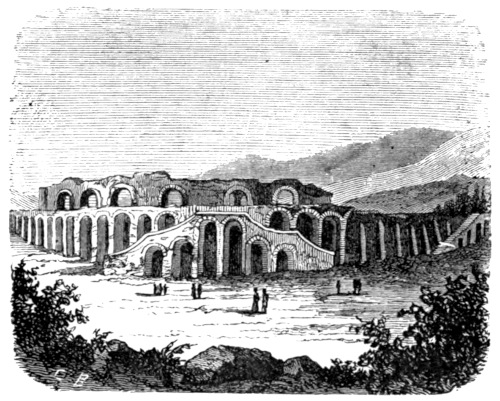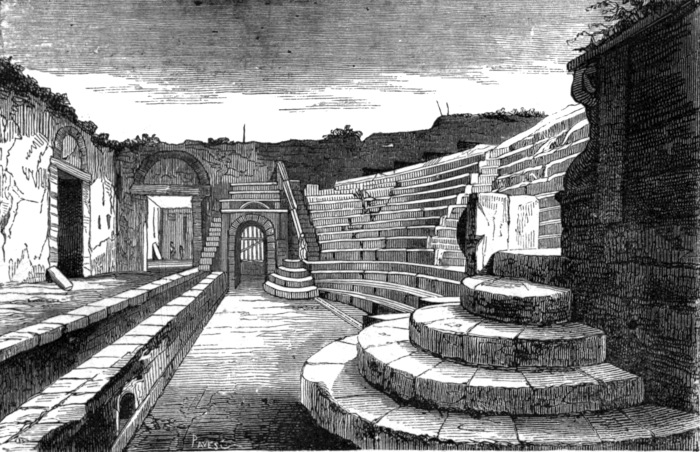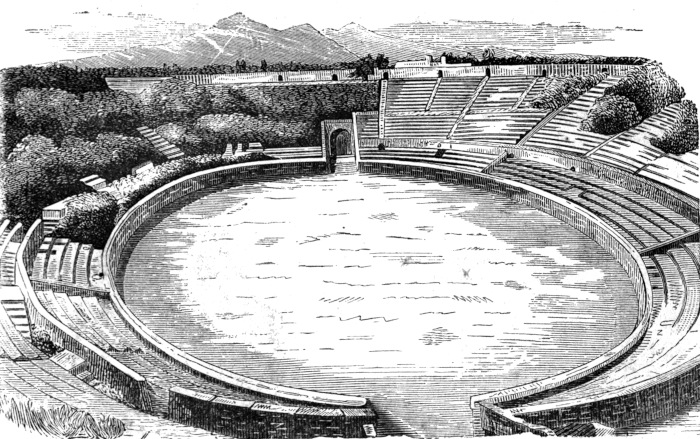POMPEI
E LE
SUE ROVINE
VOL. II
POMPEI
E LE
SUE ROVINE
PER L’AVVOCATO
PIER AMBROGIO CURTI
GIÀ DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE
DIRETTORE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ARCHEOLOGIA
E DI BELLE LETTERE DI MILANO
VOLUME SECONDO
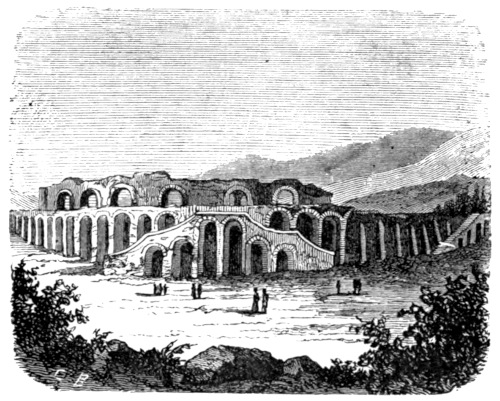
1873
MILANO — F. SANVITO, EDITORE.
NAPOLI — DETKEN E ROCHOLL.
Proprietà letteraria.
Legge 25 Giugno 1865. Tip. Guglielmini.
[5]
CAPITOLO XII.
I Teatri — Teatro Comico.
Passione degli antichi pel teatro — Cause — Istrioni — Teatro
Comico od Odeum di Pompei — Descrizione — Cavea, præcinctiones,
scalæ, vomitoria — Posti assegnati alle varie classi — Orchestra — Podii
o tribune — Scena, proscenio, pulpitum — Il
sipario — Chi tirasse il sipario — Postscenium — Capacità
dell’Odeum pompejano — Echea o vasi sonori — Tessere
d’ingresso al teatro — Origine del nome piccionaja
al luogo destinato alla plebe — Se gli spettacoli fossero
sempre gratuiti — Origine de’ teatri, teatri di legno, teatri
di pietra — Il teatro Comico latino — Origini — Sature e
Atellane — Arlecchino e Pulcinella — Rintone, Andronico ed
Ennio — Plauto e Terenzio — Giudizio contemporaneo dei
poeti comici — Diversi generi di commedia: togatæ, palliatæ,
trabeatæ, tunicatæ, tabernariæ — Le commedie di Plauto e
di Terenzio materiali di storia — Se in Pompei si recitassero
commedie greche — Mimi e Mimiambi — Le maschere,
origine e scopo — Introduzione in Roma — Pregiudizj
contro le persone da teatro — Leggi teatrali repressive — Dimostrazioni
politiche in teatro — Talia musa della Commedia.
Gran parte della vita publica erano nell’orbe romano,
massime al tempo de’ Cesari, i Teatri.
Quando si consideri che solo in questa, elegante
sì, ma piccola città di Pompei vi fossero due teatri, il
comico e il tragico ed un anfiteatro, tutti di tanta capacità,
[6]
si può avere una prova abbastanza conveniente
di questa asserzione, ed un’altra poi se ne avrà ancora
nel fatto che non si fosse paghi di uno spettacolo
solo al giorno, ma se ne volesse a tutte l’ore di
esso, e s’egli è vero quel che taluni pretesero e che
io ho pur riferito, che i Pompejani fossero stati sopraggiunti
dal loro estremo disastro nell’anfiteatro,
sappiamo allora che dovesse essere circa l’ora meridiana.
Non fu detto però a torto che il popolo non vivesse
che di pane e di spettacoli, panem et circenses, e ognun
s’avvede che qui sotto il generico nome di giuochi del
circo s’abbiano ad intendere ben anco gli scenici ludi.
Una ragione più alta aveva contribuito a radicare
profondamente nell’animo di tutti la passione e nelle
consuetudini generali la frequenza de’ teatrali spettacoli, — la
religione: — perocchè rimontandosene alle
origini si trovi, per testimonianza di Tito Livio, che
nella epidemia, onde fu Roma afflitta nel 390 di sua
fondazione, la collera celeste serbandosi inesorabile
alle continue supplicazioni, si fosse ricorso alle sceniche
rappresentazioni, in cui attori erano commedianti
etruschi, detti nella loro lingua istrioni, i quali trattavano
artifiziosamente a suon di flauto e gestendo
senza parole[1]. Fra i Romani stessi sorsero subito dopo
imitatori; i giuochi scenici attecchirono e vennero per
[7]
ciò considerati non come un semplice passatempo
soltanto, chè per tali non si ebbero che gli spettacoli
del circo, ma come una vera istituzione civile e sacerdotale.
Noi medesimi, se avessimo in oggi a restringere il
teatro in que’ confini che lo fecero definire la morale
in azione, e se la coscienza degli scrittori non
escisse dai limiti assegnati dai veri intenti dell’arte,
per libidine di facili e funesti plausi, non potremmo
ricusarci dall’averlo tuttavia per una vera istituzione
civile.
Nel desiderio di abozzare alla meglio anche questa
parte della vita romana, di cui Pompei fornisce a noi
ne’ suoi monumenti le più ineccepibili prove, converrà
che prima m’intrattenga del Teatro Comico,
detto altrimenti Odeum, nel quale poi c’intratterremo,
giusta i richiami, della sua storia, delle sue produzioni;
poscia del Teatro Tragico e della sua storia;
riserbando all’ultimo il discorso intorno all’Anfiteatro
e a’ suoi ludi; quantunque a vero dire si dovrebbe
premettere di questi ultimi, se noi pure, come gli antichi,
ritenessimo che gli spettacoli scenici non siano
che appendici meno importanti di quelli del Circo.
Fin dal 13 maggio 1769 veniva scoperta sulla muraglia
del Gran Teatro, o Teatro Tragico che si voglia
dire e del quale sarà l’argomento nel capitolo
venturo, la iscrizione seguente:
[8]
C . QVINCTVS C . F . VALG .
M . PORCIVS M . F .
DVO VIR . DEC . DECR .
THEATRVM TECTVM
FAC . LOCAR ; EIDEMQVE PROBARVNT[2].
Tale scoperta confermava la designazione, che fin
dal 23 marzo precedente era stata fatta, che quivi
esister dovesse l’Odeo, o Teatro Comico, avvalorata
altresì da ciò che contiguo vi fosse il Teatro Tragico,
pur in questo avendo i Pompejani seguito la comune
consuetudine in congenere materia, e che noi troviamo
consegnata nelle seguenti parole del capo IX,
libro V di Vitruvio: exeuntibus e theatro sinistra parte
Odeum[3].
L’Odeo, in greco Ωδεῖον, che in questo passo medesimo
ci fa sapere Vitruvio essere per la prima
volta stato eretto in Atene, ornato da Pericle di colonne,
di pietre e coperto di alberi e antenne di navi,
spoglie riportate in guerra contro de’ Persiani, vogliono
tutti che fosse stato un piccolo teatro; ove
si facessero le prove e le disfide musicali, come derivatone
l’appellativo dalla voce greca ωδή, che significa
canto.
[9]
In Pompei l’Odeum era destinato alla recitazione
delle commedie, ai concorsi poetici, alle rappresentazioni
mimiche e satiriche, e se si vuole argomentare
dall’uso generale di tali ritrovi, alle dispute filosofiche
ed anche agli spettacoli d’inverno, e per ciò
coperto; onde, per dirla con Tertulliano, l’impudico
divertimento non fosse dal rigore della stagione turbato[4].
Il severo giudizio di questo padre della
Chiesa cristiana era giustificato dalla licenziosa libertà
sempre esistita nei ludi scenici e circensi, ma
fatta ancor più sfrenata negli ultimi tempi dell’Impero.
Dal 1793 al 1796 venne questo teatro sgombro
dalle macerie, messo nelle condizioni nelle quali trovasi
di presente e in guisa da prestarsi alla sua intera
descrizione.
Esso è fabbricato, egualmente che il Teatro Tragico
e il Foro, sopra uno strato di lava vulcanica
antichissima, che porge a questi edifizj il più solido
fondamento; ma la sua costruzione è di tufo di Nocera,
all’infuori delle scale che separavano le gradinate
che son di durissima lava. Sopra l’estremità del
muro semicircolare, ossia sul cornicione, ancor si
veggono i luoghi ove stavano le colonne su cui il
tetto poggiava, il quale si apriva tra l’una e l’altra
colonna uno spazio vacuo, pel quale s’intromettevano
[10]
la luce e l’aria. Tali colonne si rinvennero rovesciate,
onde anche per la certa quantità di tegole numerizzate
con carbone e là ordinatamente disposte, si argomentò
che rovinato il teatro dal tremuoto del 63,
si ritrovasse poi nel 79 in istato di restaurazione.
Dyer crede rimonti la sua prima costruzione a poco
tempo dopo la Guerra Sociale, così forse ottant’anni
avanti Cristo.
Come di consueto, e come Vitruvio ne fa regola
generale de’ teatri, la forma della cavea è d’un emiciclo,
e sotto il nome di cavea designavasi quella porzione
dell’interno di un teatro od anfiteatro, che conteneva
i sedili sui quali stavano gli spettatori, e che
era formata da un numero di ordini concentrici di
gradini sopra più ordini di arcate, quando essi non
fossero praticati in qualche parte, od addossati a
montuosità di terreno. Secondo la dimensione dell’edificio,
questi giri di sedili erano divisi d’ordinario
in uno, due o tre scompartimenti, distinti,
separati l’uno dall’altro da un muricciolo detto præcinctio,
abbastanza alto per impedire la comunicazione
fra essi; cosicchè i diversi scompartimenti assumevano
i qualificativi di prima, seconda, terza ed
anche più spesso di ima, media e summa cavea, cioè
ordine inferiore, di mezzo e superiore. E così era
dell’Odeum pompejano.
Il pavimento per nove passi di diametro tocca l’uno e
l’altro corno dell’emiciclo terminato in due zampe
[11]
di leone di tufo vulcanico. Quindi incomincia la
prima cavea in quattro ordini di gradini più grandi
e spaziosi degli altri, ove sedevano i magistrati ed
ivi erano collocati i bisellii e le sedie curuli. Indi
seguono quattordici gradini in cui l’ordine equestre
aveva il suo posto: vi tengono poi dietro diciotto
altri ordini, ognun dei quali sempre più si va allargando
nei lati per formare il diametro dell’emiciclo
e stretto pel contrario nell’orchestra, della quale
dirò fra poco.
Dopo i primi quattro gradini si vede un parapetto
di separazione con un ripiano, o gradino più
largo. Si riconosce da ciò subito una delle precinzioni,
che i Greci chiamavano δίαζωματα, con cui,
come dissi testè, precingeva, o separava il primo dal
secondo, ordine della cavea, dove stava la gente più
distinta.
V’era poscia una seconda precinzione, che separava
la media, o seconda cavea, dall’ultima, dove sedevano
la plebe e le donne. I gradini della media cavea,
sono intersecati da sei piccole scale per linea retta
dall’alto al basso, chiamate viæ, itinera, scalæ e scalaria,
che hanno principio da sei vomitoria, o porte superiori
corrispondenti al corritojo coperto, donde arrivavasi
alla prima precinzione. Da essi entravano gli
spettatori per prendere il rispettivo posto, e da essi,
a spettacolo ultimato, uscivano.
Quelle scalarie, intersecando i gradini circolari,
[12]
costituivano cinque cunei o scomparti, ciascun dei
quali veniva poi assegnato a determinata classe di spettatori;
onde vi fosse quello de’ magistrati, quello de’ mariti,
quello de’ giovani pretestati, quello de’ conjugati,
e vie via degli efebi, oratori, legali, pedagoghi,
soldati, che giammai si confondevano colla plebe, e
le altre distinzioni del popolo, le quali venivano osservate,
da che un decreto d’Augusto, secondo lasciò
ricordato Svetonio nella vita di questo Cesare, le
avesse a prescrivere, a ciò indotto dalle ingiurie che
un senatore aveva ricevuto nel teatro di Pozzuoli.
«Egli, Augusto, scrisse quello storico, rimediò alla
confusione ed al disordine estremi che regnavano
negli spettacoli, mosso dall’ingiuria ricevuta da un
senatore, che nella occasione di celeberrimi ludi in
Pozzoli, che avevano attirato immenso concorso, non
aveva trovato posto, ordinando con un senato consulto,
che in tutte le rappresentazioni publiche il
primo ordine spettasse a’ senatori. Vietò ai deputati
delle nazioni libere e alleate di sedere nell’orchestra,
perchè avesse sorpreso che molti fra di essi fossero
del genere de’ liberti. Separò dal popolo il soldato.
Assegnò posti particolari a’ mariti, speciali gradini a
coloro che portavano ancor la pretesta, collocandone
i precettori appresso. Agli abbigliati in bruno (pullatorum)
interdisse il centro della cavea. Alle femmine,
già confuse cogli uomini, non concesse assistere che
dal posto superiore alle lotte de’ gladiatori. Destinò
[13]
alle sole Vergini Vestali un separato posto nel teatro
di contro alla tribuna del pretore»[5].
Petronio nel suo Satyricon, ci ha lasciato alla sua
volta memoria che l’ordine più alto ne’ teatri fosse
quello riserbato agli schiavi, alle cortigiane ed
all’infima plebe, in quel passo in cui Criside,
l’ancella della dissoluta Circe e mezzana de’ suoi
amori, accostando Encolpo e invitandolo da parte
della sua padrona, alla maraviglia di costui che
schiavo di Eumolpione s’era infinto e mutato il nome
in quello di Polieno, così risponde: «Quanto al dirti
schiavo ed abbietto, questo è lo stesso che accendere
il desiderio di colei che ti aspetta; perchè hannovi
alcune donne che dilettansi di sucidume, o non sentonsi
brulichio se non alla vista di schiavi, o di sergenti
ben infiancati: ad altre un mulattiere coperto
di polvere, ad altre un attore che figura su per le
scene. Insigne fra queste è la padrona mia: ella sale
dall’orchestra al quattordicesimo ordine, e in mezzo
all’ultima plebe rintraccia chi più le piace»[6].
Eravi poi l’orchestra, che occupava, rispetto al rimanente
dell’edificio, un posto corrispondente alla
platea de’ nostri teatri e consisteva in uno spazio
aperto, in piano, nel centro dell’edificio sul fondo,
circoscritto di dietro dalle più basse file de’ sedili
[14]
degli spettatori e dinanzi dal muricciuolo della scena.
Il pavimento di questa parte è di marmi greci disposti
in varii quadrati, e nel mezzo sopra una larga
fascia di marmo cipollino, che ne occupa tutto il
diametro, si legge in grandi lettere di bronzo incastonata
questa iscrizione:
M . OCVLATIVS M . F . VERVS .
VIR PRO LVDIS[7].
Dalla quale iscrizione apprendiamo il nome d’uno
de’ due sovrintendenti dei giuochi o spettacoli in Marco
Oculazio Vero.
Ai lati della scena ed al disotto de’ vomitorii o porte
che mettevano all’orchestra, sonvi due podii o tribune,
a cui si giunge per quattro gradini praticati di
dietro. Il podium in un anfiteatro o circo o teatro,
era un basamento alto circa sei metri dal suolo dell’arena
destinato ad essere occupato dall’imperatore,
da’ magistrati curuli e dalle Vestali, che sedevano
quivi sopra i loro seggi d’avorio. Svetonio e Giovenale
ne fanno menzione[8].
La scena poi, misurata da Bréton di 17.m 50,
è assai bene conservata, è formata di mattoni e di
[15]
opera reticolata di tufo rivestita di marmo bianco.
Il proscenium, o intero spazio del palco rialzato,
chiuso fra il muro permanente della scena di dietro
e l’orchestra di fronte, e che con moderno vocabolo
diremmo palcoscenico, non appare così profondo
come ne’ moderni teatri; nel mezzo di esso, in sito
più elevato, sorgeva il pulpitum, o alta e lunga predella
su cui gli attori stavano quando recitavano i
loro dialoghi, o discorsi.
Vitruvio, parlando dei pulpito, che i Greci appellano
λογεῖον, avverte essersi esso usato già ristretto
in Grecia, meno altrove, e però colà i tragici e comici
recitavan sulla scena, gli altri attori tutti nell’orchestra;
onde hanno in greco diverso nome, gli
uni di scenici, gli altri di timelici[9], forse sonatori
codesti ultimi, se decomponendo la parola, troviamo
che essa significhi sollevar l’animo annojato, dove pur
non derivi da Hymele, con che si designava l’inno di
Bacco.
In questo primo senso avrei avuto ragione anch’io,
se imitando l’esempio greco, ebbi a chiamare orchestra
il luogo che è destinato nei nostri teatri a’ suonatori.
Davanti al pulpitum, scorgasi ancora nell’ammattonato,
al posto che ne’ moderni teatri serba la ribalta
dei lumi, un incavo correre tutto lungo la scena, nel
[16]
quale stava il cilindro a cui s’avvolgeva l’Aulæa od
Aulæum, che era la tappezzeria o cortina, che faceva
le veci dell’odierno sipario, ornata di figure ricamate
su di essa, il più spesso rappresentanti storici fatti
e paesane vittorie, come raccogliesi dal seguente passo
delle Metamorfosi d’Ovidio:
Sic ubi tolluntur festis aulæa theatris,
Surgere signa solent, primumqne ostendere vultus,
Cætera paulatim; placidoque educta tenore
Tota patent, imoque pedes in margine ponunt[10].
Tal cortina veniva adoperata nei teatri greci e romani
per lo stesso uso che i nostri siparii, a fine di
nascondere il palco scenico prima del principio della
rappresentazione e negli intermezzi. Questa cortina,
scrive De Rich[11], non era però sospesa come i siparii
e non scendeva giù dall’alto; ma tutt’al contrario,
quando cominciava la rappresentazione, si lasciava
cadere la cortina entro l’incavo suddescritto,
e per conseguenza, finito l’atto, si tirava su dallo
[17]
stesso; quindi l’espressione aulæa premuntur[12] di
Orazio, cala il sipario, significa che la rappresentazione
sta per incominciare ed aulæa tolluntur di
Ovidio[13], il sipario si alza, che l’atto o la rappresentazione
è finita. Questo incavo entro cui scendeva
l’aulæum, per essere sotto il proscenium, appellavasi
con altro nome hyposcenium.
Del resto v’han di coloro che l’aulæum pretendono fosse
proprio del teatro tragico soltanto, e che la commedia
si servisse del siparium, che il succitato De Rich
definisce una scena o paravento, adoperato nei teatri, e
consistente in più spicchi, che potevano essere aperti o
ripiegati l’uno sull’altro, come si fa ne’ paraventi che
usiamo ora. Se non che Apulejo ha questo passo:
Aulæo subducto et complicatis sipariis scena disponetur[14];
e si vede così usar egli de’ due vocaboli promiscuamente;
quantunque il suo linguaggio implichi che
l’aulæum era fatto calare (subductum) sotto la scena,
quando lo spettacolo principiava, e il siparium era
invece ripiegato in su (complicatum) nello stesso momento.
Pare poi che questo ufficio di abbassare gli
aulei, o siparii, de’ teatri spettasse specialmente a’ Britanni,
[18]
cioè agli schiavi fatti nelle guerre della Britannia
e condotti, secondo il costume, a Roma, se
questi versi Virgilio pose in una sua Georgica, che
vi fanno non dubbia allusione:
Vel scena ut versis discedat frontibus, utque
Purpurea intexti tollant aulæa Britanni[15].
Finalmente le due lunghe camere dietro la scena,
di cui l’una doveva essere coperta, l’altra scoperta,
e servivano alla preparazione degli attori, si chiamava
il postscenium, o dietroscena, al quale ha tratto
Lucrezio nel suo Poema al libro IV[16].
Il teatro Comico od Odeum di Pompei era della capacità
di forse millecinquecento spettatori: quindi abbastanza
grande per tale città, pur calcolando che alle
rappresentazioni tanto sceniche che circensi traessero
molti dalle città vicine e borgate. Perocchè s’egli è vero
che il Teatro Tragico ne contenesse quasi quattro
volte di più e l’anfiteatro molte migliaja, come a suo
[19]
luogo dirò, è altresì vero che la minore importanza
degli spettacoli dell’Odeum voglia essere considerata;
vedendo noi pure oggidì anche nelle più vaste e popolose
città esservi diversi teatri, e secondo l’entità
degli spettacoli che vi si offrono, avere anche la
capacità.
Compirà la descrizione materiale di questo teatro
pompejano, quale fu rinvenuto cogli scavi, l’accennare
come presso all’ingresso siensi vedute molte
iscrizioni graffite, evidentemente da schiavi, liberti e
gladiatori, taluna recante spavalde imprese, tal altra
oscenità, di cui non giova tener conto; ove si eccettui
d’una di quest’ultimo genere publicata dal De Clarac,
che portando la data dei 13 delle calende di dicembre
dell’anno del consolato di M. Messala e L. Lentulo,
cioè l’anno 731 di Roma, prova l’esistenza dell’Odeum
a tre anni avanti Cristo, quindi più di ottant’anni
prima della catastrofe della città.
Finalmente a tutto dire di quelle particolarità che
sono attinenti al teatro antico, e che possono altresì
riuscire a noi di non dubbio interesse e studio, per
quelle applicazioni che nella costruzione di congeneri
edifizj si potrebbero fare, ricorderò che
nella parte superiore di esso dov’erano le carrucole
e gli altri congegni del velarium, del quale non ho a
dire in questo capitolo, non occorrendo di esso perchè
l’Odeo era coperto, ma me ne riserbo nel venturo,
sospendevansi specie di campane di bronzo o
[20]
di terra cotta chiamate echea, la cui apertura era
rivolta in basso verso la scena, sicchè la voce ferendone
la cavità, ne produceva il suono più chiaro
e più armonioso, come si legge in Vitruvio[17]. Queste
campane, o vasi di bronzo o di terra cotta, erano
proporzionatamente una più piccola dell’altra, acciocchè
producesse l’una il suono più acuto dell’altra,
e servivano solo, come chiaramente leggesi nel
detto autore, per aumentare le voci corrispondenti,
non per sonarsi con de’ martelli, come taluno si
è avvisato di dire.
Una particolarità che non vuol essere a questo
punto negletta, sono le tessere state ritrovate negli
scavi dell’Odeum, e le quali servivano, come ora
servono i biglietti, per avere ingresso al teatro. Esse
sono di figura circolare e di un pollice di diametro
ed è a presumersi che fossero in uso anche in tutti
gli altri di Roma ed altrove in quel tempo, per quanto
eziandio sto adesso per dire.
La dichiarazione di esse importa venga qui fatta,
perchè mi aprirà l’adito a intrattenermi più avanti
del genere delle rappresentazioni.
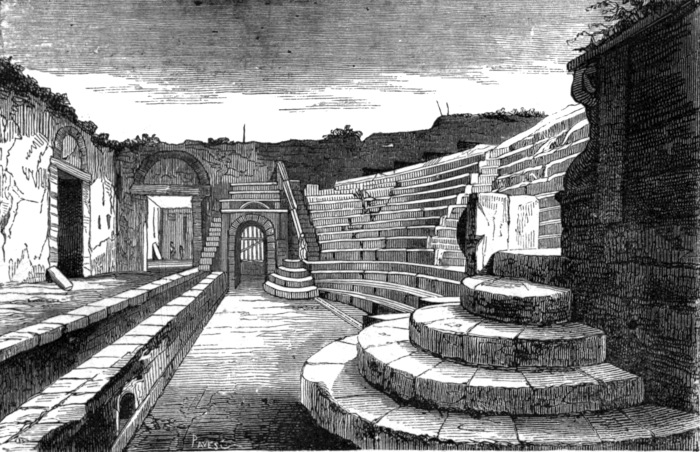
Teatro Comico od Odeum di Pompei. Vol. II, Cap. XII.
Di tre tessere si hanno esemplari, rinvenuti negli
scavi pompejani, senza tener tuttavia conto di quelle
altre a forma di mandorle o di piccioni, le quali
[21]
ultime credesi valessero per i posti destinati alla plebe;
ragione forse codesta per la quale anche oggidì a
siffatti posti si suol dare da noi il nome di piccionaja,
scambiato per sinonimo di loggione, o di quel posto
che è destinato alla plebe; o, dirò meglio, ai paganti
prezzi minori.
La prima di quelle tre tessere rappresenta da un
lato una specie di edificio e nel rovescio sono malamente
incise queste parole:
XII
AICX-YAOY
IB
che si vollero interpretare, nella supposizione che
nelle città della Campania si rappresentassero ancora
le tragedie del più antico tra i sommi tragici greci,
per XII d’Eschilo e le parole IB come la ripetizione
in greco della cifra XII.
Nella seconda è rappresentato in rilievo come una
cinta di mura con porte rozzamente indicate, e che
però si vuol indurre rappresentassero l’anfiteatro, e nel
mezzo più alta una torre o pegma, specie appunto
di torre eretta col mezzo di macchine, sulla quale
collocavansi nel circo i gladiatori combattenti. Nel
rovescio leggesi:
XI
EMIK-KAIA
IA
cioè undecimo Emiciclo: le lettere di sotto, IA, significano
in greco ancora la cifra XI. Pretendesi poi che
sia questa la tessera per lo spettacolo diurno; ma io
[22]
confesso che non so argomentarne la ragione; perochè
il dir solo che il disegno rappresenti l’anfiteatro,
non significa che dunque si accenni a spettacoli
diurni di combattimenti; mentre il fatto stesso
d’esserci rinvenuta la tessera in luogo destinato a
rappresentazioni musicali o comiche spiegherebbe
tutt’altro; e d’altronde chi oserebbe affermare con
asseveranza che un’identica tessera d’ingresso valesse
e per spettacoli diurni e per rappresentazioni notturne,
per scenici ludi e per esperimenti gladiatorj,
se pur a’ dì nostri veggiamo che un identico biglietto,
portante al bisogno emblemi musicali, o maschere
di commedia, vale promiscuamente per rappresentazioni
d’ogni genere, non escluse serate magiche od
esercizj equestri?
La terza tessera reca un’iscrizione latina più completa
delle altre, recinta da un serpe che stringendo
nella bocca l’estremità della coda forma un circolo,
e suona così:
CAV . II
CVN . III
GRAD . VIII
CASINA
PLAVTI
cioè cavea II, cuneo III, gradino VIII, La Casina di
Plauto.
Io non mi inframmetterò alla quistione agitatasi
da Giusto Lipsio, dal Casaubono, dal Bolangero, dal
Pitisco e da altri antichi, e rinvergate pur da’ moderni,
[23]
se, cioè, queste tessere rappresentassero il prezzo
d’ingresso, o il posto di favore, e se in teatro si andasse
gratuitamente o contro pagamento.
Credo che tutti possano avere ragione. — Quando
erano duumviri, edili ed altri supremi magistrati, che
all’entrare in carica, o per taluna speciale solennità
largivano spettacoli, questi naturalmente, come portava
il costume, dovevano essere gratuiti a tutti, sostenendone
la spesa chi con essi voleva solennizzare
il proprio avvenimento al potere e ingraziarsi la
plebe: quando invece venivano offerti da uno speculatore,
come in Pompei poteva essere stato Livinejo
Regolo allorchè accadde nell’anfiteatro la gravissima
contesa tra Pompejani e Nocerini, allora l’entrata
ai medesimi avrà dovuto essere certamente onerosa.
Si comprende in tal guisa come, quando fossero gratuiti
gli spettacoli, la plebe tumultuasse fin a mezzo della
notte davanti al circo od a’ teatri per occuparne i
posti, a un di presso come veggiamo accadere avanti
a’ nostri teatri all’evenienza di straordinari spettacoli
cui prendano parte celebrati artisti, e Caligola però
in Roma se ne dicesse assai disturbato, giusta quel
passo di Svetonio nella vita di quel Cesare: inquietatus
fremitu gratuita in Circo loca occupantium[18]; mentre
poi nel Pœnulus di Plauto si legge:
[24]
Servi ne obsideant, liberis ut sit locus,
Vel as pro capite dent: si id facere non queunt,
Domum abeant;[19]
lo che vuol dire che quella rappresentazione non
fosse gratuitamente data.
Descritto il Teatro Comico pompejano, che abbiam
trovato già al livello dei più celebrati di quell’epoca,
male da esso ci faremmo ad argomentare del come
fossero i primi teatri. Nondimeno mi studierò di racimolare
quelle notizie che si hanno e di restringerle
a breve dettato, a beneficio di chi le brami.
Lasciando in disparte il carro di Tespi, del quale
mi riserbo a tener parola nel capitolo vegnente, e che
segna il primo progresso dell’arte drammatica, che
dal suolo ascese in luogo più elevato per isvolgere
la sua qualunque azione, i primi teatri che questo
nome assunsero desumendolo dal vocabolo greco
Θέατρον, che significa spettacolo, erano fabbricati
di legno, alla opportunità, posticci e duravano il tempo
assegnato alla festa per cui si celebravano que’ ludi
scenici a’ quali servivano: comunque venissero dipinti,
argentati, dorati, decorati di statue, adorni d’opime
spoglie di vinti popoli. Scauro ne alzò uno in Roma
[25]
capace persino di ottantamila spettatori, ricco di
tremila statue e trecentosessanta colonne di marmo,
di vetro e di legno dorato, 479 anni avanti Gesù
Cristo.
Ma già in Grecia erasi da Temistocle assai prima
provveduto, nella 75.ª olimpiade, a sostituire al teatro
di legno di Atene, crollato circa vent’anni prima, uno
di pietra; se pure anteriori adesso non furono quelli
di Sicilia, fra cui il teatro di Segeste, le cui rovine
appajono della più vetusta antichità, e quello di
Adria, colonia degli Etruschi, eretti assai e assai più
in là de’ teatri in pietra di Roma.
Pompeo, dopo vinto Mitridate, ne fabbricò uno
stabile in Roma capace di quarantamila spettatori
con quindici ordini che salivan dall’orchestra fino
alla galleria superiore; uno, e fu quel di Marcello,
fatto fare da Augusto fra il colle Capitolino e il Tevere,
fu più vasto ancora; e Statilio Tauro ne eresse
un altro fra la porta Nevia e Celimontana: Ovidio
alluse a questi tre teatri in quel verso del libro III
De Arte:
Visite conspicuis terna theatra locis[20].
Cajo Curione volendo sorpassare i predecessori
in bizzarria, nei funerali di suo padre, costruì due
teatri semicircolari, tali che potessero girare sopra
un pernio con tutti gli spettatori; sicchè, compite le
[26]
rappresentazioni sceniche, venivano riuniti, e gli spettatori
si trovavano trasportati in un anfiteatro; ma
di questa stranezza, feconda di conseguenze maggiori
di quelle avvertite dal suo autore, tornerò a parlare
in un capitolo successivo.
L’architettura dei teatri in pietra fu suppergiù
eguale a quella che vedemmo nel teatro di Pompei:
qualche variante tuttavia si ha fra i teatri greci e i
romani, massime nell’ordinamento della scena e si
vuol dire che i teatri di Pompei si accostassero più
al fare dei primi. Dentro, erano ordinariamente scoperti,
sì che fosse mestieri agli attori di forzare ancor
più la voce, che già dovevasi emettere tutta intera
per la vastità della cavea, se, come or vedemmo, i
teatri poterono capire fino ottantamila spettatori.
Or brevemente dirò della storia del teatro comico
latino, perchè con essa si verranno a conoscere le
produzioni che avranno pur dovuto rappresentarsi
sulle scene dell’Odeo Pompejano.
E prima di tutto, delle origini, importandone l’argomento,
massime a rivendicarle a favore della Italia
nostra.
I Poeti le rinvengono alla campagna, tra i pacifici
e allegri agricoltori, e Lucrezio infatti ne fa così non
dubbia menzione:
Sæpe itaque inter se prostrati in gramine molli
Propter aquæ rivum sub ramis arboris altæ
Non magnis opibus jucunde corpore habebant,
[27]
Tum joca, tum sermo, tum dulces esse cachinni
Consuerunt, agrestis enim tum musa rigebat[21].
Virgilio alla sua volta nella seconda Georgica volea
accennare a questa allegra costumanza del villaggio;
comunque appaja le creda egli dedotte dall’Attica in
Italia, constatando singolarmente essere ciò avvenuto
all’occasione delle vendemmie ed in onore di Bacco:
Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus aris
Cœditur et veteres ineunt proscenia ludi,
Præmiaque ingentes pagos, et compita circum
Thesidæ posuere, atque inter pocula læti
Mollibus in pratis unctos saliere per utres.
Nec non Ausonia Troja gens missa, Coloni
Versibus incomptis ludunt, risuque soluto
Oraque corticibus, sumunt horrenda cavatis,
Et te Bacche vocant per carmina læta, tibique
Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu[22].
Dai quali versi si raccoglie altresì di qual modo
[28]
traessero origine le maschere, dalle corteccie d’albero,
cioè, non che dal tingersi della faccia colle
vinaccie che facevano nella vendemmia i campagnuoli;
primo cenno tuttociò alle teatrali rappresentazioni,
come Servio avverte: Primi ludi theatrales ex Liberalibus
nati sunt[24].
Nè dissimile fu l’opinione del Venosino, che di
arti vuole affatto ignaro il Lazio fin dopo l’occupazione
della Grecia, se potè dire:
Græcia capta, ferum victorem cœpit et artes
Intulit agresti Latio: sic horridus ille
Defluxit numerus Saturnius, et grave virus.
Munditiæ pepulere; sed in longum tamen ævum
Manserunt, hodieque manent vestigia ruris
Serus enim Græcis admovit acumina chartis etc.[25]
[29]
Con che per altro, in certo modo, smentisce sè stesso,
perocchè pur rammenti in questi versi che un’arte
già vi fosse in Italia sussistente. Infatti era già gran
pezza che in Sicilia esisteva: recite si facevano pur
altrove in versi saturnici, o fescennini così chiamati
da Fescennia, città dove molto erano invalse le Sature,
mescolanza di musica, recita e danza, ed anco i ludi
scenici già esistenti in Etruria e dedotti in Roma,
come superiormente riferii, fin dall’anno 380 di Roma,
provano che l’Italia non attese che Grecia le apprendesse
l’arte drammatica.
E prima ancora della importazione dell’arte greca,
sono le Atellane, così nomate da Atella, città antica
della Campania fra Capua e Napoli, favole esse, o specie
di commedie che furono del pari introdotte in Roma,
e vi ottennero largo favore sotto il nome di ludi osci,
perchè scritte in lingua osca e dagli Osci inventate.
Taluno vorrebbe perfino somigliare le atellane alle
nostre commedie a soggetto; certo, recitate da’ giovani
[30]
bennati, allettavano grandemente il popolo per
lo scherzo continuamente vivace e per la loro originalità.
Il Macco o Sannio, progenitore del nostro Zanni o
Arlecchino, era già allora in voga ed era un buffone,
raso il capo, vestito di cenci a vario colore ed anche
negli scavi di Pompei si trovò il Pulcinella, maschera
atellana, pervenuta insino a noi, ed alla quale in
Napoli è specialmente destinato pur a’ dì nostri un
teatro, quello detto di San Carlino, frequentatissimo
dal popolo e da chi ama alle facezie di lui esilararsi.
Aristotele e Solino riconobbero l’arte drammatica anch’essi
come nata in Sicilia e trasportata in Atene da
Epicarmo e Formione, ovvero dalla Magna Grecia,
ove molti Pitagorici avevano scritto commedie, e tra
essi il tarantino Rintone, che inventò una commedia
che in Roma designavasi appunto dal suo nome Rintonica.
Ma chi è dato generalmente pel più antico de’ scrittori
comici romani, che introdusse la favola teatrale, che
compose drammi con unità di azione, fu Livio Andronico,
nativo, credesi, egli pure di Taranto, schiavo e
poi fatto libero. Egli rappresentò il suo primo dramma
nell’anno 240 avanti l’era volgare, sotto il consolato
di C. Claudio e di M. Tuditano, secondo leggesi in
Cicerone. Recitando egli medesimo, perdè la voce, ed
introdusse allora a rimedio d’avere davanti a sè un
giovane, il quale cantasse i suoi versi, mentr’egli
[31]
faceva i corrispondenti gesti, vieppiù questi espressivi,
perchè non distratto dalla cura della voce; d’onde
venne poi l’uso agli istrioni di accompagnare col
gesto ciò che un altro cantava, non parlando essi che
nel dialogo.
Di tre parti si fe’ constare la commedia: dialogo,
cantico, coro. Nella prima comprendevasi l’atteggiare
di più persone, nella seconda parlava una sola, o
se ve n’era un’altra, udiva di nascosto e parlava da
sè; nella terza poi era indeterminato il numero dei
personaggi. Distinguevansi le commedie in palliatæ
o togatæ, secondo che fossero di soggetto greco o romano;
nelle prætextatæ s’introducevano persone di
grande affare, vestite della pretesta; inferiori erano
le tabernariæ e i mimi che agivano in esse. La recitazione
veniva poi sempre accompagnata dal suon
della tibia, come più avanti verrò meglio notando.
Dopo Andronico, de’ cui diciannove drammi non
sopravvivono che frammenti, venne Quinto Ennio di
Calabria, di cui son raccolti i frammenti nel Teatro
dei Latini di Levêe, quindi Tito Accio Plauto, o Maccio,
come Martino Herz vuole si legga, il quale nato 227
anni prima di Cristo, scrisse molte commedie, di cui venti
sopravvanzano, fra le quali l’Anfitrione, in cui si burla
degli Dei, l’Aulularia incompleta, il Trinummus e i
Captivi di savio e morale intreccio, non che la Casina,
che sappiamo dalla tessera, di che ho già intrattenuto
il lettore, recitata nel teatro comico di Pompei.
[32]
Ma tutti costoro trattarono soltanto soggetti greci, nè
di meglio seppe fare egualmente Publio Terenzio Africano,
che tutti i predecessori superò; comunque a
Plauto ed a Terenzio stesso si anteponesse a quei
giorni Cecilio Stazio. Delle centotto commedie che
Terenzio tradusse da Menandro, perdute in un naufragio,
non ci vennero che sei tramandate, le
quali per altro ne fanno sentir gravemente la jattura
delle naufragate per la loro purezza ed eleganza di
stile. Nondimeno l’Eunuco sembra originale, sebbene
i caratteri di Gnatone e Trasone sieno desunti dall’Adulatore
di Menandro; e tanto piacque che fu replicato
fin due volte al giorno, e guadagnò all’autore
la cospicua somma di ottomila sesterzj.
Plauto, sentenzia Cesare Cantù[26], coll’asprezza e
la facezia palesasi famigliare col vulgo, Terenzio ritrae
dalla società signorile: quello esagera l’allegria, questo
la tempora e i caratteri e le descrizioni esprime al
vivo. Orazio, che giudicando solo dall’espressione,
vilipende tutti i comici della prima maniera, chiama
grossolano Plauto e lo taccia d’aver abborracciato
per toccare più presto la mercede. Alle commedie
di Terenzio fu asserito mettesser mano i coltissimi
fra i Romani d’allora, Scipione Emiliano e Lelio:
l’un e l’altro però son troppo lontani dalla finezza
dei comici greci, vuoi nel senso, vuoi nell’esposizione.
[33]
La bagascia, il lenone, il servo che tiene il sacco
al padroncino scapestrato, il ligio parassito, il padre
avaro, il soldato millantatore, ricorrono in ciascuna
commedia di Plauto, fin coi nomi stessi, come la
maschera del vecchio nostro teatro; e si ricambiano
improperj a gola, o fanno eterni soliloquj, o rivolgonsi
agli spettatori, o scapestransi ad oscenità da
bordello. Egli stesso professa in qualche commedia
di non seguire l’attica eleganza, ma la siciliana rusticità,
come nel prologo dei Menechmi:
Atque ideo hoc argumentum græcissat, tamen
Non atticissat, verum at sicilissat[27].
Grossolano e licenzioso il frizzo, il dialogo da plebe,
verso talmente trascurato che si dubita se verso sia,
lo che per altro imputar si può anche a Terenzio,
onde vi fu chi pretese avesse scritto in prosa; tante
sono le licenze a cui bisogna ricorrere per ridurlo a
versi giambi trimetri.
Meno che pei letterati, ha lo scrivere di Plauto
importanza pei filologi che vi riscontrano idiotismi
ancor viventi sulle bocche nostre e ripudiati dagli
autori forbiti: altra prova che il parlare del vulgo
si scostasse da quello dei letterati, e forse vie più
nell’Umbria.
[34]
Meglio si splebejò Terenzio. Neppur egli poteva
produrre altre donne che cortigiane, ma le fa involate
da bambine, e consueta soluzione della commedia
è il riconoscimento loro per mezzi miracolosi:
anche all’uomo dabbene trova un luogo fra i suoi:
più corretto nella morale, men procace nel motteggio,
eletto e spontaneo nel dialogo, pittorescamente semplice
nei racconti, attraente nelle situazioni, resta
inferiore in vivezza comica e gaje fantasie; quanto
all’invenzione, e’ si scusa col dire che non è possibile
più atteggiar cosa nuova:
Quod si personis iisdem uti aliis non licet,
Qui magis licet currentes servos scribere,
Bonas matronas facere, meretrices malas,
Parasitum edacem, gloriosum militem,
Puerum supponi, falli per servum senem,
Amare, odisse, suspicari? Denique
Nullum est jam dictum quod non dictum sit prius[28].
Nè Plauto, nè Terenzio conobbero l’ammaestrare
ridendo, proponendosi unicamente di recare sollazzo
al publico.
[35]
Del resto qual giudizio si portasse de’ poeti comici,
del loro vivente, ed a chi se ne aggiudicasse la palma,
non è sì presto detto e valga a ciò persuadere quel
che ne lasciò scritto Volcazio Sedigito, vissuto sotto
gli imperatori, ne’ seguenti poco poetici versi:
Multos incertos certare hanc rem vidimus
Palmam poetæ comico cui deferant.
Eum, meo judicio, errorem dissolvam tibi,
Ut, contra si quis sentiat, nihil sentiat.
Cæcilio palmam Statio do comico;
Plautus secundus facile exsuperat ceteros:
Dein Nævius qui fervet, pretio, in tertio est:
Si erit quod quarto detur, dabitur Licinio:
Attilium post Licinium facio insequi;
In sexto sequitur hos loco Terentius
Turpilius septimum, Trabea octavum obtinet;
Nono loco esse facile facio Luscium;
Decimum addo causa antiquitatis Ennium[29].
[36]
Pare che questo critico abbia obbliato Afranio, a
meno che non essendosi accontentato di tener conto
che degli autori di commedie palliatæ, lo dimenticasse
avvertitamente, come quello che illustre fosse
sì, ma solo nelle togatæ.
Di qui vede il lettore una prima distinzione della
commedia in togata e palliata, derivante per avventura
dal valore che alle due parole veniva più comunemente
assegnato. «Palliatus, dice De Rich a questa voce,
chi porta il pallium greco, sorta di coperta di lana
di forma quadra e bislunga, fissato intorno al collo
e sulle spalle con una fibbia; quindi per induzione
vestito come un greco; giacchè gli si contrappone in
latino togatus, che vuol dire un Romano, di cui l’abito
nazionale era la toga.» Così stando, palliatæ dovrebbonsi
ritenere le commedie, come quelle di Plauto
e di Terenzio, i cui soggetti ed anzi gli originali essendo
greci, importar dovevano per necessità che gli
attori fossero abbigliati alla greca, e viceversa togatæ
quelle che avevano argomento e personaggi romani.
E così m’accade altresì di rammentare diversi altri
generi della commedia romana. — Era la condizione dei
personaggi che qualificava la favola; onde distinguevansi
eziandio le commedie in togatæ, perchè di personaggi
da toga, trabeatæ, perchè di attori fregiati della
trabea, decorazione dell’ordine equestre, tunicatæ, dalla
tonaca propria del basso popolo, e tabernariæ, cioè
da gente di bottega.
[37]
Dopo tutto, è a lamentare che le opere di Plauto
e di Terenzio sieno le sole a noi pervenute del
teatro comico de’ Latini. Esse nondimeno stanno come
non irrilevanti monumenti storici, atti a renderci
l’immagine morale della loro nazione. Nè ciò mi si
contrasti, per averci essi medesimi avvertito ne’ prologhi
delle loro commedie di non aver fatto che tradurre
i greci.
Imperocchè se Terenzio ritrasse più dilicatamente
l’atticismo de’ suoi modelli e ne fu anche un discepolo
più timido e servile; Plauto di rincontro si rese più
padrone della materia che toglieva a prestanza e la
foggiava poscia a propria fantasia. Ei poneva molto
del proprio nelle sue imitazioni. Si scorge alla vena
della sua poesia, alle irregolarità e bizzarrie stesse
com’egli si abbandoni alla propria immaginazione, e
come sia spesso originale. Puossi insomma affermare
senza essere tacciati di temerità, che sotto nomi e
costumi greci e particolarmente nel suo dialogo ed
in talune parti dell’azione delle sue commedie, egli
presenti spesso uno schizzo fedelissimo del costume
romano.
Infatti, a parte anche delle frequenti volte che già
m’avvenne in quest’opera di citarlo nel dire della
romana società e di quello che mi sarà necessità di
fare nel seguito, nulla certo di grave vi ha nell’itinerario
che il choragus, o direttore della compagnia
comica, viene a sciorinarvi nell’intermedio dei Curculio
[38]
all’atto IV Scena I. — Sono bene i quartieri di
Roma che ci fa percorrere, quando lo stesso choragus
nella I scena dell’atto III del Cartaginese, ci consiglia,
se vogliamo incontrare de’ falsarj o degli spergiuri,
di andare al comizio, nel luogo delle assemblee legislative,
politiche e giudiziarie, in cui si mercanteggiano
i suffragi dei cittadini e le deposizioni
dei testimonj. Così ci mostra i mariti libertini che
si rovinano in folli e scandalose spese presso la Basilica
e presso il tempio di Leocadia-Oppia: nella
Via Toscana ci fa fare la conoscenza di spavaldi
oziosi, e nel foro piscatorio de’ crapuloni; come sul
confine del gran foro degli uomini di credito e d’affari,
e prima del lago Curtius de’ ciarloni impertinenti
e maldicenti.
Egualmente, sia che v’introduca nelle case de’ privati,
sia che v’accompagni nelle piazze, ne’ mercati,
nelle vie, voi avrete sempre davanti gli occhi i Romani
trasvestiti, di forma che quando ei finge un’azione
contraria agli usi di Roma, ve ne avverta nel
prologo, o nel corso della scena.
E poichè nella tessera teatrale rinvenuta negli
scavi di Pompei è ricordata la Casina di Plauto,
essa pure può tornare di storico documento. L’intrigo
di questa commedia volge intorno al matrimonio
d’una giovine schiava con un uomo della medesima
condizione. Questa era cosa che allora poteva sembrar
inverosimile a spettatori romani e urtare nelle loro
[39]
idee: ebbene l’esposizione del soggetto previene
questo cattivo effetto:
Sunt hic, quos credo nunc inter se dicere;
Quæso, hercle, quid istuc est? serviles nuptiæ
Servine uxorem ducent, aut poscent sibi?
Novum attulerunt, quod sit nusquam gentium.
At ego ajo hoc fieri in Græcia et Carthagini,
Et hic in nostra terra, in Apulia.
Majoreque opera ibi serviles nuptiæ,
Quam liberales etiam curari solent[30].
Plauto è senza dubbio più geloso di conformarsi
al gusto ed alla conoscenza del publico, che di osservare
la convenienza della scena: dimentica spesso,
ed io penso lo faccia espressamente, che i suoi personaggi
son greci, perchè frequentemente ci parla
degli edili, dei questori, del pretore, nomina il Campidoglio,
la Porta Mezia ed altri luoghi celebri di
Roma. I suoi attori, quantunque vestiti del pallium,
affettano un gran disprezzo per la mollezza dei Greci;
la parola pergræcari usa spesso per significare abbandonarsi
ad orgie, mentre adula il suo publico,
lodando la romana frugalità.
[40]
Non finirei sì presto se tutte volessi in Plauto
raccogliere le costumanze, gli usi e le leggi di Roma:
solo piacemi conchiudere che una ricca sorgente di
istruzione troverà sempre colui che nelle di lui commedie
vorrà attingere e che un prezioso supplemento
può somministrare questo poeta alle indagini ed agli
scritti degli storici.
Quantunque esso morisse l’anno 570 di Roma,
nondimeno dalla summentovata tessera conosciamo
che sulle scene del teatro comico di Pompei si rappresentassero
tuttavia le di lui commedie, cioè negli
anni di Roma 832: or bene, si può egli dire con altrettanta
sicurezza, per le altre due tessere aventi lettere
greche, che veramente si rappresentassero in Pompei
drammi e tragedie greche e nel greco idioma?
Può presumersi; perchè famigliare la lingua greca
a’ più colti; come avviene a un di presso tra noi,
che abbiamo altresì rappresentazioni in lingua francese:
ma meglio ne dirò nel capitolo venturo, trattando
del teatro tragico di Pompei.
Di un genere affine alla commedia mi corre debito
ancora, a compimento del soggetto che ho tra mano,
di mentovare: di quello intendo de’ Mimi o Mimiambi
che dir si vogliano, perocchè questi nomi si scambiassero
anche per sinonimi. Ad averne una certa
idea, è bene mettere sull’avviso il lettore, acciò non
abbia a confonderli nè colla pantomima, in cui la danza
e i gesti rappresentavano soli una serie di quadri staccati,
[41]
nè coi mimi greci, piccole rappresentazioni in
verso, i cui subbietti importavan meglio del gesticolar
degli attori. I mimiambi de’ Romani, da’ quali la
danza si venne mano mano escludendo, consistevano
dapprima in burleschi atteggiamenti, in farse grossolane
e il più spesso licenziose, avanzo delle antiche
atellane, alle quali erano venute succedendo,
più gradevoli alla moltitudine che non lo fossero quelle
regolarmente imitate dal greco, e più acconcie d’altronde
ad essere rappresentate in teatri aperti ed
assai grandi, ne’ quali s’avevano perfino, siccome ho
già avvertito, ottantamila spettatori.
Scopo de’ Mimiambi era quello anzi tutto di muovere
all’allegria ed al riso, parodiando il più spesso
negli abiti, nel portamento, in determinate e spiccate
pose e in consuete e notorie frasi e maniere di dire,
personaggi celebri e popolari, cogliendoli nel loro
ridicolo, o ne’ più saglienti loro atti, o nelle viziose
locazioni e solecismi.
Gli attori di essi chiamavansi mimi, come i versi,
e mimografi i soli compositori de’ mimiambi, quando
pure non ne fossero costoro a un tempo stesso gli
attori.
Si assegna ad inventore di questo genere di rappresentazioni,
che die’ tanto nel genio del popolo romano,
Decimo Giunio Laberio, cavaliere romano, non come
attore ma come scrittore; finchè giunto a’ suoi sessant’anni,
Giulio Cesare, nell’occasione dei ludi d’ogni
[42]
maniera dati da lui per cinque giorni in Roma a festeggiare
la sua seconda dittatura, e ne’ quali superò le
pompe e le spese di quelli precedentemente offerti da
Pompeo suo rivale, come verrò a ricordare in altro
capitolo, così seppe pregarlo, che parve un comando,
egli montò sulla scena a lottar di bravura con Publio
Siro, mimo e mimografo del cui valore, percorrendola,
egli aveva già riempita l’Italia tutta.
Laberio aveva avvicinati a’ suoi Mimiambi morali
sentenze ed apoftegmi che nobilitavano lo scorretto
vezzo fin allora seguito di una soverchia licenza ne’
medesimi; onde Ovidio potesse giustamente così appuntarli
nel suo libro Dei Tristi:
Quodque libet, mimis scena licere dedit[31];
Publio Siro, che vide il merito della innovazione,
lo superò nell’egual via e di costui sono però superstiti
tuttora presso che un migliaio di massime da
disgradarne il più severo scrittore gnomico. Laonde e
Seneca se ne fe’ bello ne’ suoi filosofici scritti, e gli
educatori a que’ giorni le posero nelle mani de’ giovanetti
scolari a studiare, con miglior senno di quello
si adoperi a’ dì nostri con certi catechismi e libercoli
didattici con cui vengono ribadite la superstizione
e l’ignoranza.
È meraviglia allora più grande che, possedendo
[43]
l’Italia ripetute traduzioni di tutti i classici dell’aurea
latinità, non abbia finora avuto un volgarizzatore nel
suo idioma de’ Mimiambi di Publio Siro, mentre n’ebbe
una ghiribizzosa in greco dallo Scaligero; nè credo
però aver io fatta opera ingrata elaborandola, come
l’originale, in versi, e mandandola alla luce.
Nella lotta fra Laberio e P. Siro succennata, Cesare
aggiudicò la palma al secondo: non si sa tuttavia
se mosso da giustizia o da dispetto per avere
Laberio scagliato sanguinosi giambi al di lui indirizzo.
Nondimeno, siccome in un dignitoso prologo
che la storia ci ha conservato, con qualche altro mimiambo
appena, e che io do tradotto coi Mimiambi
di P. Siro nell’edizione che ho fatta, s’era fieramente
espresso sull’usatagli violenza di dover vecchio salire
la scena, onde ne fosse venuto, a lui cavaliere romano,
sfregio nella sua dignità, tal che i suoi pari
lo avessero poi a disdegnare; generosamente Cesare
il regalava d’un anello d’oro, e di cinquecentomila
sesterzi, che si vorrebbero eguali a lire centomila nostrali.
Nè questi due egregi soltanto andavano celebrati
come Mimografi e Mimi nell’antica Roma: altri si
ricordano, di ottima rinomanza, come Filistione Niceno,
Gneo Mattio, Lentulo, Marco Marullo e Virginio
Romano, vissuto ai tempi della catastrofe di Pompei
e ricordato con parole di miglior lode in una lettera
di Plinio il Giovane; quantunque di tutti costoro nulla
in vero ci sia rimasto.
[44]
Io ricordando questi nomi, a cagione d’onore, comunque
non l’abbia detto espressamente, ho lasciato
supporre, molto più ricordando l’ultimo mimografo,
che non breve stagione corresse fra gli uni e gli
altri; e s’anco si volesse prendere a dato di partenza
i due sommi, Laberio e Publio Siro, per giungere
insino a Virginio Romano, percorreremmo uno spazio
di oltre un secolo. Or bene, la voga de’ mimiambi
non durò sempre in tal tempo. Venne la nausea e fu
ripresa l’Atellana, per merito di Mummio, regnando
Tiberio; poi si alternarono atellane e mimi, che diventarono
entrambi la commedia dell’Impero, la
quale ritraeva il colore del suo tempo, che si andava
facendo di più in più licenzioso.
Mimi ed atellane aggiunsero anzi alla primitiva
oscenità un eccesso di licenza empia; onde si tollerarono
non solo, ma piacquero scellerati subbietti,
come Diana flagellata, Il Testamento di Giove, Gli
Amori di Cibele, I Tre Ercoli affamati, che sollevarono
giustamente l’indegnazione di Tertulliano[32].
Se di tutte le prostituzioni infami della musa comica
antica dovessi qui tener conto non la finirei
sì presto: giustizia vuol nondimeno che non le si
neghi il merito d’essere stata più d’una volta coraggiosa,
sollevando, tanto nell’atellana che nel mimiambo,
la propria voce contro la tirannide trionfante.
[45]
Poichè così ho finito di trattare de’ varj generi di
comiche composizioni, mi rimane a toccare d’una
importante particolarità del teatro antico: intendo
del costume degli attori comici di portar, recitando,
applicata al volto la maschera; onde poi dalle diverse
qualità di essa si argomentasse tuttavia ne’ fregi architettonici
ed emblemi teatrali, la indicazione della
tragedia e quella della commedia.
Se l’origine della maschera, vuolsi, come vedemmo
più sopra, derivata dal tingersi, nelle gazzarre del
contado, la faccia di mosto e dalle corteccie d’albero
ritagliate e foggiate che applicavansi i villani alla faccia,
venutasi poscia migliorando e formando d’altre più
convenienti materie; non pare che l’uso di essa venisse
subito introdotto in Roma e nelle altre parti
d’Italia; dove, al dir del Pitisco, prima di Livio Andronico
si usasse dagli attori portar cappello od
elmo, non maschera. Roscio Gallo fu il primo a servirsene,
secondo la più generale opinione, e vuolsi
ne fosse causa l’aver egli avuto gli occhi torti.
«Il fine però della maschera, scrive Francesco
De Ficoroni, non fu propriamente il coprire qualche
difetto del volto, fu piuttosto un capriccio, e il diletto
degli spettatori, che nasce dall’inganno, preso dagli
occhi; ma ben scoperto dall’intelletto nel vedere
un travisato o più terribile, o più ridicolo del suo
essere naturale. Fu anche la maggior libertà, che si
prendevano gli attori così travestiti in dire e fare
[46]
ciò che volevano. Le maschere antiche non velavano
solamente la faccia, come le nostrali, ma coprivano
una parte almeno del capo, secondo Gellio al 7, che
dice: Caput et os cooperimento persona tectum[33]. Che
se alcun vuol che la voce Persona, significhi l’abito
tutto mutato a maschera, non ripugno, purchè conceda
che significhi ancora la sola maschera del volto,
conforme il detto di Fedro, lib. 17:
Personam tragicam forte vulpes viderat,
O quanta species, inquit, cerebrum non habet»[34].
Poscia oltre che si formarono, come notai, le maschere
di pelli e d’altre materie, vennero altresì
ridotte a caricature di ridicolo o di terribile, spesso
poi foggiandole al naturale ed in sembianza de’ personaggi
che si volevano rappresentare.
Generalmente erano schiavi o liberti greci, che
per virtù di studio avevano appreso la pronunzia del
latino, quelli che davansi al recitare, e le parti di
donna erano il più delle volte sostenute dagli uomini.
Istrioni e mimi erano nel disprezzo pubblico,
[47]
poichè si tenesse infame chi per denaro fingesse affetti
e si esponesse spettacolo e mira ai possibili insulti.
I mimi però privavansi delle civili prerogative,
i censori potevano degradarli di tribù, i magistrati
farli staffilare a capriccio; un marchio impresso sul
loro capo gli escludeva da ogni magistratura e fin
dal servire nelle legioni.
Questo pregiudizio contro i comici, i mimi, i danzatori,
i cantanti e in genere gli artisti tutti da teatro,
quantunque non così spinto come in addietro, durò
fino a dì nostri; ne’ quali peraltro furon visti dalle
disonoranti tavole del palcoscenico passare artiste, per
merito di leggiadria o di loro perizia, a talami
blasonati, ed anche troppo spesso più mediocri cantanti,
attori e saltatori onorati perfino dell’abusato
nastro di cavaliere.
Ultimo tema in questo capitolo, sia la vigilanza
delle leggi e de’ magistrati sugli spettacoli teatrali.
Fin dalle XII Tavole era statuito:
Si quis populo occentessit, carmenve condisit, quod
infamiam faxit flagitiumve alteri, fuste ferito[35], e siccome
era invalso il costume di vituperare la nobiltà
dalla scena; così quella terribil legge richiamavasi
in vigore, massime dagli oppressori, come avvenne al
[48]
tempio di Silla. Vedemmo già di Nevio che per aver biasimato
i maggiorenti e massime i Metelli, venne tratto
ne’ ceppi; e Cicerone, che pur avea scritto ad Attico
che nessuno osando chiarire in iscritto il proprio
parere, nè apertamente riprovare i grandi, unica via
non fosse rimasta che il far ripetere in teatro versi
e passi che paressero alludere ai publici affari; tuttavolta,
nel Libro De Republica loda la severità delle XII
Tavole, perchè infatti il viver nostro dev’essere sottoposto
alle sentenze de’ magistrati ed alle dispute
legittime, non al capriccio de’ poeti, nè dobbiamo udir
villania, se non a patto che ci sia lecito il rispondere
e difenderci in giudizio.
Ed Orazio del pari se ne lagnava nell’epistola I,
del Libro II:
Libertasque recurrentes accepta per annos
Lusit amabiliter, donec jam sœvus apertam
In rabiem verti cœpit jocus, et per honestas
Ire domos impune minax. Doluere cruento
Dente lacessiti: fuit intactis quoque crura
Conditione super communi: quin etiam lex
Pœnaque lata, malo quæ nollet carmine quemquam
Describi. Vertere modum, formidine fustis
Ad bene dicendum, delectandumque redacti[36]
[49]
A un di presso come vedemmo accadere e lagnarsi
a dì nostri della stampa per le intemperanze di qualche
libercolo, o giornale.
Le repressioni ad ogni modo delle leggi e de’ magistrati
resero meno che in Grecia deplorevole questa
licenza teatrale.
Piuttosto si valse del teatro la coscienza pubblica
per proprie manifestazioni, che altrimenti non le sarebbero
state concesse all’indirizzo di grandi oppressori.
Ne’ giuochi Apollinari, a cagion d’esempio
avendo Difilo recitato questi versi:
Nostra miseria tu es magnus....
Tandem virtutem istam veniet tempus cum graviter gemes....
Si neque lusus, neque mores cogunt[37],
[50]
gli applausi del popolo non ebbero più modo, chè
pretese vedere in essi fatta allusione a Pompeo, e
Cicerone attesta che se ne volle pur migliaja di volte
la replica: millies coactus est dicere[38].
Nè all’indirizzo di Cesare mancò il succitato mimografo
Laberio di frizzare. Nella gara con P. Siro,
egli esclama ad un tratto:
Porro, Quirites, libertatem perdimus[39],
e poco dopo:
Necesse est multos timeat quem multi timent[40].
Cicerone invece richiamato in patria, s’ebbe così
da Esopo tragico il benvenuto, recitando il Telamone
di Azzio: Quid enim? Qui rempublicam certo animo
adjuverit, statuerit cum Argivis..... re dubia nec
dubitari vitam offerre, nec capiti pepercerit.... summum
animum summo in bello.... summo ingenio præditum....
o pater!... hæc omnia vidi inflammari.... O ingratifici
Argivi, inanes Graji, immemores beneficii!... Exulare
sinitis, sinitis pelli, pulsum patimini[41].
[51]
Sotto Nerone, un attore dovendo pronunziare:
Addio, padre mio; mia madre, addio, accompagnò il
primo coll’atto del bere, il secondo coll’atto del nuotare,
per alludere al genere di morte dei genitori di
Nerone. Poi in un’atellana, proferendo L’Orco vi tira
pei piedi (Orcus vobis ducit pedes), voltavasi verso i
senatori.
Si pensava con Orazio essere lecito dire scherzando
la verità: ridendo dicere verum quid vetat? — Ma
nondimeno tutte le verità non si possono pur
troppo dire.
Del resto attribuivasi, fin dalle origini, principale
scopo alla commedia la censura del vizio, e la Musa
Talia, che dai Greci e dai Romani si volle far presiedere
ad essa, così di sè medesima si fa in un
epigramma dell’Antologia a parlare:
Κωμιχὸν ἀμφιέπω Θαλὶη μέλος, ἔργα δε φωτῶν
Οὺχ σίων θυμελησι φιλοκροτάλοισιν αθύρω[42].
Questa allegra Musa veniva rappresentata con una
maschera comica alla mano e in caricatura, con un
bastone pastorale e della corona d’erica recinta le
tempia. Questa corona conviene a Talia, comunque
consacrata d’ordinario a Bacco, divinità tutelare delle
rappresentazioni teatrali, perchè nata la Commedia
[52]
fra le gioje della vendemmia, e le convenga perchè
ella fosse che in siffatta occasione avesse a istituire
questo genere di spettacolo.
Il ricurvo bastone, — attributo di Talia, che si faceva
presiedere altresì ai lavori campestri, e d’ogni coltura,
giusta il valor del suo nome che significa Fiorita,
onde Virgilio cantò nell’Egloga X:
Nostra nec erubuit silvas habitare Thalia[43],
— era particolarmente adoperato dagli antichi attori,
come gli scrittori intorno alle pitture d’Ercolano
hanno provato[44].
Una Musa era sempre l’ispiratrice degli antichi
poeti, e le Muse eran sempre da essi invocate; e se
Esiodo potè chiamar Calliope la più degna delle
nove muse e colei che accompagna i re rispettabili; non
può negarsi a Talia ch’essa invece sia la più gradita
per chi cerchi conforti e gioje e l’obblio delle angoscie
di quaggiù.
[53]
CAPITOLO XIII.
I Teatri — Teatro Tragico.
Origini del teatro tragico — Tespi ed Eraclide Pontico — Etimologia
di tragedia e ragioni del nome — Caratteri — Epigene,
Eschilo e Cherillo — Della maschera tragica — L’attor tragico
Polo — Venticinque specie di maschere — Maschere
trovate in Pompei — Palla o Syrma — Coturno — Istrioni — Accompagnamento
musicale — Le tibie e i tibicini — Melpomene,
musa della Tragedia — Il teatro tragico in
Pompei — L’architetto Martorio Primo — Invenzione del
velario — Biasimata in Roma — Ricchissimi velarii di Cesare
e di Nerone — Sparsiones o pioggie artificiali in teatro — Adacquamento
delle vie — Le lacernæ, o mantelli da teatro — Descrizione
del Teatro Tragico — Gli Olconj — Thimele — Aulæum — La
Porta regia e le porte hospitalia della scena — Tragici
latini: Andronico, Pacuvio, Accio, Nevio, Cassio
Severo, Varo, Turanno Graccula, Asinio Pollione — Ovidio
tragico — Vario, Lucio Anneo Seneca, Mecenate — Perchè
Roma non abbia avuto tragedie — Tragedie greche in Pompei — Tessera
teatrale — Attori e Attrici — Batillo, Pilade,
Esopo e Roscio — Dionisia — Stipendj esorbitanti — Un
manicaretto di perle — Applausi e fischi — La claque, la
clique e la Consorteria — Il suggeritore — Se l’Odeo di
Pompei fosse attinenza del Gran Teatro.
Le origini del Teatro Tragico, facile è argomentarlo,
sono comuni con quelle del Teatro Comico: i
due generi si vennero solo col progresso di tempo
separando, divisione poi compiutamente operata allorquando
[54]
il trovato de’ scenici ludi si sollevò all’onore
dell’arte, mercè le composizioni de’ poeti che
si vennero sul teatro rappresentando.
Tuttavia per taluni assegnare si vuole speciale carattere
agli incunaboli della tragedia, e se a’ principj
della commedia satirica si prestarono i cavalletti di
Susarione, il primo arringo a quelli della Tragedia
si pretese riconoscerlo nell’Attica, nel carro di Tespi,
forse quello stesso carro, che i medesimi abitatori
della campagna valevansi ne’ giorni della vendemmia
a portar uve e vasi vinarj.
La vecchia tradizione è consacrata ne’ seguenti
versi del libro, o epistola De Arte Poetica di Orazio,
indirizzata a’ Pisoni:
Ignotum tragicæ genus invenisse Camœnæ
Dicitur et plaustris vexisse poemata Thespis;
Quæ canerent agerentque peruncti fœcibus ora[45].
Tespi era poeta dell’Attica, non dell’Icaria, come
altri sostiene; quando pure egli non sia che un pseudonimo,
sotto il quale Eraclide di Ponto[46], al riferire
[55]
di Aristofane, fece comparire diversi suoi componimenti.
Tespi visse nella 51.ª Olimpiade, vale a dire
534 anni prima dell’Era Volgare, ai tempi di Solone;
e vuolsi infatti che fosse il primo degli ultimi
suoi drammi — de’ quali però non si ha pur un
frammento superstite, e che andava di villaggio in
villaggio rappresentando — che gittasse le fondamenta
del Teatro Tragico.
D’onde il nome, variano, come per tutte le antiche
e più celebrate cose, gli etimologisti. Lo dicono i più
venuto dalle due voci greche τράγος, capro, e ὠδῄ,
cauto, perchè colui che nella tragedia avesse vinto,
conseguisse in premio un capro, che poi il vincitore
sagrificava a Bacco, come lo stesso Orazio ricordò
nella succitata Arte Poetica in questo esametro:
Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum[47].
Altri al contrario, tenendo conto del tingersi che
gli attori facevano del volto col mosto o feccia, la
quale in greco è detta τρυζ, e nel dorico dialetto
τραξ, γὸς, fanno originato da tal pristino costume
il nome a questo genere di composizione.
[56]
A differenza della commedia, che assai spesso da
seri, torbidi a complicati eventi trae principio e si
chiude poi con lieto e tranquillo esito: la tragedia
ha tutto luttuoso il subbietto e tristissima catastrofe
per fine. Laonde Ovidio, personificandola, la fa camminare
violenta, a grandi passi, colla fronte torva
per la scomposta chioma e col cascante peplo:
Venti et ingenti violenta Tragœdia passu:
Fronte comæ torva, palla jacebat humi[48].
Differenzia altresì la Tragedia nella natura e qualità
de’ personaggi; spesso ridicoli, del popolo, o di servil
condizione quelli della commedia: la tragedia li richiede
invece gravissimi, re, principi e tali da versar nelle
corti, come il più spesso i subbietti svolgonsi infatti
nelle reggie, o nelle aule dei grandi, trattandovisi
calamità, delitti e luttuosi fatti.
Dopo di Tespi, al quale il Lambino, nel commento
d’Orazio, afferma che sianvi di coloro che
credono anteporre Epigene come inventor del teatro
ed anzi esservi chi prima di lui pretenda che
fossero sedici altri a precederlo in simil genere di
ludi; Orazio indica essere stato Eschilo ad avantaggiar
la tragedia prestandole la maschera, il peplo,
il coturno, a valersi della scena ed a far uso di più
perfetta parola:
[57]
Post hunc, personæ, pallæque repertor honestæ
Æschilus, et modicis instravit pulpita tignis
Et docuit magnumque loqui, nitique cothurno[49].
Aristotele non dà ad Eschilo questo vanto, dicendo
ignorarsene l’inventore: Quis autem, scrive egli, personas
introduxerit, vel prologos, vel multitudinem actorum
et alia hujusmodi, ignoratur[50]. Suida ed Ateneo
lo concedono, in quanto alla maschera, al poeta Cherillo,
contemporaneo di Tespi.
Vedemmo già delle maschere nel capitolo antecedente
e notai la diversità della maschera della commedia
da quella della tragedia: or mi piace d’aggiungere
nell’argomento maggiori particolarità per
quella speciale importanza che nella tragedia la maschera
vi aveva.
Il volto, sotto del quale presentavasi sul teatro
l’attore, era sempre corrispondente alla parte ch’ei
sosteneva, nè si vedeva giammai un commediante
rappresentare la parte d’un uomo dabbene colla
fisonomia d’un briccone. — I compositori, scrive
Quintiliano, allorchè pongono sul teatro un loro
[58]
componimento, sanno dalle maschere trarre eziandio
il patetico. Nelle tragedie, Niobe appare con riso melanconico,
e Medea coll’aria atroce della sua fisonomia,
ci annuncia il suo carattere. Sulla maschera d’Ercole
sono dipinte e la forza e la fierezza. La maschera
di Ajace mostra il sembiante di un uomo fuor di
sè stesso. Per mezzo della maschera si distingue il
vecchio austero dall’indulgente, i giovani saggi dai
dissoluti, una giovinetta da una matrona. Se il padre
i cui interessi formano lo scopo principale della
commedia, deve essere ora contento, ora disgustato,
mostra aggrottato l’uno de’ sopraccigli della sua maschera,
oppur l’altro abbassato, ed è attentissimo nel
volgere agli spettatori quel lato della sua maschera
che più si addice alla sua situazione. Si può quindi
congetturare, che il commediante il quale portava
quella maschera, si volgesse ora da una parte, ora
dall’altra, onde mostrar sempre il lato del viso che
era alla propria situazione più conveniente, allorchè
rappresentavansi le scene in cui egli doveva cangiar
d’affetto, senza poter cambiare di maschera in iscena.
Se quel padre, a cagion d’esempio, compariva lieto
sulla scena, presentava il lato della sua maschera, il
cui sopracciglio era abbassato; e allorquando gli
avveniva di cangiar d’affetto, camminava sul palco e
con tanta maestria, che presentava in un istante allo
spettatore il lato della maschera col sopracciglio aggrottato,
avendo cura, tanto nell’una, come nell’altra
situazione, di volgersi sempre di profilo.
[59]
Giulio Polluce, parlando delle maschere di carattere,
dice che quella del vegliardo il quale sostiene
la prima parte nella commedia deve essere afflitta
da una parte e serena dall’altra e trattando delle
maschere delle tragedie, le quali debbon essere adattate
al carattere, dice altresì che quella di Tamiri,
quel rinomato temerario il quale fu reso cieco dalle
Muse per avere osato di sfidarle, doveva avere un
occhio cilestro e l’altro nero.
Le maschere permettevano inoltre agli uomini di
rappresentare le parti di donna, le quali esigendo,
per l’ordinaria vastità dei teatri e, per sopraggiunta,
scoperti, non altrimenti che i circhi, robustezza di
voce, mal vi avrebbero veraci donne sopperito. Aulo
Gellio racconta infatti un aneddoto dell’attor tragico
Polo, cui nella tragedia di Sofocle venne affidata la
parte di Elettra e ricorda come nella situazione in
cui Elettra doveva comparire tenendo in mano l’urna
ov’ella crede raccolte le ceneri del fratello Oreste, vi
venisse stringendo al petto l’urna in cui erano veramente
rinchiuse le ceneri di un fanciullo che egli
aveva da poco tempo perduto; e che nel volgere,
come voleva l’azione, le sue parole all’urna, sommamente
si intenerì, non minore emozione destando
nell’uditorio.
La necessità della maschera, per la suavvertita
ragione della vastità dei teatri, è constatata dall’autorità
di Prudenzio: «Quelli che recitano, dice questo
[60]
scrittore, nelle tragedie, si coprono il capo d’una
maschera di legno e per mezzo dell’apertura fattavi
fanno sentir da lungi la loro declamazione.»
Servivano da ultimo le maschere a rendere più formidabile
l’aspetto dell’attor tragico, ciò che era uno
degli studj più accurati nell’antica tragedia; onde
Giovenale nella Satira terza:
Ipsa dierum
Festorum herboso colitur si quando theatro
Majestas tandemque redit ad pulpita notum
Exodium, cum personæ pallentis hiatum
In gremio matris formidat rusticus infans[51].
Di venticinque specie almeno si contavano le maschere
della tragedia: sei di vecchi, sette di giovani,
nove di donne e tre di schiavi, distinte tutte da una
peculiare diversità di lineamenti, di colore, di capellatura
e barba.
[61]
Eravi poi la persona muta, sorta di maschera portata
dall’attore, che, pur figurando nel dramma, non
parlava mai, come le comparse del teatro moderno.
Questa maschera aveva dunque la bocca chiusa e
non aveva espressione al pari delle altre.
Tanto negli scavi di Pompei che in quelli di Ercolano,
si rinvennero nelle pitture esempi di personæ,
o maschere tanto comiche, che tragiche, e che di
semplici comparse e rispondono perfettamente a quei
cenni che son venuto adesso fornendo.
Ho accennato più sopra che la maschera aggiungeva
altresì valore alla voce: infatti essa la rendeva
più sonora, quasi raccogliendola nell’emissione, come
faremmo noi al bisogno di più grande clamore, che
portiamo le mani intorno alla bocca. Un attore tragico
domandava una forte e tonante voce, perchè
dice Apulejo, il commediante recita e l’attor tragico
grida a tutta possa. Nè diversamente intese dire Cicerone,
quando nella enumerazione delle doti necessarie
all’oratore, chiede ch’egli abbia la voce d’attor
tragico: In oratore autem acumen dialecticorum, sententiæ
philosophorum, verba prope poetarum, memoria
juriconsultorum, vox tragœdorum, gestus pene summorum
actorum est requirendus[53]. — Vedrà facilmente
[62]
il lettore quanta modificazione avesse in progresso,
e massime a’ tempi nostri codesto requisito; il quale
or vuolsi risponda alla vera naturalezza.
Seconda invenzione di Eschilo, al dire di Orazio,
fu la palla, o con più proprio vocabolo greco, pur
serbato dai Romani, la sirma, Συρμα, ed era la tunica
che l’attor tragico portava lunga sino ai talloni,
sostenendo le parti di personaggi eroici o divini.
Era essa intesa a dare grandezza e dignità alla persona,
e nascondeva la sconveniente apparenza dello
stivale tragico, cothurnus, ad alta suola. Giovenale vi
accenna nella Satira VIII, quando così apostrofa
Nerone:
Hæc opera atque hæ sunt generosi principis artes,
Gaudentis fœdo peregrina ad pulpita saltu
Prostitui, Graiægue apium meruisse coronæ.
Majorum effigies habeant insignia vocis:
Ante pedes Domiti longum tu pone Thiestæ
Syrma vel Antigones, seu personam Menalippes,
Et de marmoreo citharam suspende colosso[54].
[63]
Questo coturno poi era uno stivale portato dagli
attori tragici sulle scene, il quale aveva una suola di
sughero alta parecchi pollici, all’intento di far comparire,
egualmente che la sirma, più grande la
loro statura ed aggiungere loro un più imponente
aspetto. Da siffatta consuetudine originò la frase
sumere cothurnum, calzare il coturno, per indicare tanto
l’attore tragico, che il poeta che componeva tragedie.
Questa promiscuità d’indicazione fu motivata allora,
come fino a’ tempi moderni, da ciò che più spesso
il poeta era anche l’attore. Già, pur allora, ne accennai
implicitamente nel parlare di Livio Andronico;
come dei tempi moderni può recarsene ad esempio
Shakespeare.
L’uso del coturno nella recitazione della tragedia
vuolsi generalmente introdotto da quell’altro sommo
poeta tragico greco che fu Sofocle; onde scambiasi,
per metonimia, fin nel linguaggio d’oggidì, coturno
sofocleo bene spesso par tragica composizione.
Virgilio l’usò in un’egloga ad esprimere la severità
o sublimità dello stile, parlando de’ versi di Cornelio
Gallo, al quale quel componimento è diretto:
Sola Sophocleo tua carmina digna cothurno[56].
[64]
Nè la dignità maggiore dell’attor tragico, poteva
tuttavia differenziarlo, nella designazione, dalla classe
dell’attor comico. Entrambi detti istrioni, histriones,
parola derivata dagli Etruschi, che l’adoperavano a
significare un attore pantomimico ed un ballerino
sulla scena, come ne fa fede l’autorità di Tito
Livio[57]. — I Romani accolsero la voce, ma ne
estesero il significato, con tal nome designando qualunque
attore drammatico, che recitasse il dialogo
del dramma con gesto appropriato, e quindi l’attor
tragico come l’attor comico.
Plinio infatti chiamò M. Ofilio Hilaro istrione di
commedie[58], come Esopo istrione di tragedie[59]. Non
fu del resto che più tardi che si usò del nome stesso
ad indicar uomo vanaglorioso e spavaldo ed anche il
vil cerretano.
E fu ciò tanto vero, che Macrobio, a dimostrare
come gl’istrioni fossero anzi stimati, cita l’amicizia
intima di Cicerone con Esopo e con Roscio
istrioni: la dilezione avuta da Lucio Silla per quest’ultimo,
così che, dittatore, il regalasse di anello
d’oro: il fatto che ad Appio Claudio, uomo trionfale,
fosse attribuito ad onore fra’ colleghi di saper ottimamente
danzare: pro gloria obtinuerit, quod inter
[65]
collegas optime saltitabat e chi tra nobilissimi cittadini,
Gabinio uom consolare, M. Celio e Licinio Crasso si recassero
a sommo di onore non solo lo studio, ma la
perizia nella danza[60]. Io piuttosto dirò che i ludi
e le ludiæ recitando e danzando sulle pubbliche vie
fossero nel generale disprezzo, come lo sono tra noi
i saltimbanchi e suonatori di strada.
Ovidio è di questa sorta di ludi che parla nel Lib. I.
Artis amatoriæ:
Dum quæ, rudem prœbente modum tibicine Thusco,
Ludius æquatam ter pede pulsat humum[61]
Fin da’ loro primordii, tanto la commedia che la
tragedia ebbero, nella loro recitazione, accompagnamento
di musica, volendosi con questa sostenere la
voce degli attori e massime del coro, che figurava
impreteribilmente nelle tragiche composizioni, secondo
ne ammonisce in questi versi Orazio:
Tibia non, ut nunc, orichalco vincta, tubæque
Æmula, sed tenuis simplexque foramine pauco
Aspirare et adesse choris erat utilis, atque
Nondum spissa nimis complere sedilia flatu[62].
[66]
Gli istrumenti erano le tibie, le quali apprendiamo
dalle notizie che si leggono in molte edizioni
in fronte alle commedie di Terenzio, che fossero di
più specie.
Erano esse fatte di canna, di bosso, di corno, di metallo,
o stinco di alcuni uccelli e animali, d’onde il
nome ebbe origine. Alcune erano simili al moderno
zufolo, altre al flauto, altre eran curve, altre s’accoppiavano
ed eran pari, altre impari, ambe suonate
ad un tempo da un medesimo suonatore, altre dicevansi
destre ed altre sinistre, a seconda dovevansi
tenere da una mano o dall’altra, e le prime producevano
le note gravi e basse, le seconde ottenevano
le acute.
L’Ecira di Terenzio, a mo’ d’esempio, fu accompagnata
da due tibie pari: modos fecit Flaccus Claudi
tibiis paribus[63]: il Formione dello stesso dalle tibie
impari o disuguali: modos fecit Flaccus Gaudi tibiis
imparibus; l’Andria con doppio pajo di tibie; gli
Adelfi dalle tibie dette Sarranæ, che erano dell’egual
lunghezza e diametro interno, come le pari, in guisa
che tutte e due si trovassero alla medesima altezza di
suono. Così dicasi delle altre commedie di lui, in
molte edizioni delle quali leggesi, come dissi, in
fronte alle stesse la nota: Acta tibiis dextris, vel sinistris,
paribus vel imparibus.
[67]
I musici che suonavano le tibie nel teatro e che
venivano altresì adoperati nelle feste e solennità religiose
e ne’ funerali, chiamavansi Tibicines, e in Roma
costituivano, come ne fa fede Valerio Massimo, una
speciale corporazione. — Una pittura pompejana ci
rappresenta un tibicen, seduto sul thymele nell’orchestra
in atto di battere il tempo col suo piede sinistro
e coperto dalla lunga veste.
Nè ufficio di tibicini era solo accompagnare del
loro suono gli attori ed il coro durante la rappresentazione,
ma ben anco di suonar negli intermezzi
e fra gli atti, come usasi modernamente e come
Plauto, chiudendo il primo atto del Pseudolus, informa
con queste parole: Tibicen vos interea hic delectaverit[64]:
ma già fin d’allora avvertivasi da molti
alla inconvenienza di turbare con suoni le scene più
interessanti e poetiche della tragedia, se Cicerone
colla finezza della sua ironia avesse a scrivere: Non
intelligo quid metuat cum tam bonos septenarios fundat
ad tibiam[65].
E in Grecia e in Italia, preponendosi, per gentile
e religiosa costumanza, alle scienze e alle arti quelle
amabili divinità che sono le Muse; se Talia, come
abbiamo veduto, era musa assegnata alla Commedia,
Melpomene fu la musa della Tragedia.
[68]
Indarno lo scoliaste d’Apollonio e quello dell’Antologia[66]
pretesero a questa Musa attribuir l’ode,
forse a ciò indotti dal valore del suo nome, che significa
cantante, senza riflettere che questo nome
meglio convenga alla musica, che, come testè ho
esposto, usavasi dagli antichi durante l’azione tragica
teatrale; perocchè la maggior parte degli scrittori
e poeti, greci e latini, s’accordino nel dire Melpomene
la Musa della Tragedia e tra gli altri Petronio
Afranio nell’Elogio delle Muse lo affermi
chiaramente:
Melpomene reboans tragicis fervescit iambis[67];
e Le Pitture d’Ercolano portano scritto ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ, Melpomene tragœdiam.
Il vestimento, che si assegna ordinariamente a questa
Musa severa, è una tunica lunga, appellata talaris,
le cui maniche giungono a’ polsi, al di sopra di essa
un peplum o tunica più corta, e da ultimo la syrma
teatrale, col pugnale e la maschera tragica alla mano,
calzata del coturno, austera nella figura ed ombreggiata
da’ capelli la fronte, fronte comæ torva, come
ebbe a cantare Ovidio, che ho già citato.
Venendo ora alla materialità o forma e disposizione
[69]
delle parti architettoniche di un teatro tragico,
non potrei che riferirmi a quanto mi accadde di dire
nel capitolo precedente, perocchè teatro comico e
teatro tragico si somigliassero quasi in tutto. Le differenze
ho già del pari notate, e son minime; l’Odeum
più spesso, il qual era d’origine greca, soleva esser
coperto. Laonde vengo difilato al Teatro Tragico pompejano.
Anche quella descrizione che particolarmente ho
fatta del teatro Comico, mi abbrevia il còmpito
della descrizione del gran Teatro, o Teatro Tragico
di Pompei; perocchè suppergiù si avrebbero a dire
le medesime cose, da che e la distribuzione delle
parti e l’ordinamento e i locali si rassomiglino, come
anche molto simili gli scopi.
Non noterò adunque che quelle specialità che lo
differenziano, a scanso d’inutili ripetizioni, non lasciando
anzi tutto di prender atto del nome del suo
architetto, quale ci fu tramandato da un’iscrizione
ch’era in una muraglia attinente al teatro ed oggi
trasferita al Museo Nazionale e che suona così:
MARTORIUS M . L . PRIMUS ARCHITECTUS[68].
Il teatro Tragico era situato sul declivio di una
collina, sulla sommità della quale si trova il lungo
e vasto portico accommodato a ricevere gli spettatori
in caso di pioggia, potendo all’uopo anche servire
[70]
di passeggio, e di lizza per gli esercizi ginnastici.
A differenza del Comico, era esso scoperto al pari
dell’anfiteatro e della più parte dei teatri d’allora,
massime di Roma; onde notai come particolarità
quella dell’Odeum pompejano d’essere stato coperto,
riferendo anzi a prova l’iscrizione che l’attesta, ma
che d’altronde non può dirsi che fosse l’unico nella
Campania, avvertendoci Stazio che pur in Napoli, dei
due teatri, l’uno fosse coperto e l’altro no, in quel
verso:
Et geminam molem nudi, tectique theatri[69].
Non è però che il Teatro Tragico esponesse così
gli spettatori all’incommodo, non lieve in quella
parte d’Italia, in cui l’estate è precoce, de’ vivi
raggi del sole; avvegnachè si fosse presto ricorso
alla invenzione di un mezzo per ovviare al grave inconveniente,
nel velarium, che vi veniva disteso al
disopra; lo che praticar solevasi anche ne’ giuochi
dell’anfiteatro, come a suo luogo vedremo, riportando
anzi, come farò, il tenore di alcuni affissi che annunziando
al popolo gli spettacoli, lo avvisavano, a maggior
eccitamento di concorso, che sarebbe tirato sull’anfiteatro
il velario.
Nei teatri della Campania, prima che altrove e
per conseguenza pur in questo di Pompei consacrato
[71]
alla tragedia, secondo la testimonianza di Plinio,
venne introdotto l’uso del velarium a coprir il teatro
e difendere per tal modo gli spettatori dagli ardori
del sole; e come che esso richiedesse servizio di
cordami e si componesse di tele quali si usavano
per le vele de’ navigli, e che anzi se ne conservasse
perciò loro il nome, così a distenderlo servivansi
d’ordinario di marinaj.
Questa commodità, che avrebbe dovuto essere come
salutare universalmente accolta, venne invece biasimata
in Roma, chiamandola effeminatezza campana, quando
Quinto Catulo ve l’importò, siccome leggiamo in Valerio
Massimo: Quintus Catulus imitatus lasciviam primus
spectantium concessum velorum umbraculis texit[70],
e quello stupido mostro di Caligola, al dir di Svetonio,
recavasi a diletto di far ritirare improvvisamente
il velario e costringere gli spettatori a rimanere a
capo scoperto esposti alla più cocente sferza canicolare[71].
Ma se nella Campania s’era ritrovato questo eccellente,
quantunque calunniato, espediente contro la
sferza canicolare, sappiam però da Marziale, che assai
spesso esso tornasse inutile affatto in Roma al
[72]
teatro di Pompeo, per l’imperversare del vento. Ma
se così in Roma, che sarà stato allora in Pompei?
Sedendo la città in riva al mare, era più che mai
esposta alla furia di esso. Il Poeta che protestava,
nell’epigramma dal titolo Causia, cioè il cappellino
usato nel teatro di Pompeo, ch’ei conserverebbe il
suo cappello in testa:
In Pompejano tectus spectabo theatro
Nam populo ventus vela negare solet[72],
senza volerlo, ci lasciò ricordato che a’ quei giorni
anche in teatri scoperti fosse della buona creanza lo
starsene a capo nudo.
Giulio Cesare spinse la propria prodigalità fino al
punto di volere in una festa magnifica data al popolo
romano, che disteso fosse il velario di seta sull’anfiteatro
e si sa che la seta si vendesse allora a
peso d’oro. Anche Nerone ordinò un velario di porpora,
i cui ricami d’oro rappresentavano il carro del
Sole, circondato dalla Luna e dalle Stelle.
Pare del resto che un certo lusso fosse entrato poi
sempre ne’ teatrali velarj, nè più si componessero,
come nelle origini, di semplici e grezze tele di navi,
se Lucrezio, nel suo poema De Rerum Natura, ingegnosamente
descrive a lungo il giuoco dell’ombra
[73]
colorata prodotta dai variopinti velarj, così che non
mi so trattenere dal qui riferirne il brano ch’io dispicco
al IV libro:
Nam certe iaci, atque emergere multa videmus
Non solum ex alto, penitusque, ut diximus ante;
Verum de summis ipsum quoque sæpe colorem:
Et vulgo faciunt id lutea, russaque vela,
Et ferrugina, cum magnis intenta Theatris,
Per malos volgata, trabeisque, trementia flutant.
Namque ibi consessum caveæ subter, et omnem
Scenæ speciem, Patrum, Matrumque, Deorumque
Inficiunt; coguntque suo fluitare colore:
Et quanto circum mage sunt inclusa Theatri
Mœnia tam magis hæc intus perfusa lepore
Omnia conrident, conrepta luce diei[73].
Nè, a temprare l’ardore della stagione, usavasi nel
teatro tragico di Pompei del velario soltanto: ma
ben anco d’altro curioso trovato, che scaltrirà il lettore
del quanto fossero innanzi i nostri maggiori
negli artifizj dilicati.
[74]
Nella parte superiore del teatro, oltre l’emiciclo,
evvi una specie di torre che figura tonda nel teatro
e quadra al di fuori, in cui stava un serbatojo d’acqua
derivata dal Sarno, che serviva ad inaffiare e rinfrescare
teatro e spettatori, facendola scendere in minutissima
pioggerella, o spruzzaglia, a mo’ di rugiada.
Stando a Valerio Massimo che lasciò scritto:
Cnejus Pompejus ante omnes aquæ per semitas decursu
æstivum minuit fervorem[74], sarebbe stato questo
valoroso capitano il primo che avesse ad introdurre
l’anaffiamento delle vie a diminuzion di caldura e
di polverio ed additasse così il bene dell’evaporazione:
facile ne era allora l’applicazione a’ luoghi di trattenimento,
massime ne’ teatri, ne’ quali, per esservi rappresentazioni
mattutine e nel pomeriggio, vi si rimaneva
tanta parte del giorno.
La ricercatezza venne spinta dipoi a mescere a
quell’acqua, onde rinfrescavansi i teatri, anche odorose
essenze, e massime di zafferano allora in voga ed a
mezzo di tubi, disposti dentro de’ muri. Esse venivano
quindi sprizzate fuori, giusta quanto si legge nella
nonagesima epistola di Seneca: Hodie utrum tandem sapientiorem
putas qui invenit quemadmodum in immensam
multitudinem crocum latentibus fistulis exprimat[75].
[75]
Queste pioggie d’essenze, che Antonio Musa, il celebre
liberto e medico di Augusto e amico di Virgilio,
presso Seneca, appella odoratos imbres, pioggie odorose,
e Marziale nimbos, nimbi; più comunemente chiamavansi
sparsiones, nome anche comune alle liberalità
che facevano i principi al popolo; ma come già erano
stati di molti che austeramente avevano rimproverato
di mollezza campana l’invenzion del velario, pur furono
a più ragione di quelli che a ricordo di virtù e sobrietà
antica, rinfacciassero alla loro età queste effeminate
invenzioni.
E Properzio fra gli altri, nella sua Elegia, in cui
accenna a un grandioso tentativo poetico sui fasti
di Roma antica sventato dai consigli di un indovino
forestiero, che lo ricondusse ai suoi canti d’amore,
ha questo distico:
Nec sinuosa cavo pendebant vela theatro,
Pulpita solemni non oluere croco[76].
Egual concetto modulava Ovidio nell’Ars amandi
in questo distico:
Tunc neque marmoreo pondebant vela theatro,
Nec fuerant liquida pulpita rubra croco[77].
[76]
Ma poichè sono a dire delle varie costumanze del
teatro, non ommetterò quella che ci rivela Marziale,
nel deridere in un suo epigramma un cotale che ei
noma Orazio, solito a comparire vestito indecentemente
il giorno degli spettacoli.
Ecco l’epigramma:
Spectabat modo solus inter omnes
Nigris munus Horatius lacernis,
Cum plebs, et minor ordo, maximusque
Sancto cum duce candidus sederet,
Toto nix cecidit repente coelo,
Albis spectat Horatius lacernis[78].
Quando adunque l’inverno, o l’inclemenza della
stagione lo consigliava, essendo i teatri scoperti, non
si lasciava tuttavia di andarvi, ma s’avea cura di
avvolgersi in bianchi mantelli di grossa lana denominati
lacernæ, e quest’Orazio il Poeta mette in canzone
perchè fosse andato al teatro con una lacerna nera;
ma la neve inopinatamente fioccata in copia aveala
resa bianca siccome le altre.
Ora i bianchi mantelli di finissimo cascemiro ricoprono
soltanto le nivee spalle delle nostre eleganti
[77]
signore allorchè traggono a’ teatri principali, od anche
a serate di gala.
Se non che può credersi un abuso questo di portar
mantello in teatro, se un senso lato vuolsi dare
al seguente passo di Svetonio nella Vita d’Augusto:
Ac visa quondam pro concione pullatorum turba, indignabundus
et clamitans: En, ait,
Romanos, rerum dominos, gentemque togatam?
Negotium ædilibus dedit, ne quem posthac paterentur
in foro circove nisi positis lacernis, togatum consistere[79];
ma credo che il divieto d’Augusto non riguardasse
che i soli mantelli neri.
Io ho detto emiciclo, parlando del corpo dell’edificio
ov’erano gli spettatori, ossia della cavea, oltre
la quale eravi la torre del serbatojo d’acqua; ma più
propriamente la cavea del teatro tragico non aveva
la figura d’emiciclo, ma piuttosto di ferro da cavallo
ed era del diametro di 68 metri e si calcola aver potuto
contenere da cinquemila spettatori.
Gli scaglioni della cavea, gradus, e che noi diremmo
gradinata, erano in numero di ventinove, tutti
[78]
di marmo bianco divisi in tre piani, moeniana, da due
precinzioni o intervalli, detti anche baltei o cingoli,
dal loro scopo, e questi pure divisi in cinque scale,
scalæ, itinera, di cui ciascuno scaglione formava due
gradini, ripartiti in cinque cunei; oltre due altre parti,
le quali non sono ordinarie ne’ teatri, ma varietà speciale
di questo e che sono di forma rettangolare,
una per fianco e terminanti in due tribune riservate,
nell’una delle quali si trovarono anche gli avanzi di
una sedia curule.
Queste tribune, o spartimenti, hanno ciascuna un
ingresso particolare, che mette sul portico di dietro,
per una scala separata.
Il primo ordine della cavea aveva cinque scaglioni,
venti ne aveva il secondo e quattro il terzo. Sul primo
scaglione del secondo ordine eranvi incastonate lettere
di bronzo formanti questa iscrizione:
M . HOLCONIO . M . F . RVFO
II . VIR . I . D . QVINQVIENS
ITER . QVINQ . TRIB . M . A . P .
FLAMINI . AVG . PATR . COL . D . D .[80]
Al medesimo personaggio, cioè a Marco Olconio
Rufo figlio di Marco, ed a Celere Olconio
esiste altra iscrizione sulla scena, da cui è manifesta
[79]
come a loro spesa fossero stati eretti a decoro della
colonia una cripta, che è la summentovata torre
quadrata onde conservare l’acqua pel teatro, un tribunale,
che è quello sulla via del tempio di Iside in
seguito a’ propilei del Foro Triangolare, di cui ho
già parlato a suo luogo, e questo teatro:
MM . HOLCONI RVFVS ET CELER
CRYPTAM TRIBVNAL THEATRVM
S . P .
AD DECVS COLONIÆ[81].
Benemerita la famiglia degli Olconj di Pompei e
della colonia per tante publiche opere, terrò conto
pur di questa iscrizione ritrovata in questo teatro, allo
stesso M. Olconio Celere dedicata e scolpita in marmo:
M . HOLCONIO CELERI
D . V . S . D . QVINQ . DESIGNATO
AVGVSTI SACERDOTI[82].
Sotto la seconda cavea dovevano trovarsi tre statue,
delle quali due esser dovevano indubbiamente degli
Olconii, Celere e Rufo, alla cui spesa erasi eretto il
teatro.
Una particolarità poi offre l’orchestra del teatro
tragico in un piedistallo, o piuttosto altare, su cui,
a norma della costumanza greca, — e della Grecia
molti usi osservavansi, più che altrove dell’orbe
[80]
romano, in Pompei, — sacrificavasi a Bacco prima
di dar principio allo spettacolo. Chiamavasi con greco
vocabolo thymele o thimela, θυμελη, e serviva altresì
ad altri usi, come anche di monumento funebre, o
di qualunque altro oggetto richiesto nella rappresentazione
drammatica, nascondeva il suggeritore che
stava di dietro, mentre il suonatore di flauto (tibicen)
e qualche volta il capo del coro prendevan posto su
quello. In un teatro strettamente romano non v’era
thymele, perchè ivi l’orchestra fosse interamente destinata
ad accogliere gli spettatori, al pari della
nostra platea[83].
Al sommo di ciascuna sala eranvi le porte, vomitoria,
cui si giungeva per mezzo di corridoi e scale
praticate internamente.
Il proscenio presenta sette nicchie semicircolari per
i tibicini e nella parte anteriore corre tutto per il
lungo quella cavità dell’hyposcenium, da cui sorgeva
l’aulæum, o sipario della tragedia.
Altre particolarità non si notano che il Gran Teatro
distinguano dall’Odeum, ove non s’eccettui la
prospettiva della scena ch’era costituita da tre ordini
di colonne, l’uno sull’altro, con eleganti basi e capitelli
di marmo e sei statue saviamente collocate.
Sembra che anche questo publico edificio fosse stato
ben danneggiato dal tremuoto del 63 e che si trovasse
[81]
nel momento della catastrofe del 79 in istato
di riparazione, perocchè la scena che evidentemente
doveva essere rivestita di marmi ed altre decorazioni,
se ne presenti ora affatto spoglia. Delle tre porte ordinarie
che la scena si aveva, e che qui sono maestose,
aperta quella di mezzo, secondo l’uso, nel fondo di
un emiciclo, chiamavasi regia, perchè di là uscivano
i principali personaggi della tragedia: le due laterali
appellavansi hospitalia. Fiancheggiano la porta di
mezzo due nicchie che contenevano le statue di
Nerone e di Agrippina.
Piacemi finalmente tener conto di ciò che afferma
il Rosmini nella sua Dissertatio Isagogica, altre volte
da me citata, che cioè questo teatro fosse stato aperto
al publico, od almeno dedicato ad Augusto nell’anno vigesimosecondo
del tribunato di questo imperatore[84].
Frammenti di statue di marmo, lapidi con iscrizioni,
tegole ed embrici, e pezzi di legno carbonizzati si
rinvennero dalla parte del Foro Triangolare, e il
complessivo giudizio che dalle interessanti reliquie è
dato di formulare, può sicuramente mettere in sodo
che a questo loro teatro avessero i Pompejani ad aggiungere
grande importanza, se gli Olconj vi credettero
portare enormi dispendj; tanta vi pare la magnificenza
e la perfezione dell’arte.
[82]
Quali fossero le tragiche composizioni che a questo
teatro venissero rappresentate cerchiamo ora coll’usata
rapidità d’indagare.
Se ci fosse lecito di mettere il teatro pompejano a
fascio cogli altri teatri d’Italia, mi trarrei presto e
facilmente d’impegno, dicendo che a siffatto teatro si
rappresentassero, nè più nè meno che ai teatri di
Roma, le tragedie de’ latini scrittori, e mi avverrebbe
allora di ricordare i nomi de’ più celebrati poeti; ma
gli scavi ed oggetti teatrali rinvenuti mi impongono
obblighi maggiori.
Sappiamo che Andronico lasciò diciannove tragedie,
comunque appena qualche frammento sia rimasto
superstite e giunto fino a noi, e di questo autore ho
già parlato altrove abbastanza: egual numero ne lasciò
Marco Pacuvio, e Quintiliano le loda per profondità
di sentenze, nerbo di stile, varietà di caratteri, sebbene
la critica moderna più severa, nel poco che ci
è pervenuto, giudichi non esser concesso ravvisare
che liberissime imitazioni in istile oscuro e senza
armonia. Lucio Accio alla sua volta ne compose e
raffazzonò di molte, fra cui il Bruto e il Decio, soggetti
patrizi che recitavansi ancora ai tempi di Cicerone
e più volontieri venivano lette, e dell’Atreo,
che Gellio scrisse aver Accio, giovanetto ancora,
letto in Taranto a Pacuvio, pur lodandolo di grandiose
e solenni cose scritte, non gli tacque di altre
sembrargli dure alquanto ed acerbe; al che avesse
[83]
a rispondergli: non dolere ciò a lui, e trarne anzi
auspicio di buon avvenire, per accader degli ingegni
quello che delle mele, che, se nate agre e
dure, divengono poscia tenere e succose; ma se
spuntino tenere e succose, col tempo, non mature
ma vizze si rendano e corrotte[85].
Di Gneo Nevio campano già dissi nel precedente
capitolo del pari; ora ricorderò Quinto Ennio Calabrese,
che scrisse tragedie e commedie non poche,
che predicava di sè aver ereditato l’anima di Omero,
Cassio Severo, Varo da Cremona e C. Turrano Graecula
rammentati, a cagion d’onore, da Ovidio, come
autori di buone tragedie[86]; ma più vorrei intrattenermi
di Asinio Pollione, che fu riconosciuto siccome
il più celebre tragico latino: ma che dirne, se
nulla di lui, come degli altri sunnominati, sopravisse?
Istessamente della Medea, che si sa avere
scritto Ovidio stesso, della quale egli nel libro secondo
Dei Tristi, dopo avere ricordato i libri dei
Fasti, i sei ultimi dei quali o non iscrisse, come
crede il Masson, o andarono perduti, soggiunge:
Et dedimus tragicis scriptum regale cothurnis:
Quæque gravis debet verba cothurnus habet[87].
Di questa tragedia non sussistono infatti che il seguente
verso riferito da Quintiliano:
[84]
Servare potui, perdere num possim rogas?[88].
e l’emistichio seguente ricordato da Seneca il Vecchio,
nella terza Suasoria:
Feror huc illuc, ut plena Deo[89].
Se non che, oltre la Medea, più altri lavori sembra
che Ovidio abbia scritto pel romano teatro; fra i
quali certo la Guerra de’ Giganti, com’ei ce ne avverte
nell’elegia I degli Amori:
Ausus eram, memini, cœlestia dicere bella
Centimanumque Gygen; et satis oris erat[90].
Si gloria egli stesso che molte volte fossero rappresentate
anche alla presenza d’Augusto[91], e continuassero
a rappresentarsi con grande concorso anche
dopo il suo bando[92].
Nè di più posso dire del Tieste di Vario, che a
giudizio di Quintiliano cuilibet Græcorum comparari
potest[93], e che Orazio nell’Arte Poetica mette con
Virgilio a paro.
[85]
Alcune tragedie, gonfie di declamazioni e mancanti
di quel che appunto costituisce il dramma, che è
l’azione, raccolte in volume, vengono tuttavia spacciate
sotto il nome di Lucio Anneo Seneca da Cordova.
Esagerazioni, passion falsa, caratteri atroci, furori,
situazioni improbabili sono difetti comuni a
queste composizioni, alle quali non ponno tuttavia negarsi
ben coloriti racconti, spesso maschii concetti e
qualche buona sentenza, laconiche e concettose parole.
Nella Medea, a cagion d’esempio, quando la nutrice
la compiange perchè più nulla le sia rimasto:
Abiere Colchi; conjugis nulla est fides;
Nihilque superest opibus e tantis tibi,
Medea fieramente risponde:
Nell’Ippolito, Teseo chiede a Fedra qual delitto creda
dover ella colla morte espiare:
Quod sit luendum morte delictum, indica.
Fedra risponde:
[86]
Curioso è poi nel Coro de’ Corintj della Medea trovar
vaticinata la scoperta di un nuovo mondo, quattordici
secoli, cioè, prima che Cristoforo Colombo
facesse quella dell’America:
Venient annis
Sæcuta seris, quibus Oceanus
Vincula rerum laxet, et ingens
Pateat tellus, Tethysque novos
Delegat orbes; nec sit terris ultima Thule[96].
Nè qui tutti furono i tragici romani, tra i quali si
vuol perfino annoverare Mecenate, l’amico e protettore
di Virgilio e d’Orazio, ed abbenchè si persista
dai dotti a ritenere che Roma non abbia avuto tragedie;
pure io reputo che tale sentenza unicamente
debba intendersi nel senso che la romana storia non
abbia prestato forse i subbietti eroici come la greca,
alla quale pur tolsero per la più parte i proprj coloro
che scrissero tragedie nella lingua del Lazio, e
che però non sia riuscita a lasciare, come la greca,
traccie luminose. Ma io non torrò, a tale riguardo,
la mano al Nisard, che le cause ne indagò ne’ suoi
Études sur les moeurs et les poètes de la decadence, trattando
[87]
appunto di Seneca. — I subbietti di questo poeta,
noterò ad ogni modo, ed a rincalzo di questa osservazione,
che all’infuori dell’Octavia, sono tutti eroici
greci, che tali sono appunto la Medea e l’Hippolitus
succitati, l’Hercules furens, Thiestes, Thebais, Œdipus,
Troas, Agamemnon ed Hercules Œtæus.
Ecco come il sullodato Nisard riassume le cause
per le quali Roma non ebbe tragedie:
«Nè il dramma per altro motivo è l’opera letteraria
più indigena e più originale d’esso paese, se
non perchè non può essere fatto senza il popolo, e
perchè il popolo deve discuterlo in pieno teatro.
Roma non ebbe dunque drammi, perchè non ebbe
vero popolo. Senza il popolò può esser creata una
bella letteratura d’imitazione, ma non il dramma, e
questo lo provò appunto la Roma aristocratica. Seminando
il suo vero popolo su tutti i campi di battaglia,
essa perdette una delle più belle glorie dello
spirito umano, quella del dramma, ma ebbe in compenso
la gloria di vincere il mondo, e qui ebbe assai
di che compensarsene. — In conclusione, un dramma
nazionale era impossibile a Roma; e quanto alla
bella e patetica tragedia di Atene, che sarebbe venuta
a fare in mezzo ad un popolo di usuraj e di
soldati, con tutte quelle delicatezze d’arte che inebbriavano
la colta popolazione di Atene? Che interesse
potevano prendere quelle turbe ardenti, e senza gusto,
per uomini della leggenda omerica, per la caduta
[88]
delle antiche monarchie, per quegli incesti, per quegli
assassinj, che eccedettero le forze umane, delitti
comuni agli Dei ed agli uomini, che le giurisdizioni
della terra non possono punire? Che pietà potevano
esse sentire per que’ figli maledetti, per que’ sovrani
ciechi ed erranti, per quelle vergini sospese alle
braccia de’ vecchi, o chinate come statue sull’urne funerarie,
o di loro mano componenti nel sepolcro il
corpo d’un fratello, e sempre conservando in mezzo
delle più dolorose prove la grazia e la bellezza, senza
aver mai quelle lagrime moderne che solcano le
guancie ed insanguinano gli occhi, nè quelle smorfie
di dolori la cui invenzione risale a Seneca? E se la
tragedia trapiantata così dalla Grecia sul teatro di
Roma, avesse saputo, come l’epopea, imitata da Virgilio,
e come l’ode imitata da Orazio, riprodurre
nella bella lingua latina tutte le armonie e le grazie
della lingua d’Atene, che noja non avrebbe dato
questa musica dell’anima a’ sensi avvezzi al pugilato
ed ai combattimenti di bestie, abbrutiti dalla
vista del sangue grondante sotto i colpi del cesto o
dei corpi lividi per le ammaccature, e che prestava
l’orecchio assai più volontieri agli urli degli orsi che
al ritmo delle strofe alate che rapivano il popolo di
Atene e l’aristocrazia di Roma?»
Lance, nelle sue Vindiciæ romanæ tragediæ[97], raccolse,
ciò malgrado, frammenti di ben quaranta tragici.
[89]
Otto Ribbeck[98] publicò del pari Tragicorum
romanorum reliquiæ: ma nondimeno la tragedia latina,
come dissi testè, restò di molto addietro dalla
greca, i cui capolavori, che noi italiani abbiamo
egregiamente tradotti da Felice Bellotti, rimarranno
sempre, infin che vivrà ombra di letterario gusto,
meritamente ammirati.
Queste tragedie tutte del teatro latino, è più che
naturale che al Teatro di Pompei venissero rappresentate;
ma pare altresì che a’ greci autori chiedessero
colà le opere e si rappresentassero sulle
scene pompejane e nel loro originale le tragedie
più cospicue de’ greci poeti.
Già una delle tre tessere teatrali d’avorio che furono
rinvenute negli scavi, quella, cioè, che offre da
un lato l’immagine in rilievo di un anfiteatro con il
pegma nel centro, vedemmo come nel rovescio portasse
l’indicazione del posto, a cui apriva l’ingresso,
in caratteri greci, e forse una tale particolarità potrebbe
essere un indizio che quella tessera, diversa
dall’altra che porta caratteri latini e che annunzia
la commedia di Plauto, fosse in caratteri greci perchè
greco lo spettacolo; non altrimenti che si usa
da noi, lorchè si rappresenta la commedia francese,
che affissi, programmi e biglietti sono nella stessa
lingua composti e distribuiti. Ma più che questa,
valse di prova ad altri la tessera portante pure
[90]
nel rovescio parole greche, che si pretesero leggere
per Αῖςκυλο, cioè di Eschilo; con che si volle inferire
che nelle città della Campania si rappresentassero
ancora le tragedie del più antico tra i sommi
tragici greci nel loro nativo idioma.
Ora, poichè sono a dire di quella tessera, credo fornire
la diversa interpretazione di chi, esaminate altrimenti
le parole del rovescio greche ed indagato il
disegno del gettone, volle conchiudere significar esso
invece la tessera dell’infimo posto. Negli oggetti
confusi che vi son rappresentati si può distinguere
una porticella alla quale si giunge per una scaletta
ed alquante barriere a croce, ciò che parve a
Barré, continuatore di Mazois[99], indicare la galleria
di legno, od altrimenti l’impalcato che erigevasi
sulla sommità delle mura degli anfiteatri o teatri,
pari al loggione dei teatri moderni. Ciò ritenuto
e considerando che le parole greche del rovescio
sono scritte testualmente così: ΑΙCΧ . ΥΛΟΥ, vale a
dire con un punto nel mezzo, mal si potrebbe allora
sostenere che si debba ravvisarvi il nome di
Eschilo. Forse ΑΙCΧ potrebbe essere l’abbreviatura
di αίςκροῦ, posto cattivo, ΥΛΟΥ potrebbe essere la
forma scorretta di ὔλης, di legno, ed indicare allora
l’ultimo banco destinato agli schiavi, alle cortigiane
ed alla plebe.
[91]
Ma per tornare all’argomento delle rappresentazioni
greche, è assai verisimile che esse potessero aver
luogo massime ne’ teatri della Campania, dove la
lingua greca invece rimase, più che in Roma, conosciuta
e più popolare; nè è rado che pur oggidì
nelle città e paesi dell’antica Magna Grecia si oda
tuttavia l’antico linguaggio materno. E notisi che
nelle agiate famiglie romane la lingua greca costituiva
la base della educazione, come il latino e il
greco furono della nostra. I giovani si esercitavano
a composizioni nel greco idioma ed erano incamminamento
a maggiori. Han tratto a quest’uso i seguenti
versi di Persio:
Ecce modo heroas sensus afferre videmus
Nugari solitos græce[100].
La forma da ultimo de’ teatri pompejani che ho
descritto s’accosta meglio al modello greco che al romano:
prova questa eziandio che le antiche tradizioni
vi si mantennero e si rivelarono in tutto.
Questi cenni, comunque specialmente riguardino il
teatro tragico di Pompei, riassumono a un di presso
le condizioni pure generali del teatro romano.
Mancherebbe di dire ora qualcosa intorno agli attori
e vi soddisfarò con brevi parole.
[92]
Ho già detto, parlando del Teatro Comico, a qual
classe essi per lo più appartenessero e in che sprezzo
dalle leggi e dalla società fossero tenuti: ma non fu
sempre così. L’arte drammatica progredì; spesso autore
ed attore non furono che una persona sola, e
l’ingegno seppe anche vincere spesso i pregiudizj.
Batillo e Pilade, Esopo e Roscio conseguirono, come
attori, celebrità; dal nome di quest’ultimo è anzi ancora
designata l’arte dell’agire sulle scene: arte di
Roscio, egli avendo pel primo abbandonata la maschera;
onde l’effetto e l’espressione divennero di
lunga mano maggiori. Fu a riguardo di questi nomi
e dell’eccellenza loro, che a distinguerli dagli altri,
non vennero più detti istrioni, e fu per avventura
mercè codesta, che direi riabilitazione, che, scostandosi
dal greco costume, il quale inibiva alle donne
il prodursi sulle scene, Roma ebbe anche attrici, e
celebrata fra tutte andò meritamente Dionisia.
Fu agli insegnamenti di Roscio che l’Oratore Romano
apprese il gesto a secondare più efficacemente l’arringa,
e, divenuti poi entrambi amici, gareggiarono tra
loro a chi meglio sapesse esprimere un pensiero,
questi colla parola, quegli col gesto. Anche Esopo, il
quale volle essere attore unicamente tragico, fu nell’intimità
di Cicerone, e già rammentai come egli
salutasse dalla scena il richiamo in patria di questo
gran cittadino ed insuperato oratore. Ed Esopo e Roscio
alla lor volta non mancavano poi d’intervenire
[93]
al loro ogni qualvolta si fosse agitata alcuna causa
interessante per istudiarvi i movimenti dell’oratore,
del reo e degli astanti.
Non fu per questo che Giulio Cesare credesse di
compiere atto di tirannide inqualificabile, come noi
giudichiamo adesso, quando costringeva Siro e Laberio
di patrizio casato a montar sulle scene. Laberio,
è vero, si lagnò della violenza in un suo
prologo che Macrobio ci ha conservato; ma tenutosi
conto delle condizioni della società d’allora, forse
fu incentivo al despota la particolare attitudine alle
scene di questi uomini, che infatti si resero famosi
nell’arte imposta loro.
Anche di Siro, come già notai nell’antecedente
capitolo, ci vennero conservate alquante sentenze
morali, che teneva in serbo per intromettere all’occasione
in quelle composizioni, nelle quali, se comiche,
assai spesso sapevano improvvisare felicemente
il dialogo[101].
Così alle sceniche rappresentazioni il publico appassionandosi,
si poterono vedere attori e attrici venire retribuiti
largamente e montare in ricchezza e possanza.
Sappiam di Roscio che ricevesse all’anno cinquecento
sesterzi grossi, che vorrebbero dire centomila
lire de’ nostri tempi; di Esopo che lasciò, morendo,
a suo figlio, il pingue gruzzolo di quattro milioni di
[94]
lire, in onta ch’egli avesse menata splendidissima
vita, e permettergli il bizzarro capriccio di ammanire
a sè ed agli amici suoi un manicaretto di perle. Perocchè
rammenti Plinio, che questo Clodio, figlio
di Esopo, prima di Cleopatra, avesse voluto un giorno
esperimentare qual gusto avessero le perle, e in un
festino ne mangiò parecchie di eccessivo prezzo. Il
gusto gli andò maravigliosamente a genio e per non
essere solo ad assaporarne le delizie, ne fece stemprare
altre a’ suoi convitati, fra le quali la grossa perla
strappata all’orecchia di Metella, l’amante sua[102].
Anche la summentovata Dionisia, per una sola stagione,
ottenne mila sesterzj grossi, o dugentomila lire.
Non facciamo noi dunque le meraviglie de’ lucri ingenti
della Rachel e della Ristori, le somme attrici del
nostro tempo, nè delle favolose somme concesse alle
agili gole delle nostre prime donne di canto.
I lauti emolumenti, che si pagavano a’ migliori
artisti, son già prova di per sè che dovessero essere
determinati dal favore che si godevano nel pubblico;
ma questo aveva altri modi ad estrinsecarlo,
quelli stessi, cioè, che abbiam pur di presente. Eran
essi gli applausi ed i viva, il gitto di fiori e di corone,
e i doni; come i sibili, i gesti di scorno, gli urli ed
altre violenze notavano la disapprovazione.
Quest’argomento ch’io non tocco, per l’economia
della mia opera, che di volo, suggerì materia a Francesco
[95]
Bernardino Ferrario ad un volume in quarto
di oltre quattrocento pagine, che tolto il titolo De
Acclamationibus et plausu vide la luce in Milano il
1627. Nicola Alianelli, buon letterato napoletano, ne
spigolò quanto a lui parve per adornarne alcuni articoli
interessanti ch’ei diede in luce nella Rivista Teatrale
L’Arte (riputato giornale napoletano), nel
passato anno 1870 sotto il titolo Dell’Antico Teatro
Romano e che, sciente forse del come io incombessi a
quest’opera su Pompei, volle cortesemente regalarmi,
di che son lieto di rendergliene pubblicamente i
dovuti ringraziamenti. Ed io di taluna di queste notizie,
più che del volume del Ferrario, mi varrò alla
mia volta per quel poco che ne devo qui dire.
Fra Plauto e Terenzio, sappiamo che il popolo accordasse
le sue predilezioni al primo, spesso anzi al
secondo riserbando le sue disapprovazioni, od almeno
non concedendo quella larghezza di plausi che pur
avrebbe dovuto meritarsi. N’è una causa certissima
che Plauto si avvantaggiasse meglio dell’idioma popolare
e però ne fosse meglio dal suo uditorio capito:
Terenzio, di latinità più castigata, s’aveva l’approvazione
dell’aristocrazia, e il popolo, che poco
intendeva, gli era anche poco propizio e gli volgeva
sovente le spalle.
Ad ogni modo vediamo, sia ne’ prologhi, che nei
congedi delle loro commedie, da entrambi fatto appello
all’attenzione indulgente ed agli applausi. Plauto, a
[96]
cagion d’esempio, nella Cistellaria, prega gli spettatori
di applaudire secondo le costumanze degli
antichi, more majorum. Nella Casina, si raccomanda
agli stessi di dargli colle mani la debita mercede,
manibus meritis debitam mercedem. Terenzio pure chiude
l’Andria, l’Eunuco, l’Ecira, e tutte insomma le sue
commedie col solito plaudite.
In quanto a’ Tragici, Cicerone nel libro De Amicitia
ci ha lasciato memoria delle voci di plauso
clamores, con cui fu accolta la nobile gara di Oreste
e Pilade nella tragedia di Marco Pacuvio.
Il gridar euge equivaleva al bravo de’ nostri giorni:
quella parola troviamo usata in diverse commedie di
Plauto; i maggiori entusiasmi, più facili per altro
nel circo e nell’anfiteatro, nelle corse, e nei ludi
gladiatorj, si esprimevano, come dissi più sopra, co’
fiori e coi doni, e coll’agitar delle vesti e delle pezzuole,
od anche alzando i pugni con particolare atteggiamento
dei pollici, come raccogliesi nel seguente
passo di Orazio:
Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum[103].
Nè sempre di buona lega erano gli applausi e le
altre dimostrazioni d’aggradimento, nè creda però la
[97]
Francia, esser’ella l’inventrice della claque teatrale.
Pur troppo l’origine di essa è nostra, e rimonta ai
tempi de’ quali parlo. Chi vuol credere, a mo’ d’esempio,
che fossero giusti e ben meritati i plausi
dati a Nerone citaredo e cantante? Per lui eran la
paura, l’adulazione e la speranza dell’imperatorio
favore che li suscitavano: come anche quelli dati
agli altri istrioni, al par di lui mediocri o cattivi, avevano
la lor ragione nel prezzo ch’era stato da essi sborsato.
Udiamo Marziale:
Vendere nec vocem Siculis plausumque theatris[104].
Questo giambo del Poeta era per Cinnamo fatto cavaliere
per intrighi dell’amante, da barbiere ch’egli era,
e che non potendo comparir nel foro, era passato in
Sicilia, dove gli dice: non potendo più vendere il
suo plauso nel teatro, sarà costretto ritornare barbiere.
Cicerone poi racconta al suo Attico d’aver udito
in Roma un Antifonte attore, di cui nessuno più meschino
e sfiatato, nihil tam pusillum, nihil tam sine
voce[105], che tuttavia palmam tulit, fece furore; come
molto piacque, valde placuit, certa Arbuscula, attrice
d’un merito non superiore. Costoro di certo avevano
mercanteggiato quel plauso, che lo stesso Oratore
[98]
Romano, nell’arringa Pro Publio Sextio, afferma si
comperasse nei teatri e nei comizj.
Plauto poi nella Cistellaria ci fa sapere che il
choragus, finita la commedia, dava a bere agli attori che
avevano fatto il loro dovere, e saranno stati vino e
bevande calde.
Vediamo ora il rovescio della medaglia.
Lo stesso Cicerone summentovato, parlando di Oreste,
attore, dice che fu cacciato dal teatro non modo
sibilis, sed etiam convicio, non coi sibili soltanto, ma
benanco colle ingiurie, e che se un attore avesse fatto
un movimento in aria non in corrispondenza della
musica, od avesse peccato di una sola sillaba, lo si
fischiava e copriva di urli, exibilatur, esploditur, theatra
reclament[106].
Così non mancava ciò che or diremmo, col vocabolo
consacrato, la clique, e Terenzio esperimentò
l’opera d’un partito contrario comitum conventus, l’odierna
consorteria, massime nell’Ecira, stata a lui
fischiata per ben due volte; ciò che per altro non
impedì che piacesse alla terza volta.
Ai cattivi attori poi si gettavano, a segno di
sfregio maggiore, e pomi e noci e talvolta anche pietre,
la quale ultima dimostrazione fu poi dagli edili
con ispeciale editto interdetta. Siccome poi gli attori
[99]
erano per lo più schiavi, così come si apprende dalla
suddetta Cistellaria e dall’Asinaria di Plauto, quando
cattivi o svogliati, venivano a spettacolo finito battuti.
«Ma non bisogna dimenticare, scrive il sullodato
Alianelli, un personaggio umile, modesto,
stretto in una buca, che niuno plaudisce, di
cui niuna rivista teatrale parla mai, e che non
pertanto è necessario, che deve sempre stare
presente a sè stesso, sempre attento. Il lettore ha
già capito che parlo del suggeritore. Nei teatri romani
gli attori imparavano le parti, nè più nè
meno che si fa ai tempi nostri, e perciò vi era il suggeritore
e si chiamava Monitor.» Pompeo Festo ricorda
il monitor come quegli che avverte, monet,
l’istrione sulla scena, ed in questo senso è ricordato
anche da un’iscrizione antica riportata dal Morcelli
nella sua Dissertazione sulle tessere con annotazioni
del dottor Giovanni Labus[107].
Dopo tutto, nel chiudere questo capitolo e quanto
interessa il teatro tragico e l’argomento delle sceniche
rappresentazioni, a non perdere di vista il principal
subbietto del mio libro, accennerò appena della
questione largamente agitatasi fra i dotti che un solo
veramente fosse il teatro in Pompei, e questo fosse
quello che ho finito di descrivere, sotto la denominazione
di teatro tragico, e che l’altro teatro non
[100]
fosse già destinato alla commedia e all’egloga e a
musicali rappresentazioni, ma unicamente l’Odeum
nella più stretta sua significazione, o quanto dire
una semplice pertinenza del Gran Teatro, ove si
sperimentavano non solo i componimenti, ma gli attori,
i suonatori, tibicini e fidicini, o suonatori di tibia, di
lira e di cetra, i danzatori, i coristi e quante persone
insomma dovevano prendere parte in tali spettacoli,
prima di esporsi nel gran teatro. Trovo ricordato che
siffatto argomento sia stato molto illustrato dal signor
Mario Musamesi, erudito architetto di Catania, nella
sua Esposizione dell’Odeo Greco tuttora esistente nella
di lui città, e che un estratto di quest’opera con
savie osservazioni ed aggiunte sia comparso nel
Giornale de’ Letterati Pisani dell’anno 1823; ma nè
l’opera del Musamesi, nè questo giornale non essendomi
stato possibile di procacciarmi, nè d’altronde
presumendo io, come ho già più d’una volta in quest’opera
protestato, di entrare in polemiche archeologiche,
che lascio volontieri ai dotti, ben diverso
essendo l’intento del mio libro, mi parve di non dovermi
discostare dalla opinione più generalmente
accettata che il minor teatro designa come esistente
a sè e col nome di Teatro Comico.
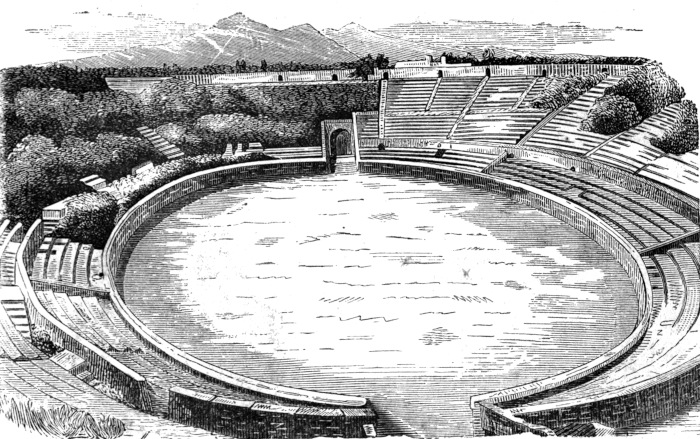
Anfiteatro di Pompei. Vol. II, Cap. XIV.
D’altronde, sempre rispettando le ragioni, che potranno
essere eccellenti e che sono sostenitrici di diversa
sentenza, sembrami che se il minor teatro non avesse
dovuto servire che ai soli bisogni ed alle prove del
[101]
Gran Teatro, non vi sarebbe stato mestieri, nella
costruzione, di praticarvi tutte le parti, sia per gli
spettatori, che per gli attori; perocchè, come più d’una
volta ho in queste pagine osservato, non escluse le
altre minori particolarità attinenti l’assistenza de’ magistrati
e de’ maggiorenti, i due teatri non differiscono
che leggermente tra loro nella forma, e sensibilmente
solo nella capacità e nella magnificenza.
La scena allora e l’orchestra avrebbero bastato: della
cavea, delle tribune e degli altri accessorj, evidentemente,
destinati al concorso del pubblico, se ne sarebbe
fatto senza.
Del resto io pure non ricusai al minor teatro pompejano
il nome di Odeum, congiuntamente a quello di
Teatro Comico, perchè non ignorassi, ed avessi anzi
a dire, che se dapprima per Odeum si intendesse quel
piccolo teatro con un tetto convesso costruito da Pericle
in Atene per gli spettacoli di musica, stando a quanto ne
scrissero Plutarco[108] e Vitruvio[109]. Ed ebbi a notare
altresì come in progresso di tempo questo nome si
avesse ad estendere anche in Italia, per designare
ogni piccolo teatro coperto di un tetto (tectum), come
in questo senso l’usò Svetonio, quando nella vita di
Domiziano assicurò aver questo Cesare restaurato un
Odeum[110]: Item Flaviæ templum gentis, et stadium et
[102]
odeum, et naumachiam, e cujus postea lapida maximus
circus, deustis utrimque lateribus, extructus est[111].
D’altra parte io ebbi ad ammettere pure che l’Odeum
pompejano potesse servire non alla commedia soltanto,
ma alle musicali rappresentazioni benanco, ai
concorsi poetici, alle filosofiche disfide ed agli spettacoli
d’inverno.
[103]
CAPITOLO XIV.
I Teatri. — L’Anfiteatro.
Introduzione in Italia dei giochi circensi — Giochi trojani — Panem
et circenses — Un circo romano — Origine romana
degli Anfiteatri — Cajo Curione fabbrica il primo in legno — Altro
di Giulio Cesare — Statilio Tauro erige il primo di pietra — Il
Colosseo — Data dell’Anfiteatro pompejano — Architettura
sua — I Pansa — Criptoportico — Arena — Eco — Le
iscrizioni del Podio — Prima Cavea — I locarii — Seconda
Cavea — Somma Cavea — Cattedre femminili — I Velarii — Porta
Libitinense — Lo Spoliario — I cataboli — Il triclinio
e il banchetto libero — Corse di cocchi e di cavalli — Giuochi
olimpici in Grecia — Quando introdotti in Roma — Le fazioni
degli Auriganti — Giuochi Gladiatorj — Ludo Gladiatorio
in Pompei — Ludi gladiatorj in Roma — Origine dei Gladiatori — Impiegati
nei funerali — Estesi a divertimento — I
Gladiatori al Lago Fùcino — Gladiatori forzati — Gladiatori
volontarj — Giuramento de’ gladiatori auctorati — Lorarii — Classi
gladiatorie: secutores, retiarii, myrmillones,
thraces, samnites, hoplomachi, essedarii, andabati, dimachari,
laquearii, supposititii, pegmares, meridiani — Gladiatori
Cavalieri e Senatori, nani e pigmei, donne e matrone — Il
Gladiatore di Ravenna di Halm — Il polpo e il diritto
di grazia — Deludia — Il Gladiatore morente di Ctesilao
e Byron — Lo Spoliario e la Porta Libitinense — Premj
ai Gladiatori — Le ambubaje — Le Ludie — I giuochi Floreali
e Catone — Naumachie — Le Venationes o caccie — Di
quante sorta fossero — Caccia data da Pompeo — Caccie
di leoni ed elefanti — Proteste degli elefanti contro la
mancata fede — Caccia data da Giulio Cesare — Un elefante
funambolo — L’Aquila e il fanciullo — I Bestiarii e le
donne bestiariæ — La legge Petronia — Il supplizio di Laureolo — Prostituzione
negli anfiteatri — Meretrici appaltatrici
di spettacoli — Il Cristianesimo abolisce i ludi gladiatorj — Telemaco
monaco — Missilia e Sparsiones.
Io credo avesse ragione davvero il grande Oratore
Romano, quando, scrivendo ad Attico, gli dicesse che
[104]
delle ventiquattro ville che possedeva quelle di Tusculo
e di Pompei, gli andassero meglio a genio:
Tusculanum et Pompejanum valde me delectant; e l’avesse
Fedro, lo scrittor di favole, di rifugiarsi in
Pompei dalle ire e persecuzioni di Tiberio e di Sejano;
e Seneca di rammentare a Lucilio, come una
delle più care e sorridenti reminiscenze della sua
vita il soggiorno fatto nella sua giovinezza, in questa
bella ed allegra città campana.
Che avreste voluto infatti di più? qui alla salubrità
ed alla purezza dell’aere, alla mitezza e mollezza del
clima, alla feracità della terra, alla verzura dei monti,
al bell’azzurro del cielo e del mare, si aggiungevano
ricreazioni e diletti d’ogni maniera, sì che nulla si avesse
a invidiare per ciò alle delizie dell’Urbe, senza per
avventura contare gli inconvenienti di essa. Noi vi abbiam
trovato un Odeum o teatro per la commedia e
per i musicali concerti; vi abbiam visitato il teatro
maggiore per la tragedia: meco invito ora il lettore ad
ammirarvi l’anfiteatro destinato a que’ giorni ai ludi
gladiatorii ed alle cacce delle belve feroci.
Gli è uno de’ più bei monumenti antichi del genere
e se per vastità non da mettersi in concorrenza
coll’anfiteatro Flavio o Colosseo di Roma, nè con
quelli di Verona e di Pola nell’Istria che ci rimangono;
poteva tuttavia ben esser capace di ventimila
spettatori, considerevole ampiezza certamente, se non
si perda di vista ch’esso servisse ad una città che
[105]
sappiam di terz’ordine e la cui popolazione non poteva
eccedere il numero de’ trentamila abitanti.
Prima d’entrarvi meco, investighiamo, amico lettore,
insieme le origini di siffatti pubblici e grandiosi ritrovi
e dei ludi a cui giovavano essi: è così buona
la storia alla tua lodevole curiosità e all’indole degli
studj nostri!
Io già avvertii, sulla fede dello storico padovano,
del come seguisse l’introduzione in Roma dei ludi
scenici: i circensi erano già allora in uso; eranvi
anzi venuti co’ fondatori della città stessa, portati
da Enea e da’ suoi compagni, o se si vuol questa
una favola, da que’ guerrieri che, superstiti dall’eccidio
di Troja, navigarono ai lidi tirreni.
Romolo infatti eresse pei medesimi un circo presso
al foro; Tarquinio Prisco murò il Circo Massimo sul
Palatino, lungo tre stadj e mezzo, largo quattro
jugeri e capace di cencinquantamila persone.
Ne è altro documento e prova il fatto che pur a’
tempi di Augusto e di Claudio si celebrassero giuochi
in Roma che venivan detti trojani. Virgilio così
li ricorda, dopo aver descritto ad imitazione d’Omero
per la morte di Patroclo[112], quelli celebrati in onore
di Palinuro, il timoniero della nave d’Enea caduto
dormendo in mare:
[106]
Hunc morem cursus, atque hæc certamina primus
Ascanius, longam muris cum cingeret Albam,
Retulit, et priscos docuit celebrare Latinos.
Quo puer ipse modo, secum quo Troja pubes,
Albani docuere suos; hinc maxima porro
Accepit Roma, et patrium servavit honorem;
Trojaque nunc, pueri, Trojanum dicitur agmen[113].
E Tacito, ne’ tempi appunto di Claudio, fa egli
pure menzione, negli Annali, del Giuoco di Troja, equestre
giostra che rappresentavano nobili donzelli a cavallo[114],
come traduce il Davanzati.
Questi giuochi del circo, essendo altresì parte di
cerimonie religiose, attecchir dovevano nelle popolari
abitudini di Roma e la vita guerresca de’ suoi cittadini
e l’animo temprato a spettacoli efferati, avevano
agevolmente que’ giuochi posti in cima d’ogni altro
divertimento; sì che si suolesse, come ho rammentato
nel duodecimo capitolo, dir che la plebe
romana si pascesse di pane e di ludi circensi: panem
et circenses.
Per circo, secondo l’uso romano, intendevasi quello
[107]
spazio di terreno destinato alla corsa. Ne’ primissimi
tempi consisteva esso in una spianata aperta, intorno alla
quale si erigevano de’ palchi provvisori in legno per
commodo degli spettatori, a un di presso come possono
essere que’ tratti di pianura ne’ parchi, nei giardini,
in altre vaste campagne che in Inghilterra,
in Francia e pure in Italia, su cui si fanno oggidì
le corse de’ cavalli. Non si tardò guari a costruire
un edificio permanente su d’una pianta acconcia,
che però assunse la forma oblunga, da una parte
chiusa da un semicircolo e dall’altra da una costruzione
detto oppidum, o castelletto, sotto cui erano le carceri,
pel servizio de’ cavalli e de’ cocchi, nome serbato
tuttavia nelle congeneri costruzioni odierne degli
anfiteatri, che si aprirono eziandio a quegli ippici
divertimenti.
Rich così descrive quello tuttavia superstite vicino a
Roma, assai ben conservato, sulla via Appia e comunemente
conosciuto sotto il nome di Circo di Caracalla.
«Un lungo muro basso (spina) era costruito in
senso longitudinale per mezzo al campo della corsa,
così da dividerlo come una barriera, in due parti separate,
ed a ciascheduna delle due estremità era
posta una meta (meta), intorno a cui i carri giravano;
quella più vicina alla stalla pigliando nome di meta
prima, la più lontana di meta secunda. I due lati del
circo non sono affatto paralleli l’uno all’altro e la
spina non è esattamente equidistante da’ due lati.
[108]
Forse questo è un caso eccezionale: ed una tale
norma di costruzione era seguita solo quando s’aveva
un terreno, come questo, limitato ad oggetto di fornire
il maggiore spazio ai carri a principio della
corsa, quando pigliavano le mosse tutti in riga; ma
quando la meta in fondo era stata girata, si dovevano
trovare schierati piuttosto in colonna che in
riga; e quindi una minore larghezza bastava lungo
questo lato del terreno di corsa. Per una simile ragione
l’ala destra del circo è più lunga della sinistra,
e le stalle sono disposte su un segmento di circolo,
di cui il centro cade esattamente al punto intermedio
fra la prima meta e il lato dell’edificio da cui la corsa
principiava. L’oggetto di ciò era che tutti i carri, secondo
uscivano dalle loro stalle, potessero avere la
stessa distanza da percorrere prima di raggiungere
il posto di dove aveva luogo la mossa, ch’era all’entrata
del terreno della corsa, dove una corda imbiancata
(alba linea) era tesa a traverso raccomandata a
due piccoli pilastri di marmo (hermulae), e poi lasciata
libera da un lato, appena i cavalli vi si erano
tutti egualmente accostati, ed il segnale della partenza
era stato spiegato. Eravi il palco dell’imperatore
(pulvinar) e quello dal lato opposto si suppone
che fosse stato destinato al magistrato (editor spectaculorum),
a cui spesa i giuochi si davano. Nel centro
dell’estremità occupata dalle stalle vi era una
grande porta, chiamata porta pompæ, per la quale
[109]
la processione circense entrava nel circo prima che
le corse principiassero, un’altra era costruita all’estremità
circolare chiamata porta triumphalis, per la
quale i vincitori escivano dal circo in una specie
di trionfo; una terza è situata sul lato destro chiamata
porta libitinensis, e per essa i cadaveri degli
auriga uccisi o feriti erano portati via e due altre
erano lasciate proprio vicino ai carceres, che davano
l’ingresso nel circo ai carri.»
Tutti i circhi erano modellati su questo e fu per
l’appunto la ragione per la quale ne riportai la descrizione
particolareggiata, perchè se ne potesse
avere l’idea precisa.
Quanto all’elevazione interna ed esterna dell’edificio,
un circo nell’esterno era costruito sopra un
disegno simile a un di presso a quello de’ teatri, a
gradinate di sedili, divisi in file separate da scale e
da pianerottoli.
Quando si immaginarono gli Anfiteatri, de’ quali
or vado a dire, i circhi si compenetrarono per lo
più in essi: corse, cacce e giuochi gladiatorj vi si
trasportarono, trovandosi più proprio ed opportuno
arringo, come più sopra dissi, tal che si scambiassero
quasi sinonimi i rispettivi nomi. Ecco perchè io pure
li verrò quind’innanzi promiscuamente adoperando.
Entrati i ludi circensi, siccome ebbi del pari a notare
diggià, nelle abitudini e nei gusti della vita
romana, è meraviglia perfino come pel migliore servizio
[110]
dei medesimi non avessero gli Anfiteatri a sorgere
che negli ultimi tempi della Repubblica e fossero
anche questi dapprincipio temporanei e costruiti
di legno come erano stati prima i circhi, venendo cioè
eretti solo all’evenienza di straordinarie solennità per
vittorie riportate, o trionfi di capitani, le quali festeggiate,
si disfacevano incontanente.
L’origine ad ogni modo, ad onta del greco nome
che esprime l’idea di due teatri riuniti aventi quindi
gradinate e sedili disposti tutti all’intorno[115], vuol
essere attribuita a Roma, e Plinio, comunque additi
il fatto a ragione di biasimo, così lo narra:
«Io passo, scrive egli, a trattare del lusso degli edifici
di legno, lo che porge esempio della più completa
demenza. Cajo Curione, che morì nella guerra
civile, seguendo la fazione di Cesare, in occasione dei
funerali del padre, volle dare al popolo uno spettacolo
così straordinario, da lasciarsi addietro Scauro
e di far ciò che questi fatto non avesse. Ma come
avrebbe egli potuto per opulenza misurarsi col genero
di Silla e col figlio d’una Metella, il qual s’era
fatto aggiudicare a vil prezzo i beni de’ proscritti, e
aveva avuto a padre quel Marco Scauro, tante volte a
capo della città e che pel sodalizio suo con Mario aveva
potuto rapinar le provincie? Scauro stesso s’era già
sorpassato, traendo partito dall’incendio della sua
[111]
casa, per riunire in un sol luogo le più peregrine
cose dell’universo, sì che nessuno potesse in demenza
sopravvanzarlo. Fu dunque a Curione mestieri
di dar le spese al proprio ingegno; ed è prezzo
dell’opera esporre quanto ebbe a immaginare, onde
felicitarci de’ costumi presenti e chiamarci, come
usiamo di fronte agli andati, noi piuttosto che essi
di tempra antica.
«Fece egli costruire in legno due eguali e grandissimi
teatri, girevoli entrambi su pernii, così che
nelle ore antimeridiane si trovassero a dosso rivolti
in modo che l’uno non nuocesse alla schiena dell’altro,
poi d’un tratto i teatri girando sovra sè stessi, si
volgevan di fronte, congiungendosene le estremità e
fornivano un anfiteatro per gli spettacoli de’ gladiatori,
movendo con esso il popolo romano che vi si
trovava.
«Ma che è più a maravigliarsi in tutto ciò? dell’inventore,
o del trovato, dell’artefice o dell’autore,
di chi questo escogitò, o di chi l’accolse, di chi comandò,
o di chi obbedì? ecc.»[116]
In Dione poi leggesi altro anfiteatro essere stato
fabbricato di legno; ma essendosi sfasciato e rovinato,
aver tratto con sè molta uccisione di gente. Giulio
Cesare stesso, già dittatore, ne eresse alla sua volta
uno in campo di Marte; onde chiaro si vede che
[112]
molti e frequenti fossero tali costruzioni in legno,
come frequenti erano gli spettacoli gladiatorii o di
fiere, che per feste religiose, per gloriosi politici avvenimenti,
ed anco per elezioni di magistrati o di
capitani si venivano offerendo.
Ma sotto Augusto la smania dei ludi circensi e massime
delle caccie, venationes, venne fuor misura aumentando,
ed importanza pur s’accrebbe alla loro
degnità. Fosse eccesso di ricchezza, o inclinazione
di principe, a istigazione d’Augusto, nell’anno 725
di Roma, Statilio Tauro, amico di lui, costruì a propria
spesa il primo anfiteatro di pietra, i cui ruderi,
nella sua distruzione, hanno poscia formata quella
piccola eminenza, su cui poggia di presente la piazza
di Monte Citorio, ove fu eretta adesso la Camera dei
Deputati.
In molta fama ed in uso durò tale anfiteatro, finchè
sotto Nerone divampò in fiamme e sebbene si fosse
procacciato di ristaurarlo; così non lo fu che non venisse
a Vespasiano in pensiero d’altro erigerne più
degno. E vi pose mano infatti nell’ottavo suo consolato;
nondimeno solo compiuto da Tito figliuol suo
e da lui dedicato. Venne la ingente mole denominata
Flavia, perchè della famiglia Flavia questi due imperatori:
ma più comunemente è noto sotto il nome
di Colosseo o di Coliseo, a cagione d’una statua colossale,
che la volgar diceria esagerò di certo dicendola
dell’altezza di cento venti piedi, la quale fu
[113]
ritrovata nelle vicinanze e per alcun tempo stata
nella casa aurea di Nerone. E dura esso tuttavia ne’
pur suoi maestosi avanzi, avendo resistito alle ingiurie
del tempo e degli uomini; abbenchè, rispettato
da’ Barbari che invasero l’Italia e devastarono più
volte l’immortale città, patisse gli oltraggi d’un cardinal
Barberini, che, a sfruttarne il molto bronzo
che ne teneva unita la gigante costruzione, contribuì
alla demolizione di tanta parte, sì che avesse a meritare
che del vandalismo suo si dicesse: Quod non
fecerunt Barbari, fecerunt Barbarini[117]. — Ma corre antico
il vaticinio, riferito da Vida, che finchè duri il
Colosseo, abbia a durare anche Roma.
Dell’altezza di questo gigantesco monumento, scrisse
Ammiano Marcellino, essere stata tanta che l’occhio
umano vi giungesse a mala pena alla sommità; e circa
la vastità, Publio Vittore afferma contenesse commodamente
seduti ottantasette mila spettatori, e nell’àmbito
superiore, e sotto i portici altri dieci o dodici
mila ancora.
Ma prima assai dell’Anfiteatro Flavio di Roma,
esisteva quello di Pozzuoli, dove già riferii aver Augusto
trovata occasione di far leggi per distinzioni
delle classi nei teatri, per irriverenza usata a un Senatore,
e dove Nerone festeggiò Tiridate, re dell’Armenia,
con giuochi gladiatorj, ed apparato
[114]
grandissimo[118]; ed esisteva pur quello di Pompei, edificato
in pietra.
Il lettore che mi ha seguito ne’ capitoli della storia
deve rammentare come io abbia coll’autorità di Tacito
narrato della festa degli accoltellanti datasi da Livinejo
Regolo a quest’ultimo anfiteatro, e nella quale Pompejani
e Nocerini vennero fieramente alle mani, nè
avrà dimenticato allora che ciò avvenisse a’ tempi di Nerone,
il quale a punir quel sanguinoso fatto ebbe ad
inibir per dieci anni gli spettacoli dell’anfiteatro in
quella città. Ciò accadde nell’anno 812 di Roma e 59
dell’era cristiana; ma le due lapidi rinvenute, l’una
presso la principal porta meridionale dell’anfiteatro,
e l’altra presso l’uno de’ vomitori respicienti la città
dal lato occidentale e recanti una medesima iscrizione,
forniscono i dati per farne rimontare la fabbrica ad
assai tempo anteriore.
Ecco l’iscrizione:
[115]
C . QVINCTIVS . C . F. VALGVS
M. PORCIVS . M. F. DVO VIR .
QUINQ . COLONIÆ HONORIS
CASSA SPECTACVLA DE SVA
PEQ. AG. COER . ET COLONEIS
LOCVM IN PERPETVVM DEDER[119].
Questa iscrizione attribuisce la fondazione dell’anfiteatro
a Cajo Quinzio Valgo e Marco Porcio; gli
stessi che avevano fatto edificar e collaudato l’Odeum
e i quali necessariamente non potevano aver concesso
il luogo alla stessa che dopo l’invio della colonia
per parte di Silla; ma dove poi si ponga mente alle
altre iscrizioni rinvenute nell’anfiteatro stesso e che
più innanzi riferirò, e per le quali si veggono costruiti
de’ nuovi cunei o scomparti di gradinate da altri magistrati
e da maestri, magistri, del sobborgo, pagus,
Augusto Felice e una contribuzione per parte di costoro
alle spese, è allora concesso d’inferirne che la
completa costruzione dell’anfiteatro pompeiano seguisse
intorno al tempo in cui venne mandata da
Augusto una compagnia di Veterani, che vi costruì
appunto il Pagus Augustus Felix, cioè verso l’anno 747
di Roma, e il P. Garrucci infatti nelle sue Questioni
Pompejane stabilì con irrecusabili argomenti che essa
fu di poco posteriore ad un tal tempo.
[116]
L’anfiteatro fu costruito nella parte meridionale
della città presso le mura che guardavano a Stabia,
ed anche oggidì, appare meglio conservato che tutti
gli anfiteatri che ho superiormente ricordati, quelli
di Roma, cioè, di Verona, e di Pola; tanto esso venne
solidamente fabbricato, che neppure il tremuoto e
gli altri cataclismi, onde fu desolata Pompei, non poterono
nuocerne le fondamenta, poco la muraglia
che lo recingono, poco la gradinata della cavea, e solo
vedesi danneggiato nella parte superiore; conservate
per altro la prima e la seconda precinzione, benchè
spogliate de’ marmi ond’erano rivestite.
L’architettura esteriore, semplice e senza alcun
ornamento, non presentando che più ordini d’arcate
l’una all’altra sovrapposte, come si vede praticato
negli altri congeneri edificj, e non senza un certo
effetto nel suo complesso, è di pietra vesuviana.
Pur esternamente si osservano cinque grandi scalinate,
per le quali si ascendeva ad un deambulacrum,
o gran terrazza scoperta, che corrisponde al giro
esterno della seconda cavea, donde si saliva alle logge
superiori di archi laterizii, destinate per le donne e
per la plebe. Da questo deambulacrum, non è superfluo
al visitatore delle rovine di Pompei il sapere come
si goda del più delizioso orizzonte, poichè rimpetto
si abbia il Vesuvio, a settentrione i monti Irpini, ad
oriente i monti Lattarj, sulla china dei quali posa
Sorrento, e a mezzodì Napoli e le sue isole avvolte
come da una rosea nebbia trasparente.
[117]
Forse a diminuzione di spesa, e forse anche a renderlo
proprio agli spettacoli di naumachia, se si avessero
voluti offrire, ma che però il fatto d’essere città
marittima esclude che vi si avessero a dare, perchè
certo sarebbero riusciti inferiori ad ogni aspettazione
ed a quelli che offerir si potevano sul mare stesso,
l’edificio era stato costruito in una specie di bacino,
scavato in parte artificialmente, per modo che l’arena
si trovasse tanto al di sotto del livello del suolo per
quanto le mura si elevavano al disopra.
Vien misurato il più gran diametro dell’anfiteatro
di 130 metri, il più piccolo di 102. La direzione dell’ovale
è da N. a S.: alle sue estremità si trovano i
due principali ingressi, i quali mettono all’arena di
forma elittica.
Appunto per la suindicata ragione, che l’arena era
incavata nella terra, l’ingresso settentrionale che
riesce a quella e che forma un breve porticato a
vôlta, ha il pavimento lastricato di pietra vulcanica
in declivio, ed ha nei lati l’incanalatura per ricevere
le acque.
Due grandi nicchie sono a destra ed a sinistra di
tale ingresso, le quali dovevano contenere le statue
di due benemeriti cittadini, e di chi fossero ce lo
rivelano le opportune iscrizioni che sotto di esse si
leggono.
Quella a destra è così concepita:
[118]
C . CVSPIVS C . F . PANSA PONTIF
D . VIR . I . D .[120]
Quella a sinistra, così:
C. CVSPIVS . C . F . PANSA PATER D . V . I . D .
IIII QVINQ . PRAEF ID . EX D . D . LEGE PETRON .[121]
Più avanti fornirò gli schiarimenti intorno a questa
legge Petronia, della quale si fa nella iscrizione
cenno, riservandoli essi all’argomento degli spettacoli
gladiatorii.
Il marchese Arditi, nel trattare della legge Petronia,
saviamente opina che l’iscrizione e la statua del
prefetto Cuspio Pansa siano state collocate nell’anfiteatro
prima del tremuoto dell’anno 63, ed anche
prima della sospensione degli spettacoli ordinata da
Nerone nel 59.
Avanti d’entrare nell’arena, o sia nella gran piazza
de’ combattimenti e delle caccie, detta appunto arena,
dalla sabbia che vi era sempre sparsa, onde il sangue
che si versava dagli uomini e dalle fiere, a scanso
di ribrezzo, avesse presto a iscomparire, trovasi a
destra e a manca l’entrata in un criptoportico, o corridojo
circolare sotterraneo rischiarato da numerosi
spiragli, da cui per diversi vomitorj si ascendeva a’
[119]
gradini della prima e seconda cavea, dove sedevano
i magistrati e i più cospicui cittadini e i collegi.
Questo sotterraneo, che girava tutt’all’intorno dell’anfiteatro,
è degno di considerazione per la sua
forma intatta e per non riscontrarsi in alcun altro
anfiteatro. Le pareti di questo portico hanno tuttavia
iscrizioni scritte in rosso ed in nero, che accennano
a nomi de’ magistrati, forse benemeriti dei ludi
al circo, e leggonsene altre contenenti officiosità pel
loro indirizzo e tal altra eziandio che suona ingiuria,
o lode a talun combattente. Ho già notato come fosse
insito nel costume de’ Pompejani di dare sfogo ai sentimenti
proprj, esprimendoli sui muri delle case o di
qualunque altro edificio.
Ma eccoci nell’elissi dell’anfiteatro. Appena entrato,
io sperimentai, alzando la voce, l’eco che vi regna,
e che già rammentai al lettore quando dipingendogli
l’estrema catastrofe, affermai, come essa avesse contribuito
a rendere maggiore l’orrore della situazione.
L’arena, tutta recinta d’un parapetto, o podio dell’altezza
di circa due metri, sul quale alzavasi eziandio
un graticcio di ferro, per tutelare gli spettatori dal
furore delle fiere che, istigate dal combattimento,
avrebbero potuto gittarsi su di essi. Siffatto parapetto
era tutto dipinto a soggetti convenienti al luogo;
ma l’azione dell’aria ve li ha fatti tutti sparire.
Si rammenta da chi si trovò all’epoca della scoperta
di questo monumento, che fu il 16 novembre
[120]
1748[122], che fra tali dipinture una vi fosse che
raffigurava un lanista o maestro de’ gladiatori, che in
mezzo a questi, armato di bacchetta (rudis) era in
atto di giudicare cui spettasse colla vittoria nella
lotta il premio del vincitore, sul quale svolazzavano
due genii alati recanti corone nelle mani.
Ma non si smarrirono le iscrizioni, che nel parapetto
stesso si lessero, dedicate a memorare i nomi
di que’ magistrati che meglio avevano contribuito
alla restaurazione dell’anfiteatro, rifacendo i cunei e
riparando le altre rovine, che erano stati altresì i sovrintendenti,
o prefetti degli spettacoli.
Eccole, quali sono riferite dalle Guide e dagli illustratori
di Pompei.
MAG . PAG . AVG . F . S . PRO . LVD . EX . D . D .
T . ATVLLIVS . C . F . CELER . II . VIR . PRO . LVD . LV . CVN
C . F . C . EX . D . D
L . SAGINIVS . II . VIR . I . D . PRO . LV . LV . EX . D . D . CVN
N . ISTACIDIVS . N . F . CILIX . II . VIR . PRO . LVD. LVM
A . AVDIVS A . F . . RVFVS . II . VIR . PRO . LVD .
P . CAESETIVS . SEX . F . CAPITO . II . VIR . PRO . LVD . LVM
M. CANTRIVS. M F. MARCELLVS. II. VIR. LVD LVM CVNEOS. III F. C.
EX. D D.[123]
[121]
Importa che io qui traduca una nota che Bréton
appone a queste interessanti iscrizioni.
«Queste iscrizioni, scrive egli, presentano un
enigma assai difficile a sciogliere. Che vogliono esse
dire queste parole PRO LVD, pro ludis? Si è creduto
dover tradurre per i giuochi, e scorgere quindi
nell’iscrizione la menzione dei giuochi che venivan
celebrati nell’anfiteatro[124] da certi magistrati. Questa
interpretazione sarebbe stata accettabile, se nella
terza iscrizione non si trovassero le parole PRO LVD .
LVM . che il P. Garrucci legge pro ludorum luminatione,
per l’illuminazione dei giuochi, e Mommsen
pro ludorum luminibus; per i lumi dei giuochi. Questa
spiegazione non essendoci sembrata in tutto soddisfacente
noi abbiamo consultato uno de’ nostri
dotti colleghi, il signor Léon Rénier, noto per gli
studj speciali che ha fatti dell’epigrafia antica. I nostri
lettori saran lieti di trovar qui le sue risposte, delle
[122]
quali abbiamo creduto adottare le conclusioni così
ben motivate.
«L’interpretazione del P. Garrucci, e quella di
Mommsen, dice Léon Rénier, proverebbero, se si
fosse costretti d’attenervisi, che si davan dei giuochi
con illuminazione nell’anfiteatro di Pompei, ciò che non
mi pare da ammettere. Ecco come io interpreto il
passo dell’iscrizione: Marcus CANTRIVS, Marci Filius
MARCELLVS duum VIR PRO LVDis LVMinatione,
CVNEOS III Faciendos Curavit EX Decreto Decurionum.
PRO LUDis, LVMinatione, cioè in luogo dei
giuochi e dell’illuminazione, ch’ei doveva dare nell’occasione
della sua elezione alle funzioni di Duumviro.
L’elissi della congiunzione et non ha nulla che
debba sorprenderci: era essa di regola nello stile
epigrafico. (Ved. Morcelli, De Stylo inscr. p. 4486 ed.
Rom.) Gli onori municipali si pagavano ordinariamente
con giuochi, spettacoli, distribuzioni di sparsioni,
ecc.: spese improduttive che si scontravano talvolta
come qui, con altre spese equivalenti il cui
effetto era più durevole. In una iscrizione di Djemilah
(l’antica Colonia Cuiculitanorum), che io ho pubblicato
in una memoria che fa parte dell’ultimo volume
della Società degli Antiquari di Francia, si
vede un magistrato di questa città erigere una basilica,
in luogo d’uno spettacolo di gladiatori ch’ei doveva
dare. Si potrebbero citare molti esempi analoghi.
«Le interpretazioni del P. Garrucci e di Mommsen
[123]
sono affatto congetturali; la mia si appoggia sopra
esempj che mi sembrano concludenti. Il primo ne è
fornito da un’iscrizione di Roma edita dal Fabretti
Inscript. Domestic. p. 243 n. 556, e da Orelli p. 3324,
la quale termina così: POPVLO VISCERATIonem
GLADIATORES DEDIT LVMINAtionem LVDOS Junoni
Sospitæ Magnæ Reginæ SOLIS FECIT.
«Il secondo si trova in un’iscrizione della raccolta
di Muratori pl. 652. n. 6, nella quale si legge:
..... VS . SPORTVLAS ITEM FIERI ET
..... PVERIS NVCES SPARGI DIE Suprascripto ET
LVMINATIONE
«Quest’ultima iscrizione è un’iscrizione funeraria,
nella quale non v’ha questione nè di giuochi nè di
spettacoli, ciò che mi fa pensare che in quella dell’anfiteatro
di Pompei non vi sia connessità fra le
parole LVD e LUM; queste parole designano due
spettacoli differenti, che i nuovi magistrati dovevano
dare al popolo e da cui un decreto dei decurioni
gli aveva dispensati, loro imponendo l’obbligo di applicare
alla costruzione dell’anfiteatro una somma
almeno equivalente a quella ch’essi avevano così economizzata»[125].
Per quanto ragionate codeste conclusioni, non mi
so risolvere ad accettarle; perocchè fin quando io trovi,
come in questa iscrizione di Marco Cantrio, che cuneos
[124]
tres faciendos curavit, che, cioè, veggo menzionata
un’opera, allora ben posso spiegarmi il pro ludis del
modo che interpretò Rénier, vale a dire in sostituzione
dei giuochi; ma quando trovo il pro ludis come nell’iscrizione
M . OCULATIUS M . F . VERVS II VIR PRO LUDIS
che ho riferita nel Capitolo precedente del Teatro
Comico e che stava sulla soglia del medesimo in lettere
di bronzo, senz’altra indicazione che m’additi
cosa siasi dato o fatto in luogo dei giuochi, allora
mi è permesso di dubitare che l’interpretazione di
Rénier abbia sciolto l’enigma e di credere piuttosto
che possa intendersi il pro ludis, come magistrato
sopra i giuochi, cioè sovrintendente degli spettacoli.
E tanto più mi confermo in ciò, in quanto io non
abbia rinvenuto autorità che mi convinca che gli
spettacoli dati dai nuovi magistrati, fossero un verace
obbligo inerente alla loro nomina; anzi che una liberalità,
quantunque forzata, e che però potesse intervenire
decreto di decurioni a sostituire ad una spesa
obbligatoria un’altra spesa.
Ritornando ora alla difesa del podio, vuolsi osservare
come anche un canal d’acqua vi corresse lungh’esso;
onde così non fosse permesso alle fiere di
accostarvisi di troppo.
La cavea era regolata e distribuita del modo stesso
che accennai, parlando de’ teatri, nei capitoli antecedenti,
partita cioè in tre zone col mezzo di due gallerie.
[125]
La più bassa riserbata, come pur testè ho detto,
ai principali magistrati, ai capi della colonia, a’ sacerdoti
e sacerdotesse ed il posto che ognun d’essi occupava
sopra i gradini era circoscritto in due linee col corrispondente
numero distinto in rosso; e quel numero
doveva corrispondere alla tessera che si presentava
entrando all’impiegato denominato Locarius, o pigionante
di sedili. Il quale occupava prima i posti negli
spettacoli, o li accaparrava per cederli poi a chi giungesse
tardi, contro determinato prezzo.
L’affaccendarsi di costui era singolarmente per le
dame, imitate pur dalle moderne, che ultime sempre
giungevano allo spettacolo, trattenute dalle lunghe e
studiate toelette; onde il nostro Savioli, facendo allusione
nella sua Ode Il Teatro a siffatta consuetudine,
cantava:
Tardi ai roman’ spettacoli
L’altera Giulia venne,
Ma i primi onor del Lazio
Su l’altre belle ottenne.
Marziale, ne’ suoi epigrammi, parla di questi locarii
nel verso:
Hermes divitiæ locariorum[126];
ed io, tenendo conto di tali inservienti de’ pubblici
trattenimenti, addito origini di pratiche pur oggidì
[126]
sussistenti, e riconfermo il concetto del Savio, che
disse nulla essere nuovo sotto il sole.
Questa prima cavea dell’anfiteatro era divisa da
una precinzione di pietre di tufo dall’altra cavea superiore
e conteneva diversi muri traversali che ripartivano
il podio stesso. Così aveva quattro ripartimenti,
due verso le porte di cinque gradini, e due
altri nel mezzo del giro di quattro gradini assai più
larghi e spaziosi, aventi poi ognuno le proprie porte
separate.
La media, o seconda cavea era assegnata ai cittadini
distinti, e più agiati, ai diversi collegi e ai militari
ed aveva trenta gradini.
Termina finalmente colla summa cavea costituita di
diciotto fila di gradini ed era riserbata al popolo e
dietro di esso si collocava la plebe, dopo la quale, in
bell’ordine di archi sorgevano le logge per le donne,
che si formavano degli archi stessi sorretti da colonne,
alle quali logge, per essere coperte, Calpurnio
chiamò col nome di cattedre ne’ versi in cui rammenta
di aver dovuto ascendere fin su su nell’ultima fila dell’Anfiteatro,
per essere la infima e media cavea occupate
da magistrati e cavalieri:
Venimus ad sedes, ubi pulla sordida veste
Inter femineas spectabat turba cathedras,
Nam quæcumque patent sub aperta libera cœlo,
Aut eques aut nivei loca densavere tribuni[127].
[127]
Tutta la cavea ha quaranta scaglioni con altrettanti
vomitorj per i quali gli spettatori entravano ed
uscivano ordinatamente; solo le donne avevano una
separata gradinata onde accedere ai loro posti; lo che
dinota ancora un riguardo che a’ dì nostri non si
serba al gentil sesso ne’ teatri, e ciò malgrado che
allora fosse dal diritto romano considerata la donna
poco più di cosa, e adesso si pretenda che i costumi
illeggiadriti ne abbiano senza confronti migliorate le
condizioni.
Abbiamo già veduto nel precedente capitolo, come
a temprare agli spettatori del Teatro Tragico gli ardori
canicolari, fosse stato in Pompei e nelle altre città
della Campania, prima che altrove, immaginato il velario,
cagione di tanto scandalo a’ puritani scrittori di allora:
or bene l’Anfiteatro pompeiano usava esso pure
il più sovente di questa salutare costumanza. Dirò
di più: la distesa del velario era tanto desiderata e
voluta, che il Theatropola, od impresario di teatro, o
chi dava le feste, si affrettava, nel pubblico annunzio
che scrivevasi sui muri delle principali vie o de’
luoghi più affluiti di gente ad indicare che le vele
e le tende non sarebbero mancate. Ho già recato nel
[128]
capitolo nel quale parlai delle vie e degli affissi, quello
in cui Valente Flamine perpetuo di Nerone, avvertendo
che ai 28 marzo (V. Kal. aprilis) si darebbe
una caccia, si dà premura di soggiungere che vi sarebbero
i velarii, et vela erunt: ora, a meglio constatare
la buona usanza, ne recherò due altri.
Un Ottavio, od un Onesimo, procuratore, poichè gli
scrittori non sanno leggere che questi due nomi
sotto la lettera O della seguente iscrizione, così annunzia
una caccia, venatio, che darebbe a’ 29 di ottobre
la famiglia gladiatoria di Numerio Popidio Rufo,
che a’ 20 Aprile si alzerebbero le antenne, mala, ed
i velarii, vela, nell’anfiteatro.
N . POPIDI
RVFI . FAM . GLAD . IV . K . NOV . POMPEIS
VENATIONE ET . XII . K . MAI
MALA . ET . VELA . ERVNT
Q . PROCVRATOR . FELICITAS .[128]
Si argomenta da tale avviso che i velarii si rizzassero
nell’anfiteatro appena che il caldo incominciasse
vivamente a farsi sentire e a dar fastidio la sferza
del sole e che, se si credeva avvertire una caccia gladiatoria,
ancorchè lontana, perchè più spettacolosa,
non toglieva che prima si facessero altri minori divertimenti
nell’anfiteatro; senza di che non avrebbe
[129]
senso il dirsi che si rizzerebbero antenne a vele nell’aprile,
per una caccia che dovesse seguire sei mesi
nell’ottobre.
L’altro manifesto che si lesse su d’un muro della
Basilica si esprime così:
N . FESTI AMPLIATI
FAMILIA . GLADIATORIA . PVGNA . ITERVM
PUGNA . XVI . X IVN VENAT . VELA.[129]
Or bene, nel cornicione dell’anfiteatro sì avvisano
ancora alcune pietre aventi dei fori, ne’ quali si infliggevano
le aste od antenne (mali, o mala come è
scritto nella surriferita iscrizione) a cui venivano
raccomandati i capi del velario e le funi che lo sostenevano.
Abbiam veduto superiormente come alle due estremità
della elissi dell’anfiteatro vi fossero due porte:
noterò ora che un’altra più piccola ve ne fosse, la
quale era detta Libitinense, il cui scopo avverrà di conoscere
più avanti, parlando de’ gladiatori.
Per questa porticina entravano poi le bestie feroci,
le quali, per l’angustia di essa, non avrebbero potuto
ritornare indietro o volgersi dai lati. Una cameretta
vi è presso, forse lo spoliario, luogo nel quale i gladiatori
uccisi venivano spogliati delle loro armi e
delle loro vestimenta, come troviam ricordato in
[130]
Seneca ed in Lampridio[130]: in essa si trovarono
le ossa d’un leone. Questa circostanza e l’altra che
già ricordai di eguali avanzi di leoni rinvenuti nelle
vicinanze avvalorano l’affermazione di chi scrisse
che il cataclisma sorprendesse i Pompejani intenti
ai giuochi dell’anfiteatro. Per lo meno ci provano che
recenti ne dovessero essere stati i divertimenti.
In quanto a me, non sono alieno del dividere l’opinione
di coloro che osservarono che il novissimo
giorno fosse pure un dì a’ ludi circensi destinato,
confermandone altresì il fatto d’essersi trovati verso
l’ingresso e ne’ corridoi dell’anfiteatro sei scheletri,
a fianco di essi due braccialetti, due anelli, una moneta
ed altri frammenti d’oro, quattro belle monete
di bronzo, un involto di drappi ed una lampada.
Perchè avrebbero dovuto rinvenirsi questi scheletri
e questi oggetti in luogo ordinariamente chiuso,
oltre che all’estremità della città, se non per essere
stato in quel giorno aperto a pubblico divertimento?
Non si potranno ad ogni modo per questi dati abbastanza
significanti, avere per sognatori coloro che
la detta opinione sostennero.
Altre piccole camere vi sono ai lati delle due porte
principali ed erano i cataboli, o stalle in cui le belve
attendevano d’essere lanciate nell’anfiteatro.
[131]
Finalmente chiuderò la descrizione dell’anfiteatro
pompejano col far cenno del triclinio, che di contro
al principale ingresso di esso si vede. Era uso presso
gli antichi che il giorno innanzi l’esecuzione dei condannati
a morte si imbandisse loro un publico banchetto,
chiamato libero. In cotale occasione si largheggiava
ad essi di ogni ricercata vivanda. Chateaubriand,
che di tal costume favella ne’ suoi Martyrs,
non può trattenersi dallo scagliarsi contro di esso, come
di raffinamento della legge e come brutale clemenza
del paganesimo; l’una, perchè voleva rendere la vita
cara a quelli che dovevano perderla; l’altra, che non
considerando l’uomo che fatto per i piaceri, ne lo
voleva colmare nel mentre che spirava. Anche i gladiatori,
devoti a morte, poichè non avvenisse mai
che talun d’essi non restasse sull’arena, avevan diritto,
prima del giorno dello spettacolo, a questo
publico pasto. Era poi nella piazza cinta di muro, in
prossimità al triclinio, che i gladiatori attendevano
l’ora di entrare alla lotta nell’anfiteatro.
Ora poichè conosciamo il luogo che in Pompei
serviva d’arringo a’ giuochi circensi, e coll’anfiteatro
di questa città, possiam dire di conoscere quelli
pure delle altre e anche quello più famoso di Roma;
passiamo a trattare de’ ludi, che più frequentemente
solevano celebrarsi in essi, e delle persone che vi pigliavano
parte.
I più consueti e desiderati spettacoli dell’Anfiteatro
[132]
erano le corse, che prima si facevano, come già vedemmo,
nel Circo; i ludi gladiatorj e le cacce, che son
le venationes che abbiamo in più affissi veduto annunziate
in Pompei. Le danze, le pantomime, i canti e i
suoni dei tibicini e dei fidicini erano divertimenti
minori a’ quali prestavasi bensì l’anfiteatro, ma piuttosto
a riempire gli intermezzi e ad illudere l’impazienza
del publico che stava attendendo i principali
spettacoli annunziati, anzi che a costituire di per sè
un vero trattenimento.
Le Corse, o fazioni degli Auriga, il lettore s’è accorto
essere state introdotte fin dai primordj di Roma, per
aver io al principio ricordato il giuoco de’ Trojani: il
qual non fosse infatti che un armeggiamento a cavallo.
Molto più in onore in Grecia erano tenute le
Corse, dove i vincitori ne’ giuochi olimpici vennero
consegnati alla immortalità dagli inni di Pindaro.
Colà, per responso della Pizia, a’ siffatti giuochi annettevasi
la salute della Grecia. Furono perfino misurate
le epoche dalle olimpiadi, ogni olimpiade essendo
lo spazio de’ quattro anni che scorrevano fra due
celebrazioni de’ giuochi olimpici. Dall’una all’altra olimpiade
si contavano cinque anni, benchè non fossero se
non se quattro compiuti. Presso gli storici la prima olimpiade
comincia nel 776 prima di G. C. e 24 avanti
la fondazione di Roma. Dopo la 340.ª olimpiade, che
finì coll’anno 440 dell’Era Volgare, più non si trovano
gli anni calcolati per mezzo delle olimpiadi.
[133]
Or si fu nella vigesima quinta olimpiade che presso
quella nazione ebbe luogo la corsa del carro a due
cavalli; nella ventottesima quella dei cavalli da sella;
nella novantottesima corse con due cavalli da maneggio
nello stadio, e nella susseguente si attaccarono
ad un carro due giovani puledri condotti a mano ed
un’altra corsa di un puledro montato a guisa d’un cavallo
da sella.
In Roma e nelle città italiane, dove massime negli
ultimi tempi della republica ed in quelli dell’impero
si grecizzava, era più che ovvio che que’ giuochi si
importassero con quelle discipline e seguissero nel
circo dapprima e poi nell’anfiteatro e s’introducessero
le corse dei cocchi o de’ carri, currus, detti anche
bighe se tirate da una coppia di cavalli, quadrighe
se da quattro. Dione nel lib. XXIX, cap. 28, parla
delle corse dei cavalli che fecero parte dei giuochi
famosi che diede Pompeo e de’ quali dirò ancora più
avanti.
Le fazioni degli auriganti che si vennero presto
istituendo e le quali aspiravano alla palma nei ludi
circensi, erano quattro in Roma, distinte dal vario colore
delle vestimenta loro, cioè verde, ceruleo, rosso
o bianco, onde appellavansi Prasinæ, Venetæ, Russatæ,
Albatæ. Svetonio ne fa sapere essersene di poi
aggiunte altre due, l’una di stoffa aurata, e l’altra
di panno porporino. I principi perfino si onoravano
d’esserne i capi; così Caligola della Prasina, Vitellio
[134]
della Veneta. I guidatori (agitatores) montarono in
prezzo e i poeti li celebrarono, come ne fanno fede,
oltre que’ di Marziale, anche i vecchi epigrammi di
M. Aurelio Dione, di Diocle, di Pompeo Eusceno e
di Fuseo. Così rimasero ricordati i nomi di Incitato
caro a Caligola, di Prasino caro a Nerone, di Passerino
e Tigri diletti a Domiziano e di Scorpo a
Nerva; del quale Scorpo dettò Marziale il seguente
pomposo epitaffio:
Ille ego sum Scorpus, clamosi gloria Circi
Plausus, Roma tui deliciæque breves:
Invida quam Lachesis raptum trieteride nona,
Dum numerat palmas, credidit esse senem[131].
L’interessamento generale, la division delle opinioni,
il parteggiar di tutti per questa o quella fazione
d’auriganti, e le scommesse furon tali e tante,
che parve fino un delirio. Giovenale così della fazion
Prasina attesta la propria simpatia e predilezione:
Totam hodie Romam circus capit et fragor aurem
Percutit, eventum viridis quo colligo, panni[132];
[135]
e più tardi a’ tempi di Giustiniano, per la contenzione
delle fazioni Prasina e Veneta, tanta nacque sedizione
in Bisanzio che il monaco Zonara, nel suo libro
Degli Imperatori Greci, scrisse essersene occasionata
la strage di quasi quarantamila uomini; d’onde poi
si avesse ad abolire la designazione delle fazioni.
I vincitori nelle corse de’ giuochi circensi, proclamati
per tali dal Pretore, come ne ammonisce Giovenale
in que’ versi:
. . . . similisque triumpho
Præda caballorum Prætor sedet[133],
uscendo dalla porta trionfale del circo fra le ovazioni
frenetiche del popolo, colle palme raccolte e della
corona di lentischio recinta la fronte, spesso assisero
conviva alla mensa imperiale.
Passo rapido ora da questo subbietto, perocchè fosse,
a mio sentimento, mal propria l’arena dell’anfiteatro
pompeiano a siffatto genere di ludi, e vengo invece
più distesamente a dire de’ gladiatorj, che tutto attesta
essere stati assai frequenti in Pompei.
Ed è a questo punto ch’io pongo dapprima la
descrizione del Ludo Gladiatorio che esisteva e che
venne discoperta dagli scavi in Pompei.
Ma non pensi il lettore ch’io m’intenda parlare di
quella taberna, che da parecchie Guide vien detta la
[136]
Scola dei Gladiatori, la quale fu scoperta il 12
aprile 1847 ed a cui valse un tale titolo unicamente perchè
nell’esterno di essa si trovò un’insegna dipinta
che rappresentava un combattimento di gladiatori.
L’angustia di questa esclude assolutamente ch’essa
potesse servire allo scopo al quale si vorrebbe destinata,
poichè la scuola de’ gladiatori suppone che abbia
un locale atto all’esercizio della scherma e capace di
contenere, oltre i duellanti, anche il lanista, o loro
maestro. Ora una tale taberna non era atta a tanto.
Più probabile è invece ch’essa appartenesse a qualche
theatropola, o impresario di pubblici spettacoli, il
quale vi tenesse ricapito per la vendita delle tessere
teatrali, o per l’allestimento dei ludi o per l’ingaggio
dei gladiatori. Tale insegna, comunque difesa da un
piccolo tetto, è pressochè tutta omai cancellata: sotto
di essa vi si lesse in addietro la seguente iscrizione:
ABIAT (HABEAT) VENERE (VENEREM) POMPEIIANA (M) IRADAM (IRATA)
QVI HOC LAESERIT[134].
Queste scorrezioni di dizione ci rivelano però il linguaggio
volgare e l’approssimazione fin d’allora all’italiano.
Ma del resto farò osservare che il soggetto dell’insegna
non può in alcun modo forzarci a ritenere a
qualunque costo che la taberna dovesse aver un’attinenza
[137]
coll’arte gladiatoria e con ispettacoli, da che
sembri che il combattimento di due gladiatori fosse
tema assai frequente delle insegne, se Orazio, nella
satira settima del Lib. 11, potè lasciare scritto:
. . . . . atque ego, cum Fulvi, Rutubæque,
Aut Placideiani contento poplite miror
Prœlia, rubrica picta aut carbone: velut si
Re vera pugnent, ferient, vitentque moventes
Arma viri[135].
Il Ludo Gladiatorio piuttosto e veramente, a quante
le ricerche diligenti fatte hanno condotto a ritenere,
è quell’edificio al fianco orientale del Foro triangolare,
del quale parlando, ho già mentovato, che per tanto
tempo si continuasse a designare per quartiere di soldati.
Tale designazione non era stata, siccome avvenne
di tanti altri edifici di Pompei, determinata dal capriccio,
ma sì dall’esservisi trovate alcune armature e
ceppi entro i quali costrette ancora le ossa dei piedi
di varii scheletri, che s’era supposto essere stati di
soldati in punizione, i quali erano stati sorpresi dalla
estrema eruzione del Vesuvio e dalla finale catastrofe
[138]
senza potersi svincolare da essi. Questi ceppi si conservano
al Museo Nazionale di Napoli e costituisconsi
di una lunga e duplice barra di ferro, avente ad
eguali intervalli venti perni rialzati che sulla cima
finiscono in anelli. Tra l’uno e l’altro di questi perni
il colpevole doveva collocare i piedi, che vi venivano
serrati da un ferro traversale, che passava per quegli
anelli, ed a fianco stava la serratura a chiave che assicurava
un tal ferro.
In tutto questo edificio, scoperto nel 1766 e completamente
sbarazzato nel 1794, si contarono al momento
delle prime indagini, non meno di sessantatrè
scheletri e si è questo considerevole numero di scheletri
che farebbe persistere taluno scrittore, — cui pare
improbabile che una città di non molta importanza
per popolazione come Pompei potesse contare un
numero sì forte di gladiatori, — a voler ravvisare in
questo edificio una caserma di soldati; tanto più che
una piazza forte come questa dovesse invece avere
una guarnigione e per conseguenza una appropriata
caserma.
Ma il P. Garrucci stabilì in una sua memoria, inserita
nel tredicesimo numero del Bollettino Archeologico
Napoletano del gennaio 1823, che quest’edificio
non potesse essere che un Ludo de’ gladiatori. Nè
del resto può sembrare improbabile in Pompei il
numero suddetto di gladiatori, da che si avverta, e noi
l’apprendemmo dalle iscrizioni che riprodussi, come
[139]
l’epoca dell’ultima eruzione che seppellì Pompei coincidesse
colla stagione ordinaria degli spettacoli più
strepitosi dell’anfiteatro, e che doveva pur esser
quella in cui i più doviziosi romani, che possedevan
ville nel delizioso golfo napolitano, solevano ritrovarsi
nelle loro villeggiature. D’altronde se la questione
numerica della popolazione dovesse essere
non solo un irrecusabile argomento, ma ben anco
un semplice argomento od una seria congettura, non
si saprebbe, per egual titolo, trovar la ragione d’essere
del vasto anfiteatro. Ma ho già notato invece che
agli spettacoli di Pompei intervenissero pure dalle
vicine terre e castella e, i fatti storici alla mano, ciò
si è incontrovertibilmente da me stabilito.
Questo Ludo adunque è un vasto parallelogramma,
nel quale i gladiatori venivano istruiti a combattere
da un lanista o maestro di scherma. Era questi o
il proprietario d’una compagnia di tali uomini, che li
locava a chi volesse offrire uno spettacolo gladiatorio;
od anche solo l’istruttore de’ gladiatori appartenenti
allo stato, e perciò detti cæsarei. Tale parallelogramma
era tutto circondato di portici e d’architettura dorica
a due piani, sostenuti da sessantaquattro colonne di
tufo rivestite di stucco e scannellate nella parte inferiore.
Nel giro del portico terreno vi sono molte camere,
ed in quelle verso il lato occidentale si trovarono i
suddetti istrumenti di punizione. Nell’interno del
[140]
portico, sulle colonne e nelle camere erano graffite
parecchie iscrizioni, fra le quali è riportata da tutti
e non per anco decifrata con soddisfazione, e per me
affatto di colore oscuro, la seguente:
VHI . K . FEBR .
TABVLAS POSITAS
IN MVSCARIO
CCC . VIIII . SS . CCCC . XXX .
Dal pianterreno si ascendeva per mezzo d’una
scala in angolo presso le camere ad uso di prigione
al piano superiore. Non fa ora all’argomento mio di
tener conto degli oggetti, fra’ quali molti muliebri,
qui rinvenuti negli scavi: perocchè debba affrettarmi
ad entrare più spiccio nel tema di questi gladiatori.
Roma aveva parecchi di questi ludi, e furon noti il
Ludus Gallicus, il Dacicus, il Magnus, il Mamertinus,
l’Æmilius. A questi non eran preposti soltanto i lanista
ma de’ procuratores, tratti dalle classi cittadine più
distinte, ed avevano inoltre proprj medici e chirurghi
per curarne l’esistenza e la prestanza, come farebbesi
di polli che si vengano nutricando per le delizie
de’ banchetti. Tacito però non a torto chiamò il
ludo sagina gladiatoria[136], ingrassamento gladiatorio. Nè
meno celebri furono i ludi di Capua e di Ravenna;
dal primo eruppe Spartaco e sappiam com’egli fosse
il capo della rivoluzion servile: al secondo, di proprietà
[141]
dello stato, appartiene il Gladiatore che è il
protagonista della bella tragedia dell’Halm, tradotta
dall’egregio prof. dott. Giuseppe Rota, d’alcun brano
della quale, a chiarimento del mio soggetto, infiorerò
tra poco queste pagine.
Quale si avessero origine i Gladiatori, esporrò
sotto brevità.
I funerali e la religione li produssero. Gli Etruschi
gli usarono ne’ funerali, essendo loro credenza che l’anime
de’ morti coll’uman sangue si propiziassero.
Epperò i captivi di guerra, gli schiavi tristi e colpevoli,
comperati, si immolavano nelle funebri pompe.
Dagli Etruschi venne il costume a’ Romani, prima
però che a questi, passò con determinate modificazioni
ne’ riti, a’ popoli della Campania.
Fu nell’anno 490 della fondazione di Roma, che
Marco e Decimo Bruto offersero pubblicamente in
Roma nel Foro Boario spettacolo di gladiatori, in occasione
della morte di Giunio, loro padre: i tre figli di
Emilio Lepido, augure, ne fecero lottare undici coppie
nel foro per tre giorni, poi venticinque i figliuoli di
Valerio Levino; indi crebbero vieppiù. Già vedemmo di
Lucio Silla, come i ludi gladiatorii ordinasse per testamento
nelle sue esequie. Cesare, in memoria della
figlia, ne presentò seicentoquaranta; Tito, delizia del
genere umano, continuò tali conflitti per cento giorni;
il buon Trajano, l’amico di Plinio, per centoventitrè,
offerendo duemila combattenti.
[142]
Nè fu più ragione il funerale o la religione soltanto
a siffatti spettacoli; ma i gladiatori si diedero
ben anco a semplice titolo di divertimento, e i magistrati
primarj entrando in carica, a ingrazianarsi il
popolo, glieli offrivano a spettacolo; onde perfino tale
divertimento stesso gladiatorio si appellasse munus,
sia che intender si volesse dato gratuitamente, sia
perchè dato per l’officio.
È fatto menzione da Svetonio, nella vita di Claudio,
come questo Cesare, prima di disseccare il lago Fùcino,
vi volesse dare uno spettacolo di naumachia, e
che i gladiatori che vi dovevano combattere, passando
prima d’innanzi all’imperatore gridando: Ave, Imperator,
morituri te salutant: — Salve, o Imperatore, que’ che
vanno a morire ti salutano, — Claudio lor rispondesse:
Avete vos, — state sani; ond’essi, il saluto interpretando
come un perdono e una dispensa dal battersi, più
non volessero infatti pugnare; tal che Claudio, indegnato,
rimanesse in forse se farli tutti perire di ferro
e di fuoco; ma poi lanciandosi dal suo seggio e girando
intorno il lago d’un passo tremante e ridicolo,
un po’ con minacce, un po’ con promesse, li obbligasse
a combattere.
Era dunque una vera frenesia per codesti giuochi
e così fu spinta, che tali combattimenti diventarono
presto un mestiere, e il popolo sovrano a pagarli e
fin le dame a carezzarne i campioni.
Or chi erano questi sciagurati che mettevano a
prezzo il loro sangue, la loro vita?
[143]
Due specie vi avevano di gladiatori: la prima di
coloro che venivano astretti ad assumere siffatto mestiere;
l’altra di coloro che volontariamente lo esercitavano.
Venivano essi, cioè, della prima specie,
trascelti fra diverse classi della società, o erano
schiavi che a tal uopo vendevansi o prigionieri di
guerra, che dopo aver servito a decorare i trionfi de’
comandanti vittoriosi, riservavansi ai pubblici giuochi;
o finalmente colpevoli di crimini o condannati
per causa di ribellione.
Tuttavia accadde, — ed ecco come avvenisse che vi
fossero atleti della seconda specie, — che si vedessero
scendere ne’ circhi a combattere co’ gladiatori anche
liberi cittadini, sia che fossero spinti a così degradarsi
dall’ingordigia del danaro, ed appellavansi auctorati,
sia che fossero mossi da una stolta ambizione.
La degradazione era necessaria conseguenza della
professione da chiunque venisse essa abbracciata;
perocchè, comunque liberi, questi auctorati erano tenuti
ad un solenne giuramento, che ben valeva una
verace schiavitù. La formula di tal giuramento si può
leggere nei frammenti di Petronio Arbitro: In verba
juravimus, uri, vinciri, verberari, ferroque necari, et
quidquid aliud Eumolpus jussisset: tanquam legitimi gladiatores,
domino corpora animosque religiosissime addicimus[137].
Essere uccisi dal ferro, cioè, quando cadevano
[144]
vinti che dovevano allora sommettersi all’ultimo e
mortale colpo del vincitore; abbruciati o flagellati,
quando avessero timidamente pugnato o si fossero
vilmente sottratti al ferro. A questo fine nell’arena e
sulla scena erano sempre i Lorarii, o Mastigofori
altramente detti, schiavi destinati ad infliggere loro le
summentovate pene.
Erano inoltre diverse le classi de’ gladiatori. V’erano
i secutores, inseguitori addestrati a combattere coi retiarii,
prendendo il nome dal modo onde inseguivano
l’avversario, che avendo tentato di gittar su di essi
la sua rete, senza esservi riuscito, era costretto fuggire,
finchè gli fosse dato di ricuperar la rete, di cui
si valeva. Così sappiamo de’ retiarii, altri gladiatori
che, oltre la rete colla quale cercavano avvolgere i secutores,
erano pure armati d’un forcone a tre rebbi, tridentes. — Myrmillones
chiamavansi que’ gladiatori che
ponevansi a pugnare contro i retiarii o contro i Traci,
thraces, gladiatori pur questi armati di coltello con
arma ricurva, come Spartaco che vuolsi appunto nativo
di Tracia, che combattevano alla foggia del loro
paese. I Myrmillones portavano l’elmetto gallico con
l’immagine d’un pesce per cresta. In una tomba presso la
porta Ercolano in Pompei si trovò scolpita una figura di
[145]
essi. Giovenale così delle prime tre sorta di gladiatori fa
cenno, staffilando i nobili degenerati del suo tempo,
che spudoratamente a questo infame mestiere si erano
dati.
. . . hæc ultra quid erit nisi ludus? Et illud
Dedecus Urbis habes: nec mirmillonis in armis
Nec clypeo Gracchum pugnantem, aut falce supina
(Damnat enim tales habitus; sed damnat et odit):
Nec galea frontem abscondit: movet ecce tridentem,
Postquam librata pendentia retia dextra
Nequidquam effudit, nudum ad spectacula vultum
Erigit et tota fugit agnoscendus arena.
Credamus tunicæ, de faucibus aurea quum se
Porrigat, et longo jactetur spira Galero.
Ergo ignominiam graviorem pertulit omni
Vulnere, cum Graccho jussus pugnare secutor[138].
[146]
Gli scavi di Pompei offersero del pari, in un basso rilievo
in istucco su d’una tomba, la figura d’un’altra specie
di gladiatori, detti Samnites, la cui origine ci è svelata
da Tito Livio in quel passo cui già accennai nel
capitolo della Storia: Campani odio Samnitium gladiatores
eo ornatu armarunt, samniticumque nomina appellarunt[139].
Questi Sanniti credesi anche si chiamassero col nome
di hoplomachi, se pure non fossero designati con questo
nome altri differenti atleti: ed erano essi gladiatori
codesti che pugnavano armati da capo a’ piedi.
Essedarii dicevansi coloro che combattevano dall’essedo,
veicolo da me già spiegato nel capitolo Le Vie;
Andabati quelli che battevansi sui cavalli; Dimachœri
che usavano di due gladii, o spade; Laquearii che
cercavano abbattere il proprio competitore col laccio;
Supposititii o surrogati, che subentravano al gladiator
vinto, misurandosi col vincitore per contendergli la
definitiva vittoria; Pegmares quelli che servivano
nell’anfiteatro a subitanee trasformazioni, da pegma
ch’erano appunto macchinismi scenici; Postulatitii
coloro ch’erano dati nello spettacolo in soprappiù
del numero regolare indicato nell’annuncio, a fine
di soddisfare la richiesta (postulata) del publico; e
[147]
Meridiani, finalmente, certi gladiatori armati alla leggiera,
che combattevano per modo d’interludio, a mezzo
giorno, dopo terminati i combattimenti colle fiere.
Nè certo ho con questi menzionati i nomi tutti
delle tante specie di gladiatori, che nella frenesia di
que’ spettacoli si vennero studiosamente immaginando.
Più tardi adunque, come già ci avvertirono i succitati
versi di Giovenale, superando ogni ritegno e pregiudizio,
scesero nell’arena cavalieri perfino e senatori.
Come s’è veduto avvenire che uomini dell’ordine
equestre montassero la scena sotto di Giulio Cesare;
fu pur sotto di esso che in Roma primi obliassero
il decoro del loro ordine Furio Leptino e Aulo Caleno,
senatori; ma rotto il freno e precipitando ognor più la
pubblica moralità in basso, si vedevano offerirsi a indecente
e brutto spettacolo di nudità e di degradazione
nel circo nani e pigmei, donne e fra queste
anche matrone.
Il perchè Giovenale così flagella l’inverecondo costume:
Endromidas Tyrias et femineum ceroma
Quis nescit? vel quis non vidit vulnera pali?
Quem cavat assiduis sudibus scutoque lacessit,
Atque omnes implet numeros, dignissima prorsus
Florali matrona tuba; nisi si quid in illo
Pectore plus agitat, veræque paratur arenæ.
Quem præstare potest mulier galeata pudorem
Quæ fugit a sexu? Vires amat[140].
[148]
Pare, ed a ragione, così di troppo conculcata la
dignità umana; ma che si dirà dinanzi il fatto di
Nerone che fe’ pugnare in un giorno nell’Anfiteatro
40 senatori e 60 cavalieri? Dopo l’umiliazion della
donna, succedeva quella dell’autorità. Che rimaneva
omai di venerando e sacro?
Quelli nondimeno che fra tutti costoro destavano
maggior pietà, erano indubbiamente i prigionieri di
guerra, ai quali Tertulliano concede l’epiteto d’innocenti,
per distinguerli da’ gladiatori di mestiere.
Nessuna guerra, dice Giusto Lipsio, non fu giammai
più distruttiva pel genere umano quanto i giuochi
del circo. Infatti si sa da Plinio il Giovane che fin da’
suoi tempi e da lui e da altri prestantissimi uomini
se ne gridasse all’abolizione.
L’universale delirio per questi giuochi giadiatorj,
l’affluenza del pubblico, l’intervento del principe e
[149]
de’ magistrati, la descrizione di queste pugne e l’interessamento
dovunque ad esse per parte d’ogni classe
di persone, non escluso il sesso che suolsi appellare
gentile, io dirò meglio colla viva dipintura che ne
fa l’illustre poeta tedesco Federico Halm, ossia, per
togliergli il velo della pseudonimia lacerato non ha
guari da morte, il barone Münch Bellinghausen, nella
sua tragedia Il Gladiatore di Ravenna, la quale abbiamo
la fortuna d’avere egregiamente recata in italiani
versi da quel chiarissimo letterato che è il prof. dottor
Giuseppe Rota:
Allor che Roma pompeggiando lieta
Come a festivo dì tutta s’adorna,
E Cesare e il Senato e i cavalieri
In solenne corteo traggono al circo,
Onde gli spazii smisurati occupa
Di figure e di voci all’ondeggiante
Pelago fragoroso; allor che al cenno
Aspettato di Cesare le sbarre
S’aprono ai combattenti e un tal silenzio
Sorge improvviso che nessun più vedi
Trar fiato, bocca aprire, o batter occhio;
Ed ecco il segno squilla, i colpi cadono,
L’uno innanzi si fa, l’altro retrogrado
Gitta all’elmetto del rival con rapido
Moto la rete, cotestui districasi,
Poi di nuovo s’intrica, i colpi accumula,
Poi percosso egli pur vacilla e sanguina,
Presenta il petto, anche cadendo, all’emulo,
Riceve il colpo e muore; e allor che i soniti
D’immensi plausi a quella vista scoppiano
Simile a folgor che scoscende nuvola,
E par la terra vacillar dai cardini,
Sull’ebbro capo al vincitore piovono
[150]
Rose e lauri a gran nembo, accenna Cesare
Del viva il segno e mille bocche il suonano
Al vincitor sì che vi echeggia l’aere....[141]
Quando un gladiatore aveva ferito il suo avversario,
gridava: habet, cioè l’ha tocco. Il ferito, gettando
l’arme allora, si portava presso gli spettatori, alzando
il dito per supplicare la grazia. Dov’egli avesse ben
combattuto, il popolo l’accordava premendo il pollice
e lo salvava: in caso diverso, od anche dove gli
spettatori non si sentisser disposti a di lui favore,
essi abbassavano il pollice e il gladiatore vittorioso
imponeva senz’altro al vinto: recipe ferrum, ricevi il
pugnale, e questi veniva immolato. A tale barbarico
uso del popolo di abbassar il pollice perchè valesse
d’ordine al gladiatore vincitore di dar il colpo di
grazia, segando la gola al vinto, han tratto questi versi
dello stesso Giovenale nella satira terza:
Quondam hi cornicines et municipalis arenæ
Perpetui comites, notæque per oppida buccæ,
Munera nunc edunt, et verso pollice vulgi
Quem libet occidunt populariter[142]
Questo crudel decreto di morte osava, — tanta era
[151]
l’efferatezza dei tempi — la vergine vestale stessa
bene spesso pronunciarlo, come Prudenzio, De Vestalibus,
ce lo attesta:
. . . . . . . pectusque jacentis
Virgo modesta jubet, converso pollice, rumpi[143]
Stava tuttavia ne’ precetti dell’arte gladiatoria il
saper cader bene ed atteggiarsi pittorescamente nel
presentare la gola o il petto ond’essere trafitto dal vincitore;
e cosiffatto artificio poteva conciliar talvolta al
gladiatore il perdono della vita. Nella succitata tragedia
di Halm, ecco come Glabrione, rettore della
scuola gladiatoria in Ravenna, ciò rammenti a Tumelico,
il protagonista del componimento, insieme ad
altri consigli.
Non io di sferza
Nè di buone parole a te mi parco:
Tu dunque bada a farmi onor: m’intendi?
Impassibile mostrati e sicuro:
La coscïenza di vittoria è mezza
Già la vittoria: tieni gli occhi agli occhi
Del tuo rivale e dove intenda avverti
Pria ch’ei muova la man.
Nel caso....
Intendi ben.... ciò non sarà, ma pure
Esser potria.... nel caso che abbattuto,
Gravemente ferito.... egli è un supposto...
Tu ti sentissi, allor fa di cadere
Sovra il manco ginocchio e fuor protesa
La destra gamba e del sinistro braccio
Fatto puntello, declinato indietro,
Grazïoso a vedersi e pittoresco,
Statti aspettando il colpo estremo[144].
Talvolta il popolo era tanto feroce che dava tumultuosi
segni d’impazienza quando il combattimento
durava un po’ più dell’usato, senza che alcuno
dei due campioni fosse rimasto ucciso o ferito.
V’eran tuttavia degli intervalli di riposo in queste
lotte di gladiatori e si chiamavano deludia: Orazio
usò nell’Epistola XIX la frase deludia posco, per dire
chieggo un armistizio, togliendola a prestanza dallo
stile gladiatorio e dall’anfiteatro.
La presenza dell’imperatore faceva d’ordinario accordare
la vita al vinto, e fu ricordato come un esempio
di crudeltà il fatto di Caracalla, che a Nicomedia, in
uno spettacolo gladiatorio, avesse licenziato coloro che
eran venuti ad implorarne la vita, sotto pretesto
d’interrogarne il popolo; lo che si ritenne quanto
l’ordine di trucidarli.
[153]
Byron, l’immortale poeta del Corsaro, di Lara e
di Don Juan, nel Pellegrinaggio di Childe-Harold, dinnanzi
al capo d’opera di Ctesilao, il Gladiatore morente,
da lui veduto in Roma, e del quale Plinio il
Vecchio aveva detto che l’artefice vulneratum deficientem
fecit in quo possit intelligi quantum restat
animæ[145], così lo descrisse e gli prestò tal sentimento
da sembrare che le barbare orde settentrionali e le
sventure tutte piombate poi sull’Italia e Roma, non
altro fossero che la giusta espiazione del sangue
sparso da’ poveri e innocenti prigionieri di guerra
condannati in sollazzo pubblico a’ cruenti spettacoli
dell’Anfiteatro.
Così alla meglio tento di rendere in italiano i bellissimi
versi inglesi:
Ecco il vegg’io prostrato in sul terreno,
Colla man regge il capo il gladiatore:
Col guardo esprime, di fierezza pieno,
Ch’ei frena l’ineffabile dolore;
La testa piega e il lacerato seno
Geme l’ultime stille del suo core,
Che ad una ad una cadon lentamente
Come le prime di uragan fremente.
Romba l’arena intorno a lui..... ma spira
Prima che il plauso al vincitor suo cessi:
Egli lo intende e non per ciò sospira;
L’occhio ed il cor lungi di qui son essi;
[154]
La vittoria o la vita non l’attira,
Ma come avanti a lui li abbiano messi,
Vede il Danubio, la capanna e i suoi
Presso la madre folleggiar figliuoi.
Ed ei frattanto, a rallegrar le feste
Della superba Roma, è presso a morte....
Questo pensier si mesce a le funeste
Strette dell’agonia orrendo e forte....
— Ma non avran vendetta mai codeste
Supreme angosce?.... Or su, genti del Norte,
Su levatevi tutte e qui correte
Del furor vostro a soddisfar la sete.[146]
Nè la morte dell’infelice gladiatore bastava a calmare
bene spesso l’immane ferità del pubblico, perocchè
fosse accaduto che esso ingiungesse senza
pietà la ripetizione de’ colpi sui vinti e l’inferocir
contro i cadaveri, per tema di essere frodato dall’artificio
di simulata morte, come ce lo attesta Seneca:
injuriam putat quod non libenter pereunt[147]; nè
mancò talvolta chi osasse mettere la mano dentro
la ferita e perfino ne bevesse il sangue ancora caldo e
fumante, tratto da superstizioso pensiero che fosse a
certi mali, come l’epilessia, farmaco salutare e certo.
Il cadavere del gladiatore veniva tratto di poi, come
ricorda Lampridio nella Vita di Commodo, col mezzo
d’un gancio nella camera, che pur si vede nell’anfiteatro
[155]
di Pompei, la quale veniva detta lo spoliario:
gladiatoris cadaver unco trahatur et in spoliario ponatur[148].
Ogni anfiteatro poi aveva la porta Libitinense,
dalla dea Libitina, nel cui tempio custodivansi gli
apparati funebri, e da cui, collocati dentro la sandapila,
o bara, escivano, a spettacolo compiuto, i morti
corpi per trasportarsi al carnajo.
I gladiatori invece ch’erano riusciti vittoriosi nell’arena
ottenevano duplice premio: la palma e il denaro:
altri ne avevano pur dai privati, massime per le vinte
scommesse, e a tale crebbero che dovette il principe
intervenire a moderare le donazioni.
Ai veterani concedevasi la bacchetta, rudis, quasi
in segno di magistero: anche a’ nuovi era essa accordata
per alcun fatto cospicuo e per acclamazione di
popolo, impetrata spesso dal gladiatore medesimo.
Effetto della stessa era d’essere liberati nello avvenire
dall’obbligo della arena, e gli auctorati d’essere
restituiti alla prima libertà. Questi privilegiati della
bacchetta denominavansi Rudiarii; ed assolti da’ combattimenti
ulteriori, sospendevano le loro armi nel
tempio di Ercole, che si reputava essere il nume
che presiedeva ai gladiatori.
Un’altra razza di gente che offerivasi in ispettacolo
[156]
nel circo erano le Ambubaje. Oriunde queste della Siria,
o come qualche altro scrittore pretende, derivate
da Baja nel golfo di Napoli, onde avessero dedotto
il nome, perchè le donne di quel luogo, — celebre per
le sue terme, a cui nella state affluivano le eleganti
e lussuriose femmine dell’Urbe e gli uomini più
rotti alla scostumatezza, — solevano pur concorrere in
Roma ad esercitarvi la lascivia e sonando e cantando[149]
campavano la errabonda vita, suonando
cioè le tibie, e cantando ballate. La bellezza e procacità
loro, cui lo spettacolo aggiungeva rilievo e
prestigio maggiori, del modo stesso che ballerine e
mime pur oggidì sono meglio appetite da’ nostri
ricchi fanulloni, le rendeva ambite dalla libidine de’
facoltosi, cui e nel circo e in posti di pubblico ritrovo
si concedevano, ed a questa passione per esse allude
il seguente passo della Satira III di Giovenale,
che già ne occorse di conoscere come il pittore
più accentuato dei costumi romani del proprio
tempo:
Quæ nunc divitibus gens acceptissima nostris,
Et quos præcipue fugiam, properabo fateri;
Nec pudor ostabit. Non possum ferre qui vites,
Græcam urbem: quamvis quota portio faecis Achei?
Iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes,
Et linguam et mores et eum tibicine cordas
[157]
Obliquas, nec non gentilia tympana secum
Vexit et ad Circum jussas prostare puellas.
Ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra.[150]
Orazio, prima ancora di Giovenale, aveva le ambubaje
ravvolte tra la spregevole canaglia, nella Satira
II del Lib. 1.
Ambubajarum collegia, pharmacopolæ,
Mendici, mimi, balatrones; hoc genus omne
Mœstum ac sollicitum est cantoris morte Tigelli.
Quippe benignus erat[151].
[158]
Le quali Ambubaje vogliono essere distinte dalle
Ludie, che erano bensì donne che ballavano e recitavano
in pubblico, ma non nei circhi e anfiteatri,
sibbene nei teatri, come l’uomo ludius, che vedemmo
nell’antecedente capitolo. Ricordo per altro qui ancora
le ludie in altro senso, perchè più tardi infatti
esse significassero le mogli de’ gladiatori, essendo che
la scuola di costoro si appellasse, come ho già più
d’una volta notato, ludus. Giovenale ancora in questo
senso parla della ludia, nella Satira VI.
Dicite vos neptes Lepidi, coecive Metelli,
Gurgitis aut Fabii, quæ ludia sumserit umquam
Hos habitus?[153]
Un breve cenno or debbo fare dei giuochi Florali,
i quali si celebravano in Roma nelle Calende di marzo
di ciascun anno. Se può esser vero che non egualmente
si festeggiassero in Pompei, nondimeno, siccome
ho detto che lo studio di questa città ci trae a conoscere
la vita romana, parmi così non dover passare
sotto silenzio questi giuochi speciali, che nel quadro
dei giuochi circensi reclamano indubbiamente un
posto, per il forte rilievo che danno al degenere
costume di quel popolo.
I Sabini, da cui tanto dedussero di costumanze e di
[159]
riti i primi Romani, ebbero in onore il culto di Flora,
questa ninfa che, sposa a Zeffiro, ebbe da lui in dote
l’impero de’ fiori. Essi lo trasmisero ai Romani a’
tempi di Tazio loro re, e se la gentilezza e purità del
regno di questa Dea avrebbe dovuto informare i suoi
adoratori a leggiadri riti, vuol esser detto perchè invece
fossero essi in Roma non meno impudici ed osceni
de’ Lupercali, che per le sue vie in altro tempo venivano
celebrati in onore della Lupa, ossia della cortigiana
Acca Larenzia, con quel nome designata
per cagione de’ suoi sfrenati costumi, la qual raccolse
ed allattò Romolo e Remo.
Una cortigiana venuta di poi, denominata Flora, che
volle appropriarsi il nome d’Acca Larenzia, in memoria
della prima, chiamava erede de’ molti suoi beni, frutto
di sua vita sciupata, il popolo romano, il quale riconoscente
la collocò nel novero delle sue divinità, e le
eresse un tempio rimpetto al Campidoglio; onde avvenne
che, istituendosi a suo onore de’ pubblici giuochi
quali si dissero florali, venissero facilmente confusi
con quelli innocenti della prima Flora.
Invocata nelle intemperie delle stagioni, o quando
lo imponevano i libri sibillini, se ne celebravano i
giuochi, i quali poi nel 580 di Roma, in occasione
di calamitosa sterilità durata per molti anni, diventarono
annuali, per decreto del Senato.
Come i Lupercali, che ho testè ricordati, celebravansi
pure i Florali dapprima a notte al chiaror
[160]
delle faci, nella strada Patrizia, ove trovavasi un
circo di sufficiente grandezza. Quivi erano cantate
le più oscene canzoni; quivi cori di ignude cortigiane,
che con procaci movimenti compivano svergognate
le più ributtanti lascivie e si prostituivano,
plaudente il popolo, a uomini brutali che, parimenti
ignudi, si erano a suon di trombe precipitati nell’arena.
Narrano le storie come un giorno Catone, l’austero,
fosse comparso nel circo in occasione appunto che
stavano i giuochi florali per incominciare, perocchè
gli edili avessero già fatto dare il segno. La presenza
del gran cittadino impedì che l’orgia scoppiasse: le
meretrici, per reverenza si strinsero nelle vesti loro,
tacquero le trombe, il popolo ammutì. Chiedea Catone
onde sì improvvisa sospensione, e avutone in risposta
esserne causa la sua presenza, egli alzatosi prontamente
allora e recatosi alla fronte il lembo della toga,
uscì dal circo. Il popolo applaudì, caddero subito
le vesti alle sciupate, squillarono le trombe e lo
spettacolo ebbe il suo corso.
Fu per avventura ad una di queste feste, che, regnando
Nerone, venne offerto l’infame spettacolo nel
circo, che Svetonio ricorda e che Marziale fe’ subbietto
al sesto Epigramma del Lib. I. che basterà di
per sè a stigmatizzare il costume di quel tempo.
Iunctam Pasiphaën Dictaeo credite tauro,
Vidimus: accepit fabula prisca fidem.
[161]
Nec se miratur, Cæsar, longaeva vetustas:
Quidquid fama canit, donat arena tibi[154].
Per l’eguale ragione che mi parve dover intrattenere
il lettore de’ Giuochi Florali, credo qualche
parola consacrare eziandio agli spettacoli di Naumachia.
La circostanza d’essere Pompei città in riva al
mare, siffatti spettacoli davanti all’imponente maestà
della pianura equorea sarebbero apparsi così meschini,
da non eccitare interesse di sorta; e però non
posso ritenere che naumachie si tentassero mai nell’anfiteatro
pompeiano. La misura della sua elissi
non credo fosse tampoco propria a congeneri ludi.
Se tal sorta quindi di divertimento da magistrati
o doviziosi si fosse voluto dare, siccome d’altronde
per lo più gli spettacoli dati da costoro erano, come
vedemmo, gratuiti, avrebbero a teatro eletto il mare
stesso e con sicurezza di miglior effetto.
Non era così altrove e massime in Roma. Che le
naumachie fossero nei gusti de’ maggiorenti e del
popolo non può recarsi in dubbio; superiormente
trattando de’ Gladiatori, menzionai quella offerta da
[162]
Claudio sul lago Fùcino. Svetonio, nel dire di essa,
ricorda la particolarità che si vedessero l’una contro
l’altra urtarsi una flotta di Sicilia ed un’altra di Rodi,
composta ciascuna di dodici triremi, fra lo strepito
della tromba d’un tritone d’argento che un congegno
praticato nel mezzo del lago faceva a un tratto scattar
fuori[155].
Naumachia, derivanda dalle due voci greche ναῦς,
nave, e μαχη, pugna, esprime già di per sè il proprio
significato. A questi navali combattimenti si trovò
modo di dar luogo, facendo entrare ne’ teatri, a mezzo
di celati condotti, le acque, e così vi si poterono far
figurare mostri marini, flotte e simulate battaglie di
navi.
Lo Storico de’ Cesari summentovato fa cenno della
naumachia data da Nerone in Roma, dove pare si fosse
all’uopo eretto apposito luogo, ed anzi, se si vuole
stare a Frontino, nell’opera sua sugli Acquedotti,
sin cinque o sei naumachie si sarebbero contate nel
circondario di Roma. In quella adunque offerta da
Nerone si videro appunto nuotare nell’acqua marina
de’ mostri: exhibuit naumachiam, marina aqua innantibus
belluis[156]. Un’altra battaglia navale ne rammenta,
data nella vecchia naumachia da Tito, con
intervento di Gladiatori[157] ed una ancora offerta da
[163]
Domiziano[158]. Era forse di quest’ultima che Marziale
intese parlare nel 31 Epigramma del lib. degli spettacoli,
e la quale egli chiamò superiore a tutte le
antecedenti:
Quidquid et in Circo spectatur et Amphiteatro
Dives Caesarea præstitit unda tibi.
Fucinus et pigri taceantur signa Neronis:
— Hanc norint unam sæcula Naumachiam[159].
Il suddetto storico Svetonio attribuir vorrebbe ad
Ottaviano Augusto il vanto d’essere stato il primo
a dare ai Romani spettacolo di un finto combattimento
navale in un bacino scavato appresso al Tevere[160];
ma Servio, scoliaste di Virgilio, ne ammonisce avere
i Romani, al tempo della prima guerra Punica,
istituita la naumachia, dappoichè si fossero accorti
che le nazioni straniere avessero nelle pugne navali
non leggiero valore[161].
Ma forse prima d’Augusto queste naumachie potevano
limitarsi ad esercitazioni de’ classiarii, o militi
appartenenti alle flotte, nell’intento appunto di addestrarli
[164]
a’ navali combattimenti, e solo averli poi
questo Cesare ordinati a pubblico divertimento.
Ma basti intorno ad esse.
Or mi resta a parlare delle cacce di animali, venationes,
che si davano così spesso negli anfiteatri romani
e che sì frequenti pure ci dicono i surriferiti
affissi seguissero in quello di Pompei.
Desiderosi coloro che davano gli spettacoli di solleticare
con isvariate illecebre gli appetiti del publico, immaginarono,
a rendere più interessanti queste cacce, di
convertire l’Arena in selva, presentando, cioè, la più
illudente immagine delle cacce germaniche, che si
volevano arieggiare. Facevasi dunque a tale intento
sollevare ne’ boschi da’ soldati delle grosse piante
fino dalle radici e trasferire nell’Anfiteatro, dove
confitte nel suolo e assicurate con travi e sovrapposta
la terra si mutava l’arena in una foresta. Nè l’arena
così conformavasi soltanto, ma anche i cataboli, stanze
di custodia, da cui, come da antri e spelonche, sbucavano,
quasi da’ naturali lor covi, le fiere. La natura
era pertanto fedelmente imitata.
E quel che in Roma facevasi ed era in voga, afferma
Giusto Lipsio essersi nelle provincie subitamente
emulato, e le caccie dovevano però tosto adottarsi e
suscitare il più vivo interesse.
In due maniere si compivano queste cacce: o facendo
combattere fra loro le fiere, o facendole combattere
con gladiatori o con condannati. Eranvi però
[165]
delle volte in cui per la rarità dell’animale, che non
si voleva uccidere, limitavansi ad ammaestrarlo
facendolo passare avanti gli spettatori, o stretto in
catene, ovveramente chiuso in una gabbia. Le cacce
più consuete, perchè meno dispendiose, erano di
orsi e cinghiali. Erano straordinarie e di lusso quelle
di leoni, elefanti, pantere ed altre belve rare.
I combattimenti degli animali vorrebbe Seneca che
avessero luogo per la prima volta in Roma, nel settimo
secolo di sua fondazione, al tempo di Pompeo.
Questi medesimo, nella inaugurazione del suo teatro,
fece combattere nel circo gli elefanti, che Plinio dice
essere stati in numero di venti, e i quali diedero
tal prova d’intelligenza da destare perfino la compassione:
strana cosa in vero, da che non la sapessero
eccitare gli uomini in quel tempo! Così Cicerone
infatti parla di quelle feste scrivendone a Marco
Mario, alleato di sua famiglia:
«Per cinque giorni v’ebbero stupende cacce, e
chi lo nega? Ma un uomo serio qual piacere può
avere dal vedere o un uomo debole sbranato da una
fortissima belva, o una superba fiera trapassata da
un cacciatore? L’ultimo giorno comparvero gli elefanti,
di cui il volgo e la turba fecero le maraviglie:
ma voluttà non vi fu, anzi destò una tal qual compassione
e si pensò che quell’animale avesse una
cotale affinità colla stirpe umana»[162].
[166]
Ma Seneca nella summentovata sua sentenza è
smentito da altri non meno autorevoli scrittori. Tito
Livio, a cagion d’esempio, ne fa sapere che, fin dall’anno
568 della fondazione di Roma, Marco Fulvio
celebrasse giuochi che passarono famosi nella storia,
per compiere un voto fatto nella guerra d’Italia,
e ne’ quali si fecero combattere pantere e leoni: et
venatio data leonum et pantherarum[163].
Diciasett’anni dopo, cioè nel 585, gli edili curuli
P. Cornelio Scipione Nasica e P. Lentulo, per la guerra
contro Perseo, facevano combattere nei giuochi del
Circo sessantatrè tigri, e quaranta orsi ed elefanti.
Quinto Scevola, nel 689, fe’ combattere leoni; e Lucio
Silla, per la prima volta, due anni dopo, offrì combattimento
di cento leoni, della varietà che si chiamava
giubbata, o colla chioma non ricciuta.
Lucio e Marco Lucullo, essendo essi pure edili curuli,
nel 678, fecero combattere elefanti contro tori,
per aizzare i quali ultimi conveniva far uso del fuoco,
come Marziale ci avverte:
Qui modo per totam flammis stimulatus, arenam,
Sustulerat raptas taurus in astra pilas,
Occubuit tandem cornuto ardore petitus,
Dum facile tolli sic elephanta putat[164].
Passata questa caccia di tori, combattuta però dagli
[167]
uomini, come nelle altre provincie dell’orbe romano,
così eziandio nella Spagna, anche quando la
civiltà tolse affatto di mezzo questi barbari divertimenti,
essa non se ne volle disfare non solo, ma
tanto la smania delle caccie del toro si è innestata
al suo costume, che pure a’ nostri giorni si continui
tra la frenesia di pubblici entusiasmi, i plausi
e le dimostrazioni di leggiadre dame; e toreros e matadores,
picadores e banderilleros e tutto il gregge gladiatorio
insomma che partecipano a queste se la campano
egregiamente e son ben anco tenuti in conto. Si potrebbero
in oggi citare più nomi di celebri toreri,
come a Roma in antico si ripeteva da ognuno il
nome de’ più famosi gladiatori, conservati poi alla
memoria de’ posteri dagli storici e da’ poeti.
Ma rivengo a dire delle caccie romane.
Cento orsi della Nubia e cento cacciatori venuti
dall’Etiopia combatterono l’anno 693 per cura di Domizio
Enobarbo edile; e tre anni dopo, Marco Emilio
Scauro, tra’ vari altri giuochi circensi, quello spettacolo
offerì pure dello scheletro di enorme cetaceo, lungo
quaranta metri, più alto di un elefante indiano, che si
spacciò dai ciurmadori essere stato quello medesimo
al quale era stata esposta Andromeda: un ippopotamo,
[168]
che Plinio afferma essere stato il primo veduto
in Roma, di cinque coccodrilli e di centocinquanta tigri
di ogni specie.
Ritornando sulla caccia data agli elefanti sotto Pompeo,
che Plutarco dice essere riuscito uno spettacolo
di spavento, Dione Cassio reca le seguenti particolarità,
che piacemi riferire. «Si fecero combattere con
uomini armati 18 elefanti; gli uni perivano nel combattimento,
altri più dopo; perchè il popolo anche
in onta a Pompeo, ebbe pietà di alcuni, quando li
vide fuggire colpiti di ferite, percorrenti l’arena, colle
trombe dirette verso il cielo e mandando lamentevoli
grida: il che fece credere che essi non agivano così
per avventura, ma che attestavano coi loro barriti
la violazione della promessa fatta loro con giuramento
nel trasportarli dall’Africa, e che imploravano
la vendetta celeste. Si narra veramente che essi non
avessero consentito a salire sulle navi, se non dopo
che i conduttori ebbero loro promesso con giuramento
di preservarli da qualunque duro trattamento. Il fatto
è certo, o non l’è? È quanto ignoro.»
Del resto si sa, soggiunge Mongez, che tal passo
riporta pure in una sua memoria, di cui mi son
valso, che gli antichi credevano che gli elefanti avessero
un’anima intelligente, e tale opinione si è conservata
fra i popoli dell’India.
In questi giuochi da Pompeo dati per cinque giorni,
a solennizzare la dedica del suo teatro, fra le molte
[169]
fiere cacciate nel circo, oltre i suddetti elefanti, Plinio
ricorda seicento leoni, dei quali trecentoquindici giubbati,
e quattrocentodieci tigri d’ogni specie.
Giulio Cesare nel 708 volle superare nella magnificenza
de’ suoi giuochi quelli dati dal suo emulo e
mostrò per la prima volta in Roma le giraffe e i combattimenti
dei tori e fe’ comparire nel circo due eserciti
composti di fanti, di cavalieri e di elefanti. «Si
diedero cacce per cinque giorni, scrive Svetonio, e
per terminare lo spettacolo si divisero i combattenti
su due schiere composte ciascuna di cinquecento
fanti, di venti elefanti e di trecento cavalieri, si fecero
combattere gli uni contro gli altri»[165].
Succedutogli Augusto, a lui si volle dar vanto
d’aver fatto uccidere, a divertimento del popolo, tremila
e cinquecento animali.
Sarebbe lungo soverchio parlare degli animali nostrali
e addomesticati; ma si può argomentarlo dalla
passione che si aveva per tali divertimenti. Non lascerò
tuttavia di narrare come il più volte citato Plinio
abbia scritto che nei giuochi dati da Germanico si
vedessero alcuni elefanti moversi in cadenza a guisa
di danzanti[166]; Svetonio in quelli dati da Galba
comparissero elefanti funamboli[167], in quelli di Nerone,
[170]
Sifilino dice di un elefante che salì sulla cima
della scena, camminando sopra una corda e portando
sopra di sè un cavaliere[168]; e Marziale parla dell’aquila
addestrata a portar in sull’aria un fanciullo,
nel seguente distico di un suo epigramma:
Æthereas aquila puerum portante per auras
Illæsum timidis unguibus hæsit onus[169]
e altrove sullo stesso fatto:
Dic mihi quem portes, volucrum regina? Tonantem[170]
perchè il fanciullo era vestito da Giove.
Le cacce e gli spettacoli gladiatorii si facevano nel
circo nelle ore mattutine; ma, nell’814, Domiziano
volle invertire l’ordine consueto e celebrò tali giuochi
a notte, collo splendore delle faci; e Svetonio che
ciò racconta nella vita di questo Cesare, aggiunge
che in questi combattimenti di bestie e di gladiatori
prendevano parte non uomini soltanto, ma femmine
benanco[171].
Le caccie più ordinarie erano, giusta quanto già
[171]
dissi, d’orsi e di cignali, come quelle più favorite e
di cui anche in Pompei si ha argomento di prova
per pitture e bassorilievi rinvenuti: e i cacciatori,
venatores, vi figuravano a piedi ed a cavallo. Usavano
costoro di apposita lancia, venebalum, dell’arco, arcus,
dei cani, canes venatici.
Le lotte degli uomini colle fiere venivano eseguite
da appositi gladiatori, designati piuttosto col nome
di bestiarii e considerati meno de’ gladiatori proprii e
spesso anche da infelici schiavi a ciò costretti da
snaturati padroni. Dapprima si accordò a tale effetto
ad essi elmo, scudo, spada o coltello e schiniere
o schermi alle gambe; poscia, sotto il regno di Claudio,
non si videro combattere che difesi da fasciature
attorno alle gambe ed alle braccia armati di spiedo
o di spada soltanto, con un brandello di stoffa colorata,
il più spesso in rosso, nella manca mano.
Di queste caccie e lotte diverse coi diversi animali
ci lasciò memoria ed intrattenne lungamente Marziale
nel suo Libellus De Spectaculis: io non vi spicco ora
che il seguente epigramma, il quale volge intorno
alla pugna delle donne colle fiere, perchè si vegga
come ne’ ludi gladiatorj il così detto sesso gentile, non
pago pure di misurarsi cogli uomini in quegli esercizj
efferati, non volesse anche nel resto rimaner
addietro degli uomini in alcun modo:
Belliger invictis quod Mars tibi sævit in armis;
Non satis est Cæsar: sævit et ipsa Venus.
[172]
Prostratum Nemes et vasta in valle leonem,
Nobile et Herculeum fama canebat opus.
Prisca fides taceat: nam post tua munera, Cæsar,
Hæc jam feminea vidimus acta manu[172].
Così si ebbero anche le bestiariæ.
Eppure il lettore non ha certo obliato come sotto
la porta principale dell’anfiteatro di Pompei nella
iscrizione a sinistra dedicata a Cajo Cuspio Pansa
padre, si faccia cenno d’una legge Petronia, della
quale l’illustre magistrato pompejano sarebbe stato
rigido osservatore.
Questa legge, così chiamata da Petronio Turpiliano
suo autore, che era console in Roma, nell’anno 813
[173]
(61 dell’E. V.), unitamente a Cajo Giunio Cesonio
Peto, soccorse alla misera condizione de’ servi, provvedendo
che dove accadesse una eguale disparità di
voti in un giudizio intorno la manumissione di un
servo, decretar si dovesse in favore della sua libertà
(L. 24. ff. de manumiss.), e proibendo agli inumani
padroni di condannare a loro arbitrio i servi al combattimento
colle bestie feroci, se prima non fossero
stati giudicati meritevoli di questa pena con un formale
giudizio. Ma intorno a questa legge, perchè memorata
nella pure da me riferita lapide pompejana,
lungamente dissertò il marchese Arditi, che fu ne’ primi
anni del secolo sovrintendente agli scavi di Pompei,
ed alla quale rinvio chi desideri saperne di più.
È implicitamente così detto che al combattimento
colle fiere venissero condannati unicamente servi ed
altri colpevoli. Ma, oltre ciò, altri, rei di parridicio
o d’empietà, venivano condannati alla esposizione
delle fiere nell’anfiteatro; ragione per cui la storia
dei primitivi tempi del Cristianesimo segna a migliaja
cosiffatte condanne dei neofiti cristiani, che gli imperatori
si ostinavano a considerare come nemici dello
Stato, malgrado pur sapessero che nelle loro agapi
e catacombe e in ogni istituzione avessero in obbligo
la preghiera per essi, l’obbedienza alle leggi e il
perdono a’ nemici. Codeste persecuzioni durarono a
questi miti ed entusiasti credenti, che da noi sono
chiamati martiri della fede e però designati alla venerazione
nostra.
[174]
Uno de’ precetti della filosofia stoica era: non ammirate
gli spettacoli; i Cristiani, nello ispirarne l’aborrimento,
avevano così una ragione maggiore.
Ecco un esempio di codesti ludi pantomimici, nei
quali la catastrofe aveva veramente umani sagrificj,
combinando così l’applicazione d’una vera pena col
pubblico divertimento.
Ancora il più volte citato Marziale, nel suddetto
Libellus, descrive di tal guisa lo spettacolo pantomimico,
nel quale, Laureolo, schiavo, che per aver ucciso il
padrone, era stato, come colpevole di parricidio, condannato
alla croce ed alle fiere, era lo sventurato
protagonista:
Qualiter in scythica relegatus rupe Prometheus
Assiduam vivo viscere pascit avem:
Nuda Caledonio sic pectora præbuit urso,
Non falsa pendens in cruce Laureolus.
Vivebant laceri membris stillantibus artus,
Inque omni nusquam corpore corpus erat
Denique supplicium dederat necis ille paternæ;
Vel domini jugulum foderat ense nocens,
Templa vel arcano demens spoliaverat auro,
Subdiderat sævas vel tibi, Roma, faces.
Vicerat antiquæ sceleratus crimina famæ,
In quo, quæ fuerat fabula, pœna fuit[173].
Il Colosseo di Roma fu singolarmente teatro a questi
barbari spettacoli, dove un popolo sitibondo di sangue
[175]
forzava la mano al principe sovente, massime quando
erano incominciate le persecuzioni cristiane, gridando
contro i nuovi credenti: alle fiere! alle fiere! perocchè
al nuovo culto e ai nuovi credenti, dagli
astuti sacerdoti pagani si attribuissero le publiche
calamità per lo sdegno degli offesi Numi.
Nè da meno inoltre attendere si doveva in un’epoca
di piena degradazione morale. Non paga la prostituzione
d’esercitarsi ne’ lupanari, nelle case de’ privati,
nella reggia e pubblicamente, perfino nei cómpiti e
quadrivii, essa versavasi ne’ teatri e nei circhi, dove
più copiosa trovava la messe. Legga il lettore Marziale,
legga Giovenale, poeti che son pur troppo forzato
a citar di soverchio, e raccapriccierà dall’orrore
di tanta spudoratezza e bassezza di popolo. I lupanari
divennero quasi parte integrante di questi clamorosi
ritrovi, vi si fabbricavano all’uopo apposite celle, e
vi si eressero temporaneamente alla evenienza di
grandi spettacoli, e le sciupate traevano però all’anfiteatro,
più certamente in cerca di lussuria che di
altro spettacolo.
[176]
Ma si oda su di ciò il Dufour.
«Non v’era eccezione nelle ore assegnate alla libera
pratica dei pubblici luoghi e piaceri, che nei
giorni di festa solenne, quando il popolo era invitato
agli spettacoli del circo. In tali giorni la prostituzione
veniva trasportata dov’era il popolo, e mentre i
lupanari chiusi restavano deserti nella città, quelli
del circo si aprivano nel tempo stesso dei ludi; e
sotto ai gradini ove affollavansi gli spettatori, i lenoni
organizzavano cellette e tende, ed ivi era una continua
processione di cortigiane e di libertini attirati
da queste al loro seguito. Mentre le tigri, i leoni e
le bestie feroci mordevano le barriere delle loro gabbie
di ferro; mentre pugnavano e morivano i gladiatori;
mentre l’uditorio scuoteva l’immenso edifizio con
grida ed applausi, le meretrices, adagiate sopra sedie
particolari, distinte per l’alta pettinatura e per le
vesti corte, leggiere ed aperte, facevano appello continuo
alle brame del pubblico, e non aspettavano
per soddisfarle che gli spettacoli fossero terminati.
Tali cortigiane lasciavano non interrottamente il posto
loro, succedendosi a vicenda durante tutto il tempo
de’ giuochi. I portici esterni del circo non più bastando
a quest’incredibile mercato di prostituzione,
tutte le taverne, tutte le osterie delle vicinanze rigurgitavan
di gente. Bene inteso che la prostituzione in
quei giorni era libera assolutamente e che gli apparitori
dell’edile non osavano inquisire sulle qualità
[177]
delle femmine che esercitavano colà l’infame mestiere.
Ecco perchè Salviano dicesse di queste orgie popolari:
si offre un culto a Minerva nei ginnasi; a Venere nei
teatri, ed altrove quanto v’ha di osceno, si pratica nei
teatri; quanto v’ha di disordinato, nelle palestre... Gli
edili quindi non si dovevano occupare della prostituzione
dei teatri, come se tale prostituzione completasse
i ludi dati al popolo. Generalmente d’altronde
(può almeno supporsi da’ varii luoghi della
Istoria Augusta), i teatri erano messi in opera da
una specie di femmine, che alloggiavano sotto i portici
e nelle gallerie arcate di questi edifizj: avevano
per mezzani, o per mariti, i banditori del teatro, i
quali vedevansi circolare incessantemente di gradino
in gradino durante la rappresentazione. Questi banditori
non si contentavano di vendere al popolo, o
distribuire gratuitamente alle spese del personaggio
che dava i giuochi, acqua e ceci: servivano principalmente
di messaggieri e d’interpreti per agevolare
la dissolutezza. Con ragione dunque il cristiano Tertulliano
chiamava il circo e il teatro concistoria libidinum»[174].
Come allora maravigliarsi dei sanguinarj giuochi
dell’anfiteatro; come sorprendersi della generale ferocia
degli spettatori?
[178]
Parini, il poeta mio concittadino, filosoficamente
e a tutta ragione ebbe a cantare:
Così, poi che dagli animi,
Ogni pudor disciolse,
Vigor dalla libidine
La crudeltà raccolse[175].
Ma la gloria di far iscomparire dalla terra queste
vere vergogne dell’umanità, che furono i giuochi gladiatorj,
in cui la vita dell’uomo era offerta al ludibrio
ed al capriccio della plebe, spettar doveva alla nuova
dottrina del Cristo, che si andava per l’orbe diffondendo.
Sarei nel dire di questo importantissimo argomento
fuori veramente dell’epoca cui deve restringersi
l’opera mia; ma, come dissimularlo? come,
dopo avere turbato l’animo del lettore col ricordo
di tanti strazii, non segnalargli poi il tempo in cui
ebbero fine, e più ancora come non segnalare il principio,
al quale andò debitrice di tanto beneficio la
povera e depressa umanità?
Il Cristo era venuto a spezzar la catena dello schiavo,
a proclamare il suo codice di libertà, d’eguaglianza,
d’amore, e santificando col proprio supplizio la croce,
segno dapprima d’infamia, l’aveva reso un oggetto di
gloria. Sparso il buon seme della nuova dottrina, fruttificata
dal sangue di tante migliaja di martiri, che
spesso in onta alle debolezze dell’età o del senso, incontravano
fra i più barbari tormenti la morte senza
[179]
pur dar un gemito, ma salmodiando a Dio e benedicendo
a’ loro persecutori, mentre i più efferati ladroni
mandavano sempre fra gli spasimi bestemmie
ed urli, doveva necessariamente riformarsi il costume
e dovevano tornare in obbrobrio i cruenti spettacoli
del circo e dell’anfiteatro.
Fu Costantino imperatore, nell’anno 1067 di Roma,
che in omaggio a’ cristiani principj, ch’egli aveva
abbracciato, bandì la legge santissima che i gladiatorj
ludi in tutto il romano impero aboliva. Pur nondimeno,
diradicare d’un tratto e per sempre sì inveterate
e glorificate abitudini non fu possibile, e un
cotal poco fecero ancora esse capolino sotto Costante, e
poscia sotto Teodosio e Valentiniano imperatori, ed
anche sotto Onorio si aprì ai gladiatori in Roma il Coliseo. — Fu
in siffatta occasione che avvenne scena
in cui tutto si pare il coraggio e l’entusiasmo cristiano.
Era l’anno 404 dell’Era Cristiana, quando questi
ludi si offerivano nell’Anfiteatro Flavio in Roma. Quivi,
venuto dall’Asia, era un monaco di nome Telemaco,
e avuto notizia che il sanguinoso spettacolo seguiva
in un determinato giorno, vi si recava animato dal
più santo zelo, e quando essi appunto fervevano, immemore
d’ogni umano riguardo, precipitatosi nell’arena
e gittatosi fra le coppie de’ combattenti, in nome
del suo Divino Maestro e della cristiana carità, tentava
disgiungere i gladiatori e farli cessare dal sangue.
Sollevavansi a quell’atto furibondi gli spettatori,
[180]
che si vedevano sturbato il loro migliore divertimento,
e dato di piglio alle pietre, lapidarono colà
il monaco generoso. — Di ciò si valse appunto l’imperatore
Onorio, perchè, proclamato Telemaco martire
della fede, si avesse a richiamare alla più severa
osservanza l’editto di Costantino.
I gladiatori adunque scomparvero di tal modo,
quantunque le caccie degli animali feroci durassero
sino alla caduta dell’impero d’occidente[176], e cessarono
pure le persecuzioni contro i credenti del Cristo.
«Voi che vi lagnate — sclama Cesare Cantù — perchè
i simboli della passione del Cristo oggi sfigurino
il Coliseo, ricordate quanto sangue v’abbiano
quelli risparmiato»[177].
A compir le notizie che riguardano i ludi del Circo
e dell’Anfiteatro, mi resta a dire delle sparsiones e
missilia, che accompagnavano quasi sempre gli spettacoli
che offerivansi in essi, quando chi ne sosteneva
le spese erano il principe, o i maggiorenti della repubblica
o dell’impero.
Queste missilia e sparsiones erano doni che si facevano
al popolo da chi dava i giuochi. Distribuivansi
a mezzo di tessere di legno, sulle quali stavano
scritte le cose cui davano diritto, lo che recherebbe
l’idea d’una gratuita lotteria, quando però non
fossero gli oggetti stessi, i quali allora si venivano
[181]
con gran tafferuglio disputando. I valori e la spesa
per siffatti regali quali fossero, possiam raccogliere
da Svetonio, là dove tratta delle missilia e delle sparsiones,
distribuite da Nerone. «Nei giuochi, scriv’egli,
per l’eternità dell’impero che Nerone appellò massimi,
persone dei due ordini e dei due sessi sostennero
parti divertenti. Un notissimo cavalier romano
sedendo su d’un elefante trascorse su d’una
corda distesa (cathadromum) in direzione obliqua. Si
recitò una commedia d’Afranio intitolata L’incendio
e si abbandonò agli attori il saccheggio d’una casa
divorata dalle fiamme. Ogni giorno si facevano al popolo
tutte sorta di larghezze (sparsa et populo missilia),
si largheggiavano a lui buoni pagabili in grani,
vestimenta, oro, argento, pietre preziose, perle, quadri,
schiavi, bestie da soma, animali addomesticati, e
finalmente si giunse per pazza liberalità a regalare
vascelli, e perfino isole e terre[178].»
E così fece dopo anche Tito, ammanendo ludi e
feste per cento giorni, nella dedica dell’Anfiteatro
Flavio da lui compito; come prima di essi, un semplice
privato, Annio Milone, quello stesso che fu difeso
da Cicerone, sprecò tre patrimonj per gli stessi dispendj.
Probo, figlio di Alipio, pretore; Simmaco pretore
del pari, per non dir di tutti, profusero, al medesimo
scopo di Claudio di blandire il popolo, infiniti tesori.
[182]
Come visitando il Coliseo e gli anfiteatri di Verona
e di Nola; così pure vedendo quello di Pompei, il quale
ne è il meglio conservato, e che tutto ciò che ho in
questa pagina brevemente passato in rassegna rammenta,
dinanzi a cosiffatte superbe costruzioni, non
puoi disgiungere dal sentimento d’ammirazione, quello
della compassione per le miriadi di vittime umane
che dentro di essi vennero sagrificate, e per la
sciagurata condizione che è fatta dalla fortuna agli
uomini d’essere gli uni di ludibrio e spettacolo agli
altri, questi destinati a servire d’incudine, quelli a
valer da martello.
[183]
CAPITOLO XV.
Le Terme.
Etimologia — Thermæ, Balineæ, Balineum, Lavatrina — Uso
antico de’ Bagni — Ragioni — Abuso — Bagni pensili — Balineæ
più famose — Ricchezze profuse ne’ bagni publici.
Estensione delle terme — Edificj contenuti in esse — Terme
estive e jemali — Aperte anche di notte — Terme principali — Opere
d’arte rinvenute in esse — Terme di Caracalla.
Seguon le terme di Caracalla — Ninfei — Serbatoi e Acquedotti — Agrippa
edile — Inservienti alle acque — Publici e privati — Terme
in Pompei — Terme di M. Crasso Frugio — Terme publiche
e private — Bagni rustici — Terme Stabiane — Palestra
e Ginnasio. Ginnasio in Pompei — Bagno degli uomini — Destrietarium — L’Imperatore
Adriano nel bagno de’ poveri — Bagni delle
donne — Balineum di M. Arrio Diomede — Fontane pubbliche
e private — Provenienza delle acque — Il Sarno e altre
acque — Distribuzione per la città — Acquedotti.
Tra gli edifizi antichi che meglio attestino della
grandezza e sontuosità romana e del costume, non
nella sola capitale dell’orbe, ma dovunque le aquile
latine ebbero a stendere il volo delle proprie conquiste,
sono, a non dubitarne, le Terme.
[184]
Terme ebbe pure, e come no? Pompei; e gli avanzi
che più innanzi esamineremo, ci varranno di conferma
di quello che storicamente sto per dire intorno a
tale argomento.
La parola dedussero i Latini dal greco vocabolo
θέρμας, che letteralmente significherebbe sorgenti
calde; quindi bagni d’acqua calda; fosse pur essa
così prodotta dalla speciale qualità e natura del luogo,
o fosse l’effetto di semplice calore artificiale. Terme
vollero dire ben presto l’edifizio intero destinato appunto
al servizio di bagni d’ogni genere, caldi o
freddi, a vapore o ad acqua.
Sotto questo aspetto generico, il vocabolo, come facilmente
si vede, ha un significato equivalente alle
parole Balineæ e Balneæ; ma queste, per istabilirne
il divario dalle Thermæ, riferisconsi piuttosto all’antica
maniera di costruire e disporre uno stabilimento
balneario; mentre dopo l’età d’Augusto, come osserva
il Rich[179], quando i Romani ebbero volto il
pensiero alle arti di pace, ed erogato ad abbellire la
città capitale una parte di quelle ricchezze che provenivano
dai tributi de’ loro estesi dominj, il nome
Thermæ venne più particolarmente appropriato a quei
magnifici stabilimenti modellati sulla pianta d’un ginnasio
greco, ma costruiti anche in più splendide proporzioni
e più vasti. Così avverrà di rinvenire negli
[185]
scrittori usati i vocaboli Balineum e Balneum e questi
per esprimere un bagno privato od una serie di stanze
per bagni appartenenti a casa privata.
Nelle Balineæ eravi d’ordinario doppio appartamento
per uomini e donne, vedendosi le eguali parti architettoniche
di un lato egualmente riprodotte dall’altro:
non così nel Balineum, del quale toccherò più d’una
volta avanti, ricordando principalmente quello che
fu riconosciuto in Pompei nella villa suburbana di
Arrio Diomede. Solo avvertirò qui che più anticamente,
a designare un bagno privato, venisse usata
la parola lavatrina, da cui, nota Varrone, si fe’ per
sincope la voce latrina, e poi si usò promiscuamente
latrina per lavatrina, accordato poi nome di latrina
tassativamente a quel luogo della casa ove confluiscono
le immondizie di essa[180].
Nell’antichità più rimota ritrovasi adottato l’uso
de’ bagni sì di acqua fredda, che di calda. Di questi
ultimi quasi sempre parla Omero ne’ suoi poemi; dei
primi fa pur cenno. Quando nell’Iliade
fa che Diomede ed Ulisse sull’alba e di primavera si
lavino nel mare per refrigerio di quella loro notturna
impresa; e nell’Odissea quando rappresenta le donzelle,
che accompagnavano la real fanciulla Nausica a lavarsi
per diletto nel fiume. Ettore, ancor nell’Iliade, tramortito
dal masso lanciatogli al petto da Ajace venne
fatto rinvenire colle acque dello Xanto.
[186]
L’esercizio e il diletto de’ bagni entrarono perfino
ne’ riti delle pagane religioni: perocchè queste di sovente
consacrarono col loro sacro e venerato suggello
quelle pratiche che la politica e l’igiene consigliavano
a’ popoli, onde e in Egitto e in Grecia, e in Roma
e presso le più barbare nazioni si introdussero nelle
religiose cerimonie lustrazioni e purificazioni frequenti
e si narri da Teofrasto che un cotale dominato
da superstizione, mai non sapesse passeggiare
la città che transitando avanti le publiche fontane
non vi avesse a tuffare e lavare la testa.
Euripide, che i bagni di mare avevan guarito da pericolosa
infermità volle forse alludere ad essi quando disse:
Lava il mar tutti quanti i mali umani.
L’uso dei bagni in Italia fu frequentissimo in allora,
assai e assai più che di presente. Servio, lo scoliaste
di Virgilio, commentandone un passo coll’autorità
di Catone e di Varrone ci fa sapere che gli
Stati primitivi portavano i loro pargoli a’ fiumi e col
ghiaccio e coll’acqua rendevano i loro corpi più duri
e più sofferenti, ciò che narrasi avere pur fatto gli
Spartani, i Germani ed i Celti. Ma del non essere rimasta
dopo l’impero di Roma, la consuetudine dei
bagni, così frequente ed eccessiva in Italia, non se
ne vuole, come fa il francese Bréton, ligio in questo
al mal vezzo del suo paese, di buttarsi in ogni
occasione a detrarci, inferire contro noi, che scostandoci
dalle consuetudini de’ nostri padri, siam
[187]
portati a bagnarci ben più raramente che non gli abitanti
delle contrade del Nord. Io non reputo vera
l’accusa. Non saprei indicare qui esattamente tutte
le stazioni termali della Penisola, sia per cure idropatiche,
che di puro convegno estivo. Forse tra noi non
hanno esse tanta nominanza quanto le terme di Baden,
di Spa, di Omburgo, di Aix, di Plombières e va dicendo,
per ciò solo che meno immorali, noi non vantiamo
ai bagni nostri di Acqui, d’Abano, di Montecatini,
di Genova, di Livorno, di Venezia, di Rimini, di Salsomaggiore,
di Recoaro e dei cento altri luoghi in
ogni parte d’Italia, che salutari guarigioni e non
rovine di sostanze giuocate sui scellerati tapis verts.
In quanto ai tempi di Roma antica, trovandosi essa
sotto clima meridionale, dove la traspirazione è abbondante
nella estiva stagione, e siccome non si
avesse ancora l’uso delle biancherie, ossia de’ pannilini,
nelle vestimenta, — la cui introduzione avvenuta
forse intorno al secolo sesto, secondo il Manni[181] e
il Ferrari e il Mercuriale da lui citati, credono essere
stata cagione della diminuzione della pratica quotidiana
dei bagni, ridotta quasi al solo uso della medicina[182] — è
certo che dovendo vestire immediatamente
presso la pelle la lana e aver soli sandali ai piedi, il
[188]
sudore e la polvere dovessero esigere giornaliere abluzioni
e persuadere così il generale e ripetuto uso
de’ bagni.
Era questo una misura igienica. Ne’ primi tempi
anzi la salute solo e la decenza lo consigliavano e
reclamavano: l’idea del lusso o della mollezza non
c’entrava ancor punto. L’uso era di bagnarsi tutti i
nove giorni, all’epoca cioè del mercato, che seguiva
appunto con questi intervalli, come già ne tenni parola,
trattando del Foro Nundinario.
Dapprima i bagni pubblici non furono che edifizj
massicci, rischiarati piuttosto da fessure che da finestre,
divisi in tre comparti, o camere, la caldaria, la
tepidaria e la frigida; nomi che indicano da sè stessi
la loro speciale destinazione. Consistevano del resto
allora semplicemente in ampie vasche in cui poteva
ognuno entrare per lavarsi e nuotare, usanza tolta a
prestito agli Spartani; ma, ai tempi di Pompeo, si
eressero luoghi più adatti; quantunque, come già
dissi, la ricercatezza e splendidezza, perfino eccessive,
delle Terme, non si noti che più tardi, cioè sotto di
Augusto e de’ suoi voluttuosi successori.
Per consueto si faceva uso dei bagni prima della
cena ed anche dopo i passeggi, le esercitazioni ginnastiche
e il lavoro; il più spesso per ragion di bisogno, non
rado tuttavia per ragione di semplice diletto. Si giunse
a un tempo perfino di eccesso nell’uso di essi; perocchè
si legga che Commodo otto volte il dì si lavasse;
[189]
Gordiano il giovane e Remnio grammatico sette volte,
e i fannulloni passassero nelle terme la più gran parte
del giorno e della notte; nè ciò si verificasse soltanto
de’ più potenti e ricchi, ma de’ privati ben anco, ivi
allettati viemmeglio dal concorso delle cortigiane; e
Plinio perfino rammentò di schiavi, che vi profondevano
ricchezze, quale era il gitto di preziosi unguenti,
di cui pavimenti e pareti rimanevano imbevute.
Seneca — e ciò valga a dimostrare la sontuosità
di codesti publici convegni — in bagni plebei trovò
fistole, o condotti di acque, lavorate in argento, e in
quelli di gente libertina vide con giustissima indegnazione
profuse perfin le gemme.
Valerio Massimo e Macrobio attestano che un Sergio
Orata avesse immaginato, a maggiore studio di voluttà,
dei bagni pensili.
Così dagli scrittori citansi in Roma le Balineæ Palatinæ,
poste cioè sul clivo Palatino; quelle di Mecenate,
quelle di Nerone, di Agrippina nel colle Viminale;
di Stefano, ricordate da Marziale nel lib. XI de’ suoi
epigrammi, in quello indiritto a Giulio Cereale:
Octavum poteris servare, lavabimur una;
Scis quum sint Stephani balnea juncta mihi[183];
di Novato pur sul Viminale; di Olimpiade; di Paolo;
di Policleto e di Claudio Etrusco, di cui parla Stazio
[190]
nel lib. I delle Selve, facendone l’entusiastica descrizione,
e Marziale suddetto nel sesto degli Epigrammi.
Il qual ultimo poeta fa menzione dei bagni pure
di Tucca, di Fausto, di Fortunato, di Grillo, di Lupo,
di Pontico, di Severo, di Peto e di Tigellino. Del resto
è impossibile tener conto di tutti i pubblici bagni di
Roma, se già dal tempo d’Augusto se ne noverassero
sin ottocentocinquantasei, e sotto Antonino, nelle terme
da lui costrutte, vi fossero milaseicento sedili di marmo
o di porfido e vi si potessero riunire fin tremila bagnanti,
e tremila e duecento in quelle di Diocleziano.
Il solo Agrippa aprì centosettanta bagni pubblici e
volle fossero gratuiti; oltre che ogni benestante, appena
l’avesse potuto, accostumò aver nella propria
casa il proprio bagno particolare.
Con quanta profusione di ricchezza si ornassero
questi luoghi ho già detto e la fantasia appena può
immaginarlo. Plinio lasciò ricordato che nei bagni
degli imperatori sul monte Palatino vi fossero vasche
e mobili d’argento nelle sale destinate alle dame.
Pitture, statue, bronzi, mosaici vi abbondavano, nè
facea difetto in questi sontuosi edifizj di tutto quanto
potesse solleticare i sensi e ricreare gli spiriti.
Per farsi ragione di quanto lusso essi fossero, non
sia discaro recar alcuni versi del succitato Stazio,
ne’ quali parla dei bagni, che ho pur più sopra mentovati,
di Claudio Etrusco.
[191]
Non huc admissæ Thasos, aut undosa Charistos,
Mœret onyx longe quæriturque exclusus Ophites:
Sola nitet flavis Nomadum decisa metallis
Purpura, sola cavo Phrygia quam Synnados antro,
Ipse cruentavit maculis lucentibus Atys,
Quasque Tyros niveas secat, et Sydonia rupes.
Vix locus Eurotæ viridis, cum regula longo
Synnada distincta variat non lumina cessant,
Effulgent cameræ, vario fastigia vitro
In species animosque nitent. Stupet ipse beatas
Circumplexus opes, et parcius imperat ignis.
Multus ubique dies radiis ubi culmina totis
Perforat, atque alio sol improbus uritur æstu.
Nil ibi plebeium, nusquam Temesea notabis
Æra, sed argento felix propellitur unda
Argentoque cadit, labrisque nitentibus instat,
Delicias mirata suas et abire recusat[184].
[192]
Ma perchè non si creda che il Poeta vi abbia aggiunto
del proprio, ascoltiamo Seneca, nel passo al
quale ho superiormente fatto cenno, che sembra essersi
incaricato di trasmetterci le notizie di tutti i
raffinamenti del lusso spiegati nei bagni, istituendo
un paragone fra il presente e il passato con viva ed
energica pittura e non dissimulando l’aspirazion sua
verso l’antica semplicità.
È la vista della villa di Scipione a Literno che gli
detta le seguenti considerazioni. «Io vidi, scrive egli,
il bagno piccolo, oscuro e tenebroso, secondo il costume
de’ nostri maggiori: credevano essi necessario
per aver caldo, che non ci si vedesse molto. Fu gran
piacere per me di mettere a raffaccio i costumi di
Scipione coi nostri. È in questo tetro asilo che quell’eroe,
il terror di Cartagine, lavava il proprio corpo,
stanco dalle fatiche della campagna. Oggi chi consentirebbe
a bagnarsi così? Si crederebbe versare
nell’indigenza, se le pietre preziose, regolate da abile
scalpello, non risplendessero da tutte parti sui muri;
[193]
se i marmi d’Alessandria non fossero interamente incrostati
di marmi numidi, se la volta non fosse di
vetro, se le piscine non recinte da marmo di Taso,
meraviglia codesta riservata un tempo appena a qualche
tempio privilegiato, se l’acqua non iscendesse da
canne d’argento. E io non parlo finora che di bagni
plebei; ma che sarà se passiamo in quelli de’ liberti?
quante statue, quante colonne che sostenevano nulla,
ma vi son collocate solo per ornamento dell’edifizio!
Tale è oggidì la nostra delicatezza, che noi non permettiamo
a’ nostri piedi che di calpestar pietre preziose.
Nei bagni di Scipione non trovansi che piccole
fessure per finestre: oggi invece si dice d’un bagno:
è un antro, se non è disposto in guisa di accogliere
a mezzo di immense finestre il sole durante tutta la
giornata, se dalla vasca non si scorgono le campagne
ed il mare. In addietro si contava picciol numero
di bagni, ed essi erano assai poco ornati: perchè, infatti,
spiegare della magnificenza in edificj in cui s’entrava
col pagamento d’un quadrante e che erano destinati
all’utilità piuttosto che al piacere? L’acqua non vi
cadeva già a cascate e non si rinovellava senza interruzione:
quanto non si troverebbe grossolano di
non aver introdotto la luce nel suo caldarium a mezzo
di larghe pietre speculari e di non essersi proposto
di digerire nel bagno! Oh lo Sciagurato! ei non sapeva
vivere! Non si bagnava già in un’acqua limpida
e calma, ma torbida il più spesso e limacciosa!
[194]
ma poco a lui ciò caleva; perocchè egli colà traesse
a lavare i suoi sudori, non i proprj profumi. Che direste
voi dunque se sapeste com’ei non si bagnasse
già tutti i giorni, non più de’ suoi contemporanei?
Oh gli uomini sucidi, direste voi! — ma lo si è diventati
di più da che i bagni si sono moltiplicati.
Che mai dice Orazio per dipingere un uomo screditato
dagli eccessi del suo lusso? Ch’ei pute di profumi.
Scipione putiva di guerra, di fatica, di eroe. Scegliete
fra Rufillo e Scipione.»
Ma se così erano i bagni pubblici e privati, faccia
ragione il lettore che dovessero essere le terme, se
a’ bagni fu sempre assegnato un significato più semplice
e più modesto, e alle terme si applicò per contrario
quello d’una magnificenza maggiore e d’una
più grande estensione.
Le rovine che tuttavia sussistono gigantesche fanno
fede di ciò e giustificano la sentenza d’Ammiano:
Lavacra in modum provinciarum exstructa, quasi le
terme emulassero in vastità, non che le città, le intere
regioni. Infatti si vuole che le terme di Settimio
Severo occupassero uno spazio di centomila piedi
quadrati.
Ma come, dirà naturalmente il lettore, poteva il
solo corpo delle terme occupar tanto spazio? Nelle
terme, oltre le piscine, o gran vasche per nuotare
allo scoperto e i battisterii pei bagni freddi a immersione,
eranvi celle pei bagni particolari, portici e
[195]
xisti, specie di giardini alberati, per le passeggiate,
sferisterii o sale per giuocare alla palla, conisterii o
stanze co’ pavimenti di sabbia onde stropicciare i corpi
unti dei pugili, teatri per rappresentazioni drammatiche,
circhi per ludi gladiatorj, esedre per conferenze
filosofiche e letture di poemi, palazzi e templi, biblioteche
ed efebei, o luoghi destinati alla educazione
della gioventù, e tali e tanti altri edificj che agli imperiti
venne poscia autorità di chiamar col nome di
terme i più cospicui monumenti che rimangono dell’antico.
Si fecero terme estive e terme jemali, che Gordiano
insegnava erigere nella medesima località; ma prevenuto
da morte, non potè recare ad effetto. Aureliano
le fabbricò poi in Trastevere ed aperte prima tutte soltanto
di giorno, poscia si resero accessibili anche di
notte.
Ecco ora, secondo l’ordine di loro anzianità, le
più celebrate terme di Roma:
Prima quelle di Agrippa, che Plinio, alla cui Storia
Naturale son costretto sempre a ricorrere, chiamò fra i
precipui ornamenti della città: ebbero archi e pavimenti
di vetro e le migliori commodità.
Seguon quelle di Nerone, delle quali Marziale,
nell’epigramma 34 del lib. VII, disse il maggior elogio,
come del loro signore rese la più trista testimonianza:
Quid Nerone pejus?
Quid thermis melius Neronianis?[185]
[196]
quelle di Tito, alle quali accenna il medesimo Marziale
nell’epigramma 20 del lib. III:
Titi ne thermis an lavatur Agrippæ?
An impudici balneo Tigellini?[186]
quelle di Domiziano, quelle di Trajano, quelle di Severo
e quelle di Antonino, di tanta mole codeste
ultime ed artificio che, se vuolsi aggiustar fede a
Sparziano, eziandio dotti architetti negassero prima
potersi di tal modo costrurre.
Vengono altresì le terme dette Siriache; le terme
di Alessandro; quelle di Gordiano sontuosissime; di
Filippo, di Decio, di Aureliano e di Diocleziano. Queste
occuparono buona parte del Viminale, e dalle loro
imponenti rovine si argomentarono e i fornici altissimi
e le ammirabili colonne e tutta la imponenza
degli altri edificj.
Finalmente si rammentano le terme di Costantino
nel Quirinale, un fornice delle quali ascendendo
Giorgio Fabricio, vi giunse ad annoverare quasi cento
gradini[187].
Come poi fossero, per così dire, divenute obbligatorie
le splendidezze ed il lusso maggiori in cosiffatti
stabilimenti, ce lo ha già appreso quel passo di Seneca,
che ho superiormente riferito.
[197]
Or si comprende adunque come tanta parte degli
antichi capolavori dell’arte greca pervenuti infino a
noi e che formano i principali ornamenti e vanti dei
nostri musei e gallerie, si avessero a ritrovare nelle
terme. Il gruppo del Laocoonte si rinvenne in quelle
di Tito; l’Ercole e il Toro Farnese, il Torso di Belvedere,
la Flora Farnese, i due Gladiatori e il gruppo
di Dirce legata da Zeto e Anfione ad un toro selvaggio,
si scoprirono nelle Antoniniane, dette altrimenti
di Caracalla, opere tutte che si conservano nel
Museo Nazionale di Napoli. Si comprende eziandio
come avesse potuto Michelangelo una sola stanza
delle Terme Diocleziane, tramutar nella Chiesa di
Santa Maria degli Angeli la più grande in Roma,
dopo quella di S. Pietro.
Delle terme Antoniniane o di Caracalla, l’architetto
Pardini sui ruderi esistenti ne ricostruì il disegno
primitivo, onde è dato di ricordarne le parti
alla maggiore intelligenza di tali stabilimenti, ed io
lo farò, ajutandomi con quanto ne ha pur fatto il
De Rich: perocchè suppergiù sieno le altre terme
egualmente conformate[188].
Una colonnata corre lungo tutta la facciata e fronteggia
la strada: sarebbe stata annessa alla fabbrica
primitiva sotto Eliogabalo in parte e compiuta sotto
Alessandro Severo. Dietro tale colonnata evvi una fila
[198]
di celle con un apoditerio o spogliatojo annesso a
ciascuna per uso delle persone che non amavano di
bagnarsi in pubblico. Nel mezzo della fronte s’apre
l’ingresso. Tre corridoi semplici intorno al corpo centrale
dell’edifizio, con un doppio corridoio dal lato
ovest, ristaurati dal detto Pardini secondo il modello
del ginnasio d’Efeso benchè non ne rimanga ora veruno;
pur senza di essi vi sarebbe stato manifestamente
un vuoto che conveniva riempire. Da ambo i
lati della generale costruzione stanno le exedræ, ove
sedevano e conversavano insieme filosofi e letterati,
costruite con un abside semicircolare che dal lato
sinistro tuttavia si conserva e intorno alla quale erano
disposti i sedili. Nel mezzo di tale abside vi sono i
corridoi conformi alli xisti greci, con terreni per esercizj
sul davanti e che avevano alle due estremità
una stanza separata, che serviva probabilmente a
qualcuno degli esercizj o giuochi di provenienza greca.
Fra questi xisti, dall’uno all’altro vi erano praticati
passeggi scoperti (hypetræ ambulationes) piantati d’alberi
e arbusti e con ispazj vuoti nel mezzo per gli
esercizj del corpo. Nella parte postica dello stabilimento
è delineato lo stadio, con sedili all’intorno,
dove gli spettatori prendevano diletto alla corsa e
agli altri esercizj, che vi si facevano; quindi anche
il nome di theatridion. Le costruzioni dietro lo stadio
contengono serbatoi di acqua e fornelli al di
sotto, che riscaldavano l’acqua pei bagni fino ad
[199]
una certa temperatura, prima che fosse travasata da
tubi nelle caldaje immediatamente contigue alle
stanze dei bagni. Quanto alle altre stanze situate in
questa estremità dell’edifizio non saprebbesi determinarne
in modo autentico l’uso speciale, dove non
servissero all’uso della ginnastica, essendo appunto
prossime ai posti o terreni destinati alla medesima.
Il corpo centrale del fabbricato conteneva le stanze
del bagno, alcune delle quali serbano tuttavia qualche
traccia della loro destinazione così da potersene con
fiducia assegnar l’uso ed il nome; quindi la natatio,
ossia una gran vasca da potervi nuotare, fiancheggiata
da ogni parte da una serie di stanze che servivano
da apoditerj e da camere per gli schiavi, capsarii, che
prendevano cura delle vestimenta deposte da coloro
che si bagnavano; il caldarium con quattro bagni di
acqua calda, alvei, ad ogni angolo, e un labrum, o
gran vaso a fondo piatto per l’acqua, onde spruzzarsi
il volto nell’altezza della temperatura, da ciascuno
de’ due grandi lati. Le stanze che seguivano appresso
contenevano il laconicum, o bagno a vapore, a cui probabilmente
serviva la camera circolare, posta propriamente
nel centro dell’edificio. Avanti di essa, ai lati
pure, stavano cisterne d’acqua alimentate dai serbatoi
posti all’estremità opposta. Due grandi spazj vicini
ai corridoi laterali valevano di stanze coperte per passeggiarvi
nel tempo cattivo e di sferisterii, o sale pel
giuoco della palla, a cui si davano con molto ardore
[200]
i Romani; quelle che si trovano più oltre, sotto un
doppio portico erano due bagni freddi a immersione,
baptisteria, con una stanza per ugnersi, elæothesium,
e una camera fresca, frigidarium, egualmente da ciascun
lato. Nel suo complesso la fabbrica occupa un’area
d’un miglio di circonferenza, o 1851 metri. Il
corpo centrale aveva inoltre un piano superiore, dove
probabilmente dovevano essere biblioteche e gallerie
di quadri.
Per ciò che spettano all’argomento delle Terme, non
dimenticherò di dire ora una parola de’ Ninfei. Che si
fossero veramente, è controverso ancora: due principali
sono i significati che vi si assegnano. Il Monaco
Zonara, che scrisse intorno agli Imperatori Greci, vorrebbe
i Ninfei essere stati pubblici palazzi, nei quali
si celebrassero nozze e che venissero aggiunti ai
massimi palagi a seconda del bisogno: altri opinano
invece che fossero luoghi pubblici di piacere, nei
quali venissero bensì derivate le acque, ma non per
terme e bagni, ma solo per ragione di amenità, traendo
il nome dalle statue delle ninfe, di cui più sovente
solevansi adornare. Ma non consta di meglio circa il
loro uso, nè circa la loro forma, variando assai gli
scrittori di cose antiche nel dir di tutto che spetta
a cotali edificj; pare nondimeno non avessero a
mancare d’una certa importanza, se gli stessi imperatori
gli ebbero a edificare; onde Ammiano
faccia menzione del Ninfeo di Marco come d’opera
[201]
ambiziosa, Publio Vittore di quello di Alessandro,
e Capitolino di quello di Gordiano, per non dire d’altri.
Degli antichi ninfei non è superstite vestigio di sorta:
solo il già citato Giorgio Fabrici, nella sua Roma, descrive
liberamente un ninfeo nella villa Leucopetrea
fra Napoli e il Vesuvio, ma non recano maggior luce
nell’argomento.
L’opinione più generale è per la seconda ipotesi,
che de’ ninfei fa un fresco ed aggradevole recesso,
e come i sunnominati scrittori ne collocarono il tema
nel dir delle terme; ho voluto pur io seguitarne l’esempio;
avvalorato a questo dall’aver trovato nel Codice
Teodosiano il titolo Quid in publicis thermis, quid
in nympheis pro abundantia civium conveniat deputari,
e nello stesso luogo aver letto: Malumus aquæductum
nostri palatii publicarum thermarum ac nympheorum
commoditatibus inservire[189], i quali testi, terme
e ninfei confondono in un solo interesse. Vi pone
suggello l’antica iscrizione scolpita sul margine di
un fonte:
NYMPHÆ LOCI
BIBE LAVA TACE
Ora naturale discende dal fatto della esistenza, molteplicità
e suntuosità di tutte queste istituzioni l’indagine
[202]
del come e terme e bagni pubblici e privati
e ninfei venissero provveduti convenientemente di
acqua, molto più in quelle città, nelle quali si doveva,
per la loro situazione, difettare.
Era tutta una scienza, che procaccerò di spogliare
di sua rigidezza, per non dirne che storicamente di
sua applicazione.
Roma per lungo tempo non ebbe altra acqua che
quella del suo Tevere e di qualche sorgente nativa;
ma accresciuta la città, e distanti di soverchio i suoi
colli dal fiume, nell’anno 441 di sua fondazione, per
opera di Appio Claudio Censore, quello stesso che
istituì il sistema di eseguir le strade, viæ stratæ, avvisò
al modo di condurvi l’acqua per tubi, canali e
fornici laterizii. L’acqua Appia vi venne pel corso di
circa undici miglia condotta. I bisogni pel bevere,
per i bagni, per le fulloniche, per le naumachie e
pei circhi, consigliarono nuovi acquedotti; onde se
ne contarono ben quattordici, e Publio Vittore ne numerò
venti; così che quasi ogni casa potè derivarne
a’ proprii usi con fistole e canali, e Plinio avesse a
notare: Si quis diligentius æstimaverit aquarum abundantium
in publico, balneis, piscinis, domibus, euripis,
suburbanis villis, spatioque advenentium extructus arcus,
montes perfossos, convalles æquatas, fatebitur, nihil magis
mirandum fuisse in toto Orbe terrarum[190].
[203]
E destano infatti tuttavia la maraviglia nostra quegli
avanzi degli arditi acquedotti romani costituiti da
più ordini d’archi l’uno all’altro sovrapposti, contribuendo
nella loro magnificenza a mantener l’antonomasia
d’opera romana allorchè si voglia significare
un’opera gigante, maravigliosa, per non dir quasi
impossibile. Questi superbi acquedotti trasportavano
perfino tre separati corpi di acque in tre canali uno
sovra dell’altro.
Nè Roma soltanto intese alla costruzione degli acquedotti,
ma nella più parte delle colonie e nelle
maggiori castella eziandio; tanto la commodità si
era venuta ingenerando come una vera necessità.
Chi volesse poi conoscerne di più e saperne tutte le
minute particolarità, consulti l’opera di Sesto Giulio
Frontino De aquæductibus urbis Romæ Commentarius;
e per informarsi delle opere nelle colonie, vegga
la dotta memoria del conte Giovanni Gozzadini Intorno
all’acquedotto ed alle terme di Bologna. Più innanzi
dirò del come le Terme e le fontane publiche
e le case si provvedessero d’acqua in Pompei.
Non va per altro taciuto, onde assolvere possibilmente
questo subbietto, degli immensi e dispendiosi
[204]
serbatoi e laghi che per gli acquedotti si vennero
facendo. Plinio summentovato ne fa stupire allor
che memora: Agrippæ in ædilitate sua, adjecta Virgine
aqua, cæteris corvisatis atque emendatis lacus 700
fecit, præterea salientes 105, castella 130; complura
etiam cultu magnifica. Operibus in signa 300 ænea aut
marmorea imposuit, columnas ex marmore 400: eaque
omnia annuo spatio[191].
Occorre poi a conoscere l’importanza che all’acqua
ed acquedotti aggiungevasi da’ Romani, riferire da
Frontino suddetto quanto venisse provveduto alla loro
custodia.
Due classi o famiglie d’inservienti vi erano preposte:
l’una del pubblico, l’altra di Cesare. Più
antica la prima, che fu da Agrippa legata ad Augusto
e da questi attribuita al pubblico e pagata dall’erario,
componevasi di circa 240 persone: il novero
della famiglia di Cesare era di 460 e questa stabilita
fin da’ primordj in cui si guidò l’acqua in Roma
da Appio Claudio. L’una e l’altra famiglia impiegavasi
in varia specie d’amministrazione: v’erano i
villici, (villici), i ministri de’ castelli (castellarii), i riportatori
[205]
(circuitores), i selciatori (silicarii), gli incrostatori
(tectores) ed altri artefici (opifices). Su tutti costoro
era il soprintendente (Curator); e lo stesso Frontino
fu alla sua volta, sotto di Nerva, Curatore alle
acque, onde ne potè scrivere con maggiore cognizione
di causa. E questi, dice egli, ideoque non solum
scientia peritorum sed et proprio usu curator instructus
esse debet, nec suæ tantum stationis architectis uti, sed
plurium advocare non minus fidem, quam subtilitatem,
ut æstimet, quæ repræsentanda, quæ differenda sint; et
rursus quæ per redemptores effici debeant, quæ per domesticos
artifices[192].
E ne fa sapere lo stesso Frontino che a codesti curatori
delle acque furono dati anche ajutatori (adjutores),
concedute insegne d’onore come a’ magistrati ed
anzi intorno alla loro magistratura reso un decreto dal
Senato, consoli essendo Quinto Elio Tuberone e Paolo
Fabio Massimo, per il quale allorquando essi fossero,
per cagione del loro ufficio, fuori di Roma, potessero
[206]
aver seco due littori, tre servi del publico, un architetto,
scrivani (scribæ) e copisti (librarii), sargenti
(accensi) e banditori (præcones), tanti, quanti ne
hanno per l’ordinario due deputati alla dispensa del
grano alla plebe, e dentro Roma, quando per cagione
del medesimo affare operassero qualche cosa, potessero
valersi di tutti gli stessi ministri, eccetto che
de’ littori.
Toccato fin qui d’ogni tema attinente le Terme,
vediamone l’applicazione allo speciale soggetto nostro
di Pompei.
Quivi Terme, quivi bagni pubblici e privati, quivi
ninfei e fontane publiche ed aquedotti e comunque
le proporzioni sieno di gran lunga inferiori a quelle
degli eguali stabilimenti che ho ricordato di Roma,
in ragione cioè della minore importanza, vastità e
quantità di popolazione; pur nondimeno ogni parte
serbando di esse e soddisfacendo ad ogni bisogno
creato dalle costumanze termali, ponno essere di
grande utilità nei loro interessanti avanzi, per la
spiegazione di tutto che si riferisce all’argomento e
quasi alla completa storia del medesimo.
Sulla scoperta delle Terme si contava indubbiamente
fin dal primo momento che si pose la mano agli
scavi. Era impossibile che altrimenti fosse. Una città
dove era stata dedotta una colonia romana, dove necessariamente
erano stati importati costumi e abitudini
greche dai primi abitatori e da’ suoi abituali
[207]
frequentatori, e costumanze romane dai nuovi arrivati,
terme e bagni dovevano essere d’obbligo: dipendeva
quindi unicamente di vedere in qual tempo
si sarebbero trovate.
Fin dal primo marzo 1749, lo che è dire intorno
al principio degli scavi pompejani, come ne fa sapere
l’illustre Fiorelli, nella sua Pompejanarum Antiquitatem
Historia[193], lungo la via dei Sepolcri, nella casa
che si dice di Cicerone, della quale ho già nei capitoli
della storia favellato, si rinvenne nella nicchia
d’un’ara una lapide, su cui fu letta la seguente iscrizione:
THERMAE
M. CRASSI FRVGI
AQVA MARINA ET BALN.
AQVA DVLCI IANVARIVS L.[194]
Fu questo il primo cenno delle Terme, ma queste
terme nondimeno di Marco Frugio sono ancora un
desiderio, che sperasi appagheranno i futuri scavi.
Invece nel luglio 1824, nella vicinanza del Foro
civile si fece la preziosa scoperta delle Terme publiche,
nelle quali, se non si ammira la magnificenza
delle arti e la profusione della ricchezza e del lusso,
trovasi in ricambio una semplicità ed una squisita
eleganza. Secondo l’idea che ne fornii più sopra, direbbonsi
[208]
queste piuttosto Balineæ che Thermæ, molto
più se si pon mente alla poca ampiezza dello stabilimento,
motivata dall’essere nel punto centrale e più
frequentato della città, e dove per conseguenza il terreno
indubbiamente doveva essere più limitato e costare
più caro.
Ad ogni modo merita che ne somministri ogni particolarità.
L’edifizio aveva sei ingressi dalla strada, di cui i
due principali davano uno sulla via del Foro e l’altro
nella Piazza detta delle Terme. Tre servivano per i
bagnanti, due per gli schiavi e pel servizio dello stabilimento
e l’ultimo per le donne. È notevole che nessuno
di questi ingressi fosse in linea diretta: ciò toglieva
che le correnti d’aria penetrassero troppo vivamente
nel luogo de’ bagnanti e forse impediva eziandio l’indiscrezione
de’ passanti per la via summentovata dove
s’aprivano anche le porte minori.
Presso ciascuno dei due ingressi principali eravi
una latrina. Subito dopo il primo v’era un cortile
circondato da un colonnato su tre lati, che formava
una specie di Atrium. Lungo un lato di esso stavano
sedili di sasso, scholæ, per chi stava aspettando quelli
che uscivano dal bagno.
Sulla parete meridionale si lesse dipinto l’annunzio
di una gran festa data nell’Anfiteatro, nell’occasione
che venivano inaugurate le terme, a spesa di Gneo
Allejo Nigidio Majo.
[209]
MAIO
DEDICATIONE PRINCIPI COLONIAE
FELICITER
THERMARVM MVNERIS CN. ALLEI NIGIDI MAI
VENATIO ATHLETAE SPARSIONES VELA ERVNT[195]
Dietro di essi era una camera appartata, in cui forse
stava, se pur non era in quelle due camere laterali
dei principali ingressi, nelle quali altri supposero esistere
latrine, il balneator, o direttore del bagno, che
riceveva il pagamento d’un quadrante o quarto di
asse, se eguale devesi ritenere la misura in Pompei a
quella che si pagava in Roma per accedere a’ bagni,
giusta quel che ne disse Orazio nella satira terza del
libro primo:
. . . . dum tu quadrante lavatum
Rex ibis[196].
Presso la seconda porta principale eravi un corridoio
che riusciva all’apodyterium, che sappiamo essere
la camera da spogliarsi, come suona la parola
d’origine greca ἀποδυτήριον, dal verbo ἀποδύομαι, spogliarsi,
detta anche più latinamente spoliatorium e
spoliarium. Questo apodyterium pompejano ha opportunamente
[210]
molte porte, quante cioè son le camere
destinate ai bagni caldi e freddi alle quali appunto
esso introduceva. Eranvi pure disposti sedili in muratura
per comodo de’ bagnanti. In fondo stava la guardaroba,
o stanza di custodia del vestiario che si deponeva
durante il bagno, e vegliavasi dai capsarii.
Anche in Roma ognuno che traeva alle terme
doveva spogliarsi nell’apodyterium ed entrar nudo
nelle altre località; savia precauzione tendente ad
ovviare alle sottrazioni delle ricchezze in fregi, pietre
preziose, oggetti di toeletta e dalle cento altre bazzicature
occorrenti a tutte le operazioni attinenti i bagni.
Di contro stava il frigidarium o bagno d’acqua
fredda: gabinetto ovale assai grazioso, con vasca circolare
rivestita di marmo, sul cui bordo è un gradino
per entrarvi: dallato il tepidarium, o come esprime
la parola, la camera ad ambiente tiepido, così mantenuto
da un braciere, foculare, che vi si rinvenne di
bronzo e valeva a graduare la temperatura dal caldo
al freddo, quando si passava dal caldarium, o camera
termale che fiancheggiava appunto il tepidarium, all’aria
aperta.
Talvolta però il balneante dal caldarium non s’arrestava
nel tepidarium, ma transitandolo rapidamente,
lanciavasi nel baptisterium del frigidarium, perocchè
si avesse fede che ciò valesse a rendere florida ed
a fortificare la pelle, come lo attestano i versi di
Sidonio Apollinare:
[211]
Intrate algentes post balnea torrida fluctus,
Ut solidet calidam frigida lympha cutem[198]:
è l’odierno sistema idropatico, principalmente nei
bagni russi.
Nel tepidarium pompejano si trovarono pure tre sedili
di bronzo su cui sedevano indubbiamente gli avventori
quando usciti dalla camera del bagno caldo
si sottoponevano alla operazione dei tractatores, che
erano schiavi adetti ai bagni, il cui ufficio era di stropicciare
il bagnante finchè non fosse ben asciutto, di
ben raschiarne la traspirazione della pelle fatta più
abbondante dal vapore e i corpi eterogenei, a mezzo
dello strigile, arnese ricurvo di ferro o di bronzo, il
cui filo rendevasi talvolta più dolce linendolo d’olio,
e le buone fortune dei quali sono rammentate da
Giovenale, nella satira VI. alla quale rimando il curioso
lettore; perocchè la parola italiana è alquanto
più della latina pudica, e mal si presterebbe alla
lestezza dell’acre e spregiudicato poeta satirico. Eranvi
poi gli aliptes che dopo ungevano con unguenti
odorosi e profumavano; e le pareti del tepidarium
hanno piccole cavità tutto all’intorno che dovevano
[212]
essere altrettanti ripostigli e di quelli stromenti e
di quelli unguenti ed aromi.
Su quei sedili si lesse la seguente iscrizione:
M. NIGIDIVS VACCVLA. P. S. (pecunia sua)[199].
Nella camera termale o caldarium era da una parte
il bagno d’acqua calda detto alveus e dall’altra
il laconicum, o alcova semicircolare, riscaldata da
una fornace e da tubi, hypocausis, sotto il pavimento
e attraverso le pareti praticate espressamente vuote.
Fu detto laconicum, perchè l’uso ne fu dapprima introdotto
fra i Lacedemoni, e nel pompejano di cui parlo
stava in mezzo il labrum, di cui spiegai lo scopo più
sopra; ch’era cioè là vasca a fondo piano che conteneva
l’acqua della qual s’aspergeva il balneante mentre gli
si raschiava il sudore prodotto dalla temperatura
elevata a cui eran mantenute le stanze, e immediatamente
su di essi v’era un’apertura, lumen, che poteva
esser chiusa od aperta con un disco di metallo
detto clipeus, sospeso mediante catene, secondo si fosse
voluto abbassare od elevare il grado di calore, come
è indicato da Vitruvio. Tre finestre quadrate si veggono
nella vôlta del laconicum ed eran chiuse con
vetri, lapis specularis, e vietavano l’entrata dell’aria.
La seguente iscrizione venne decifrata sui bordi del
bacino, scrittavi in lettere di bronzo:
[213]
GN. MELISSARO GN. F. APRO. M. STAIO. M.
F. RVFO II. VIR. ITER. I. D. LABRVM EX D. D.
EX P. P. F. C. CONSTAT H. S. DCC. L.[200]
Tutte le altre località minori valevano al servizio
dei bagni.
La rimanente porzione dell’edificio è occupata da
un altro appartamento distribuito sull’identico principio
che ho esposto, avente un solo ingresso, e serviva,
secondo l’opinione di molti, per i bagni separati
delle donne. Esso era più piccolo di quello destinato
agli uomini, ma non appariva in ricambio
nè più elegante nè più grazioso: dal primo tempo di
loro scoperta furono detti bagni rustici e si credettero
destinati invece alla povera gente.
Ricordo qui come per gli scavi venissero in questi
bagni trovati un materozzolo di quattro strigili,
un vaso di profumi ed uno specchio, il tutto in
bronzo, e si conservano tuttavia nel Museo.
In quanto a ornati e cose d’arte, nel frigidarium si
notò un fregio in istucco rappresentante carri ed
amori pieni di espressione; e nel tepidarium una sequela
di piccoli atleti, detti telamoni, in terra cotta
che simulano sforzo per sostegno della cornice che
[214]
posa sulla loro testa. La vôlta poi è lavorata a cassettoni
dipinti in rosso e in azzurro; in ciascuno,
de’ bassi rilievi leggiadri esprimenti Cupido che s’appoggia
sul suo arco, Amorini a cavalcione di mostri
marini, altri guidanti delfini o ippogrifi, o suonanti
de’ timpani, un centauro, un Pegaso, un Ercole fanciullo
seduto sul leone, e dappertutto poi si vedono
festoni con ghirlande di fiori.
Frigidarium, tepidarium e caldarium hanno egualmente
bei pavimenti di musaico.
Il lettore non ci vorrà pertanto negar ragione di
aver detto di questi bagni o terme come si vogliano
chiamare, che se non avevano tutta l’esorbitanza della
magnificenza e del lusso delle più celebri terme di
Roma, spiccavano nondimeno per i pregi della migliore
semplicità e per l’eleganza.
La descrizione delle singole parti dei Bagni Publici
che ho appena terminata, mi renderà più spiccio
nel dire delle Terme Stabiane, così appellate dal
ritrovarsi esse sulla via detta di Stabia.
Questo grande stabilimento è isolato da tre lati e
v’ha chi con assai buona ragione sostiene che fossero
bagni più antichi de’ precedenti che abbiamo
visitato. Qualche argomento in proposito avverrà di
trovare più avanti.
Intanto ci arresta a prima giunta una particolarità
che non han gli altri bagni, una palestra, cioè,
o più propriamente un ginnasio; perocchè la palæstra
[215]
fosse il luogo dove gli atleti che dovevano esporsi
ne’ ludi publici si esercitassero nel pugilato e nella
lotta, mentre il gymnasium fosse un luogo imitato da
quell’istituto di Grecia, nel quale la gioventù si procurava
ricreazione ne’ giuochi ed esercizi corporali.
Pressochè ogni città greca aveva il suo ginnasio: i
resti di quello di Efeso stanno a ricordanza di quella
istituzione, che presto divenne in Roma e nelle altre
città che si reggevano a forma di Roma una parte
interessante, direi quasi indispensabile di ben ordinate
terme.
Quante maniere di comodi avesse un ginnasio lo
si apprenda da Vitruvio.
«Nella palestra dunque si fanno i porticati quadrati,
o bislonghi che sieno in modo che il giro attorno
sia un tratto di due stadii, che i Greci chiamano
δίαυλον: tre di questi portici si fanno semplici,
e il quarto che riguarda l’aspetto di mezzogiorno,
doppio, acciocchè nelle pioggie a vento non possa
lo spruzzo giungere nella parte interiore. Ne’ porticati
semplici vi si situano scuole (exedræ) magnifiche
con de’ sedili, nei quali stando a sedere possano
fare le loro dispute i filosofi, i retori e tutti
gli altri studiosi.
«Nel porticato doppio poi si situano questi membri.
Nel mezzo l’Efebeo[202]: questa è una scuola grandissima
[216]
con sedili e deve essere lunga un terzo più
della larghezza: a destra il Coriceo[203]: immediatamente
appresso il Conisterio[204]: appresso a questo,
appunto nell’angolo del portico, il bagno freddo da’
Greci detto λοὒτρον: a sinistra poi dell’Efebeo l’Eleotesio[205]:
accanto all’Eleotesio il Frigidario: da
questo, e giusto nell’altro angolo del portico, il passaggio
del Propnigeo[206]: accanto, ma d’altra parte
intorno e dirimpetto al Frigidario, viene situata una
stufa a vôlta (concamerata sudatio) lunga il doppio
della larghezza: questa tiene ne’ cantoni da una
parte il Laconico e dirimpetto al laconico il bagno
caldo. I porticati dentro la palestra debbono essere
[217]
distribuiti con quella perfetta regola che abbiamo
detta altrove.
«Al di fuori poi si fanno tre porticati, uno all’uscio
della palestra, i due altri stadiati[207] a destra
e a sinistra: di questi quello che guarda il settentrione,
si faccia doppio e spazioso, l’altro semplice,
ma in modo che tanto dalla parte del muro, quanto
dalle colonne vi resti un tratto come una viottola,
non meno larga di dieci piedi, il mezzo sia sfondato
per un piede e mezzo dalla viottola al fondo; al
quale si scende per due scalini: il piano del fondo
non sia meno largo di dodici piedi. In questo modo
coloro che vestiti passeggeranno intorno per la viottola
non saranno incomodati da lottatori unti che si
esercitano. Questo portico si chiama da’ Greci ξὐστὸς[208]
perchè vi si esercitano i lottatori in stadii coperti
ne’ tempi di inverno.
«I sisti poi si fanno in questo modo: hanno fra
due portici a piantarsi boschetti o platani, e in essi
viali spalleggiati da alberi con de’ riposi fatti di
smalto. Accanto al sisto ed al porticato doppio si
[218]
lascino i passaggi scoperti, che i Greci chiamano
παρκὸρομίδας, e noi chiamiamo sisti, ne’ quali anche
d’inverno, ma a ciel sereno, escono dal sisto coperto
ad esercitarsi i lottatori. Dietro a questo sisto vi
vuole uno stadio fatto in modo che vi possa stare
molta gente con agio a vedere i lottatori[209].»
Il Ginnasio in Pompei, chiamavasi palæstra, come
di questa voce si serve pure Vitruvio nella citazione
che ho finito di fare. Tanto si raccoglie da un’antica
iscrizione, incisa su d’una tavoletta di travertino, trovata
in una sala di questi bagni il 15 maggio 1857,
secondo si rileva dalla succitata opera del commendatore
Fiorelli e che suona così:
C. VVLIVS C. F. P. ANINIVS C. F. II. V. I. D.
LACONICVM ET DESTRICTARIVM
FACIVND . ET PORTICVS ET PALAESTR.
REFICIVNDA LOCARVNT EX D. D. EX
EA PEQVNIA QUOD EOS E LEGE.
IN LVDOS AVT IN MONVMENTO
CONSVMERE OPORTVIT FACIVN.
COERARVNT EIDEMQVE PROBARV[210].
[219]
Questa iscrizione ci apprende doversi ai duumviri
Cajo Vulio e Publio Aninio la ricostruzione di questa
palestra; ma non è sufficiente a dirci se tale rifacimento
fosse a seguito delle rovine cagionate dal
tremuoto del 63; perocchè si voglia anzi dalla natura
dei caratteri impiegati, inferirne anzi una data
d’un secolo e mezzo prima.
Ma se questo fosse, come conciliare tal fatto con
quanto afferma Vitruvio prima del brano che ho
testè riferito; nunc mihi videtur, tametsi non sint italicæ
consuetudines, palæstrarum ædificationes tradere
explicata et quemadmodum apud Græcos constituantur
monstrare[211], e con cui si vorrebbe escludere che al
tempo di questo illustre architetto e scrittore non fossero
in Italia conosciute le palestre? Or ritenendosi
comunemente non potervi esser dubbio ch’egli abbia
vissuto e fiorito sotto il regno d’Augusto, al quale
egli dice nella Prefazione dell’Opera sua d’essere
stato raccomandato dalla sorella di lui, non è possibile
accogliere l’illazione dedotta dagli archeologi
che l’iscrizione possa rimontare a tanto tempo addietro.
Del resto l’impiego di più vetusti caratteri non
può addursi a prova irrecusabile; perocchè potrebbe
essere stato un vezzo di chi li usò, come usiamo far
pur di presente.
[220]
La palestra pompejana era decorata di portici, doveva
avere la sua sala di giuoco alla palla, sferisterio,
se vi si trovarono ancora de’ globi di pietra, che avevano
servito appunto al giuoco della sfera, al quale
la gioventù si esercitava per acquistare forza ed elasticità
di membra.
L’ingresso principale è dal lato di mezzogiorno, e
presso di esso nel vestibolo, si ammira una bella
scultura romana rappresentante un Termine sotto le
forme d’una figura di donna molto elegantemente palliata.
Dal manco lato evvi un’ampia piscina pei balneanti;
intorno ad essa son disposte diverse camerette
per l’uso di essi. Una fra l’altre si distingue
per eleganza di pittura e per una nicchia rettangolare
destinata certo a contenere l’immagine di qualche
divinità protettrice del luogo. Questa nicchia è
fiancheggiata da due cariatidi che sostengono un bacino
ed all’ingiro è dipinta una zona a scomparti,
interrotta da paesaggi con pigmei e delfini.
Si pretende che siffatte pitture alludano al culto egizio
e si trae la congettura da ciò che i Greci d’Alessandria
stabiliti a Pompei e probabilmente in prossimità
delle terme abbiano dovuto contribuire d’assai alla
costruzione d’uno stabilimento che ricordava i loro
usi nazionali.
I muri del portico sono dipinti a specchi rossi incorniciati
d’una fascia gialla: le colonne di stucco
[221]
rosse verso la base, sono bianche nella parte superiore
e sormontate da capitelli pure in istucco che
sostengono una cornice di squisito lavoro, se si argomenta
da un frammento che si ritrovò e si ricollocò
al suo posto.
Dal lato di mezzogiorno poi, nell’ottobre 1854, fu
scoperto un bel quadrante solare, formato d’un semicerchio
praticato in un rettangolo, sostenuto da zampe
di leone, con eleganti fregi ai lati. Il gnomone collocato
orizzontalmente nel centro dei raggi convergenti
è perfettamente conservato. L’iscrizione osca che vi
era, fu letta dall’illustre archeologo cav. Giulio Minervini
di questo modo: Marius Atinius, Marii filius,
quæstor, ex multatitia pecunia conventus decreto fieri mandavit[212].
Questo monumento è certo interessante: ci
attesta per lo meno che, anche dopo essersi stabilita
la colonia romana, in Pompei si usasse della lingua
osca, e mi conforta nell’idea che mi sono formato
ch’essa anzi durasse viva continuamente sulla bocca
del popolo.
Dalla palestra poi si facea passaggio al bagno degli
uomini: per le donne dovevano esser quelli ai quali
si accedeva dalla Via di Stabia.
La prima sala del bagno degli uomini era il frigidario:
tutte le pareti all’interno dipinte in azzurro
[222]
hanno nicchie rettangolari come a ripostigli di vasi
di unguenti e di profumi odorosi. Doveanvi essere
pitture sulla volta e sulle muraglie, ma la prima
crollò, e sulla seconda a sinistra non rimase che un
pezzo di nudo di donna accosciata.
A destra di questa sala s’apre il tepidario, le cui
muraglie hanno un doppio fondo, per la circolazione
del vapore che per siffatta guisa moderava il calore
dell’atmosfera; all’estremità sta il baptisterium che doveva
essere rivestito di marmi, arguendovisi ciò dalla
impronta lasciatavi dalle tavole di marmo che vi
stavano, vi lasciarono impresse le lettere d’un’iscrizione
che così si arrivò a decifrare dal sullodato
Minervini:
IMP. CAESARI
DIVI FILI
AVGVSTO IMPERATORI
XIII TRIB. POTESTATE XV
PATRI PATRIAE COS. XI[213].
La sala che segue era destinata al caldarium, o
sudatorium altramente detta. Come il tepidarium, aveva
il pavimento detto suspensura, costruito cioè alto da
terra, sorretto da specie di tegole di terra cotta, quadrate
e con peducci, e valeva a permettere che il calore
[223]
potesse liberamente circolare sotto di esso. Doppie
pure son le pareti tinte in rosso, con pilastri in
giallo a capitelli bianchi. Un bacino circolare stava
da un lato della sala e nel mezzo di esso zampillava
un getto di acqua bollente che contribuiva a rendere
più caldo l’ambiente.

Tepidarium delle antiche Terme in Pompei. Vol. II. Cap. XV.
Il destrictarium, di cui si è fatto cenno nella surriferita
iscrizione, che in un col laconicum venne provveduto
dai duumviri Cajo Vullo e Publio Aninio,
stava rimpetto all’ingresso della palestra ed era quella
località in cui i balneanti praticavano l’operazione
dello strigile all’uscir del bagno. È forse la prima
volta che si trovi questa sala così designata, non rinvenendosi
la voce destrictarium in alcun dizionario,
essendovi derivata forse da destringere, raschiare.
Si sa che tale operazione di polirsi la pelle collo
strigile era così usata e congiunta al bagno stesso,
che i ricchi usavano portare gli strigili seco al bagno,
ivi mandandoli a mezzo de’ loro servi, come si raccoglie
da Persio:
I, puer, et strigiles Crispini ad balnea defer,[215]
che ogni stabilimento termale di qualsiasi città ne
fosse largamente provveduto, e che nel bagno de’ poveri,
dove questi arnesi non erano, nè eranvi le altre
[224]
delicature, i bagnanti, a vece degli strigili, si fregassero
contro le muraglie.
Contasi a tale proposito un aneddoto. Un giorno
l’imperatore Adriano, visitando la terme di Roma, gli
venne dato di scorgere un povero veterano che si
stregghiava in questo modo contro il muro e che gli
avesse a dare denari e schiavi onde potersi per l’avvenire
farsi strigilare dopo il bagno; e che ritornato
Adriano dopo qualche dì nello stesso luogo, uno
sciame di poveri affettasse, appena accorti di sua presenza,
di far altrettanto di quello aveva praticato il veterano,
sfregandosi a tutta possa la schiena contro il
muro; ma che allora l’imperatore argutamente avesse
a consigliarli a fregarsi piuttosto gli uni gli altri.
A sinistra del destrictarium, in un lungo corridojo
che dava su d’un viottolo, trovansi quattro camerette,
solia, certo riserbate a bagni isolati, poichè vi si trovassero
le rispettive vasche in muratura.
Le sale pei bagni delle donne, a cui entravasi per
la via di Stabia, erano pur degne di attenzione. Una,
a gran volta con eleganti opere in istucco e pavimento
in marmi, serve a ricevimento ed ha proprie nicchie,
in numero di ventinove, per gli olj, le essenze e le
lampade per quando vi si veniva o se ne usciva di
notte. Tutt’all’ingiro corre un sedile di materia laterizia,
e doveva valere anche per apodyterium o spogliatoio.
Un’altra sala, circolare e pure elegante e con quattro
[225]
nicchie per deporvi le vestimenta, ed una quinta
per dar passaggio a un getto d’acqua, serviva pel
bagno freddo; un’altra pel tepidario ed un’ultima pel
sudatorium, ambe queste a suspensura per la circolazione
del vapore. Dovevano avere stucchi e pitture,
ma il loro deperimento non permette che riscontrarne
qualche reliquia appena.
Sul muro del vestibolo che separa il bagno degli
uomini da quello delle donne evvi una pittura in
giallo, rosso e verde, che raffigura un’ara ed un
serpe che le si avvicina, e tali sacri emblemi, secondo
Dyer, sarebbero valsi come di divieto agli uomini
di non avanzare nell’appartamento riservato
alle donne.
Eguale sistema nella distribuzione dei locali, come
nel loro uso che abbiam veduto adottato per le terme
e pei bagni publici, seguivasi pure ne’ balinei, o bagni
de’ privati.
Vediamo, a mo’ d’esempio, adesso il balineum appartenente
alla villa suburbana di Pompei di Marco
Arrio Diomede, e del quale m’ero riserbato di parlare
nell’esordire di questo capitolo.
I bagni e loro pertinenze occupano un angolo ad
una estremità dell’intero edifizio e vi si entrava dall’atrium
mediante una porta. Immediatamente a destra
è una cameretta, forse usata come sala di aspetto, o destinata
fors’anco agli schiavi addetti a questa bisogna
dell’azienda domestica. Più in là l’apodypterium era situato
[226]
fra i bagni caldi e freddi, ed aveva un’entrata
separata ad amendue.
Presso vi è un cortiletto triangolare coperto in parte
da un colonnato, su due de’ suoi lati e nel centro vi
era la piscina, o natatio pel bagno freddo. In prossimità
dell’apodyterium era il tepidario, quindi la camera
termale o calidarium, col laconicum all’estremità circolare,
e all’altra estremità l’alveus, o bagno d’acqua
calda.
V’è inoltre il serbatojo generale per l’alimentazione
dei bagni, la cisterna dell’acqua fredda, il sito
per la caldaja dell’acqua calda; non che quello per
la fornace e la stanza ad uso degli schiavi che la servivano.
Ora l’ordine mi imporrebbe indagare se in questa
città vi fossero ninfei; ma senza ritornare sulla questione
del loro significato, poichè non se n’è finora
precisato alcuno, noterò invece che diverse erano le
fontane sparse per ogni parte della città. Già nel corso
dell’opera m’avvenne di rammentarne qualcuna; ora
completerò alla meglio il discorso intorno alle stesse.
Quasi tutte le vie scoperte di Pompei mostrano
aver avuto fontane, il più spesso collocate sull’angolo
di crocicchi: anzi, come vedremo nel capitolo delle
Case, la maggior parte degli edificj avevano fontane,
impluvii e puteali: come poi ricevessero le acque,
oltre il già detto, toccherò più avanti.

Fontane, Crocicchii di Fortunata in Pompei. Vol. II. Cap. XV.
Le fontane publiche sono pressochè tutte eguali e
[227]
di una rara semplicità; perocchè si compongano d’una
vasca formata da cinque pietre vesuviane riunite con
legacci di ferro e sulla pietra posteriore un’altra se
ne alza più alta, nella quale è scolpita in rilievo
una testa di lione o d’altro animale o un mascherone,
dalla bocca de’ quali esce l’acqua per versarsi
nel sottoposto bacino.
Alcune fontane ottennero negli scavi nomi particolari:
tali sono quelle dette dell’Abbondanza, all’ingresso
del vicolo della Maschera, perchè reca sovra
il bacino una figura scolpita con cornucopia; del Bue
che dà il nome alla via, perchè l’acqua vi è emessa
da una testa di quest’animale; di Mercurio, perchè il
suo cippo ha una testa di questa divinità che dà pure
il suo nome alla via nella quale si trova, e su d’un
muro dicontro la fontana fu dipinto questo dio in
atto di fuggire stringendo una borsa; di Venere sulla
via di Stabia raddossata alla così detta Casa del forno,
o come la chiama Dyer, la casa di Modesto per esservisi
veduto appunto scritto su di essa il nome MODESTVM,
perchè sormontata da una testa grossolanamente
sculta e con una sola colomba; di Rotonda sull’angolo
di Vico Storto, per la sua forma che differenzia dalle
altre; della Viottola del Teatro, i cui bordi o margini
s’alzano di poco dal marciapiede, e però è difesa
d’una inferriata, ecc.
Se ogni via finora dissepolta ebbe la sua fontana;
se fontane troveremo in tante case, se terme publiche
[228]
e bagni privati esistevano, è necessaria l’illazione
che dunque copiosissima dovesse essere l’acqua in
Pompei.
Vi bastava a ciò l’acqua del fiume Sarno? Vi sarebbe
bastata se il suo livello fosse stato alto; ma sapendo
già noi come questo fiume fosse a livello del
mare, per formare il bacino di comunicazione e per
essere perfino navigabile per un tratto di strada, come
abbiam già veduto, e il Sannazzaro dicendolo eziandio
impiegato alla irrigazione de’ campi
. . . . pinguia culta vadosus
Irrigat, et placido cursu petit aequora Sarnus[216];
non era assolutamente possibile che bastasse a tanto
bisogno, molto più che sappiamo che la città dal
mare si veniva su su adagiando pel declivio montuoso.
Acquedotti saviamente praticati vi dovevano
indubbiamente, secondo il sistema in que’ tempi
generalizzato, derivar l’acqua da lungo, e così provvedere
pe’ suoi mille condotti di ramificazione anche
a tutte le fontane e serbatoj dalla parte più alta della
città.
Infatti, in ogni parte di essa vennero trovati canali
e condotti in muratura, in terra cotta ed in piombo;
[229]
le case poi hanno latenti nelle muraglie siffatti tubi
di piombo e in più luoghi, ad attestarlo, mettono
fuori tra le macerie e le rovine i loro capi e provano
quanta fosse la cura e l’importanza che si aggiungeva
ad aver copia di acqua ovunque.
Il canonico Andrea De Jorio, nella sua Guida
di Pompei, dedicò un’appendice a bella posta
per le indagini sulle sorgenti che conducevano le
acque alle terme, e giova ricorrervi per avere una
certa luce nell’argomento, che pur fu soggetto a tante
controversie. Pose prima per base il livello attuale
del Sarno, il suo canale attuale che passando per
Pompei trasporta le acque alla Torre dell’Annunziata;
l’impossibilità che vi era che il suo livello potesse
alimentare tutte le fontane di Pompei e infine tenne
conto degli avanzi di antichi acquedotti, che sono
nell’antico territorio di Sarno egualmente che nella
città di Pompei. Esaminò poi la natura de’ condotti
trovati dall’architetto Domenico Fontana, quegli che
fu incaricato di condur l’acqua a Torre dell’Annunziata,
e li dichiarò ramificazioni del principale antico, che
doveva derivare dal luogo detto la Foce, o sorgente
del Sarno; giudicò che la sorgente, che apprestava
l’acqua all’antica Pompei fosse più alta di quella
che oggi alimenta il canale detto del Conte.
Derivata per tal modo l’acqua dai monti e dalle sorgenti
del Sarno, distribuivasi per tutta la città a mezzo di
canali costruiti sotto le vie, per la cui manutenzione
[230]
di tratto in tratto erano spiragli difesi da graticci di
ferro, e mercè delle conserve e delle pressioni che
esercitavano si faceva montare al livello dei getti
più o meno alti delle publiche fontane, e servire
ai bagni delle Terme ed agli altri dei quali ci siam
venuti intrattenendo.
Il tremuoto dapprima del 63 e il cataclisma ultimo
di Pompei sconvolsero ed ostruirono acquedotti
e canali, e le acque deviarono e per modo, che
ciò che allora poteva formar testimonio de’ savi provvedimenti
edilizi per la somministrazione delle acque
alla bella città, ora è divenuto astruso tema di congetture
e di studj, frammezzo a’ quali se il solito
dubbio, che, cioè, non vi fosse tutta quella copia di
acque che si dice, non s’è cacciato, si fu perchè ad impedirlo,
rimangono eloquenti i ruderi di aquedotti e
di fontane, di bagni e di stabilimenti termali, che ponno
essere tuttavia presi a modello e con buon frutto imitati
al presente.
[231]
CAPITOLO XVI.
Le Scuole.
Etimologia — Scuola di Verna in Pompei — Scuola di Valentino — Orbilio
e la ferula — Storia de’ primordj della coltura
in Italia — Numa e Pitagora — Etruria, Magna Grecia
e Grecia — Ennio e Andronico — Gioventù romana in Grecia — Orazio
e Bruto — Secolo d’oro — Letteratura — Giurisprudenza — Matematiche — Storia
naturale — Economia
rurale — Geografia — Filosofia romana — Non è vero che
fosse ucciditrice di libertà — Biblioteche — Cesare incarica
Varrone di una biblioteca publica — Modo di scrivere, volumi,
profumazione delle carte — Medicina empirica — Medici
e chirurghi — La Casa del Chirurgo in Pompei — Stromenti
di chirurgia rinvenuti in essa — Prodotti chimici — Pharmacopolæ,
Seplasarii, Sagæ — Fabbrica di prodotti
chimici in Pompei — Bottega di Seplasarius — Scuole private.
Se fu dato potersi formulare a proverbio: di’ con
chi tratti e ti dirò chi sei; parrebbe potersi eziandio
dire, di’ come si istruisca un popolo e ti dirò quanto
sia civile. Questo per adesso: forse non si poteva altrettanto
affermare ai tempi di Roma, dei quali m’intrattengo
col discreto e umano lettore.
Egli vedrà s’io mal non m’apponga nelle poche
pagine che ho riserbato alle Scuole, traendone argomento
[232]
dalle due di cui gli avanzi di Pompei ci han
tramandato memoria.
La parola, come tanta parte delle nostre e delle
latine, deduce l’origine sua dal greco. Schola scrissero
i latini e σχολή i greci, e vollero significare riposo
da fatica corporea, il quale dà opportunità di ricreazione
o di studio: così ci accadde già di ricordare
la schola o sedile in Pompei, ov’era l’orologio solare:
così schola chiamavansi quegli altri sedili in
muratura ch’erano nelle terme, e via discorrendo.
Presto poi venne adoperato il vocabolo ad esprimere
il luogo in cui i maestri e i loro scolari si raccolgono
per fine d’istruzione; nel qual unico senso fu quindi
ricevuto nell’idioma nostro.
Io, come dissi, dalle due scuole summentovate, di
cui ci è attestata da due iscrizioni l’esistenza in Pompei,
nonchè dal ritrovamento di ferri chirurgici, de’
quali verrò a intrattenere chi legge, partirò per indagare
l’indole dell’istruzione e della coltura intellettuale
d’allora. Senza di questo capitolo, crederei incompleto
il quadro che mi sono proposto di condurre
delle condizioni di Roma e delle sue colonie, del
quale mi danno causa e pretesto le rovine di Pompei.
Sotto il portico orientale del Foro civile di questa
esumata città, e che già a suo luogo ho descritto, si è
scoperta una vasta sala: nel fondo di essa è nel mezzo
una specie di nicchia; altre minori sono distribuite
tutte all’intorno, con porte agli angoli. Gau, scrittore,
[233]
la cui autorità ho più volte in addietro invocata, riconobbe
in tutte queste disposizioni, le disposizioni
stesse delle antiche scuole d’Oriente. La nicchia del
fondo avrebbe, secondo lui e con tutta ragione di
probabilità, servito di cattedra al maestro; quelle all’ingiro
spettavano invece agli scolari, per deporvi
abiti e libri. Siffatta supposizione fu universalmente
accolta e trovò il suo suggello di verità nella iscrizione
seguente, che stava scritta in caratteri rossi, oggi
affatto scomparsi, vicino alla porta, sull’angolo della
casa:
C. CAPELLAM D. V. I. D. O. V. F. VERNA CVM DISCENT[217].
Questa iscrizione valse di per sè ad imporre a
quella sala la denominazione di Scuola di Verna, e
i commentatori e scrittori di Guide a farne fuori un
maestro di scuola di ragazzetti d’ambo i sessi, una
specie di moderno asilo d’infanzia. Io mi permetto
di dubitare che potesse trattarsi di scolari di così
tenera età e molto meno di fanciulli d’ambo i sessi;
perocchè, se ciò fosse stato, qual valore si avrebbe
voluto aggiungere allora ad una raccomandazione in
una elezione amministrativa fatta da piccoli fanciulli
e da ragazzine? Doveva adunque essere, a mio avviso,
una scuola almeno di giovinetti.
Anche un’altra iscrizione, fra le tante che vi dovevano
[234]
essere state scritte sulla muraglia dell’edificio
d’Eumachia, venne trovata il 26 gennaio 1815[218], e
ci fa essa conoscere un tal Valentino, pur senza alcun
altro prenome, per un altro maestro: essa è così
concepita:
SABINVM ET RVFVM AED. R. P. D.
VALENTINVS
CVM DISCENTES (sic)
SVOS ROG[219].
È notevole e sorprende sulla bocca d’un maestro
un sì grosso strafalcione di grammatica come questo
cum discentes suos, in luogo di cum discentibus suis, e
dà la misura sì della scienza del maestro, che di
quella de’ magistrati che lo tolleravano. «Il avait, dice
a tal proposito Bréton, parlando di questa cima di
maestro e delle sue sgrammaticature, il avait certes
besoin d’invoquer la protection des Ediles.»
Ma ad altre considerazioni, più che di fredda grammatica,
queste zelanti raccomandazioni de’ maestri
di Pompei mi han fornito il soggetto e m’han condotto
ad una savia conclusione.
I tempi sono pur sempre i medesimi, mi son detto:
le più utili e virtuose istituzioni vengono sempre
falsate e guaste: le passioni degli uomini se le assoggettano
e sfruttano a loro profitto. Le sventure
[235]
e i danni d’ogni natura, che ad essi toccano, non
sono bastevoli lezioni ai popoli; oggi, come a’
tempi di Verna e Valentino, il greggie degli stipendiati
governativi e delle anime subalterne è pur sempre
l’eguale.
Non lamentiamoci poi adesso del pari di vedere a’
dì nostri, ne’ giorni delle elezioni politiche od amministrative,
sguinzagliarsi impiegati e poliziotti a portare
il loro voto in suffragio del candidato messo innanzi
dal partito che siede al governo della cosa
publica, o dalla così detta consorteria. Quest’ultima
ho già fatto altrove rilevare essere esistita anche allora;
Terenzio l’ha rammentata sotto il nome di comitum
conventus; onde hassi da noi a conchiudere tali
disordini dell’oggi essere nuove edizioni di vecchia
storia, più o meno accresciute ed illustrate, a beneficio
dei meglio accorti.
Questo Verna e questo Valentino di Pompei io suppongo
essere stati precettori in quella città della adolescenza,
della risma, o suppergiù, di quell’Orbilio, che
fu maestro in Roma di belle lettere e reso immortale
dal suo discepolo Orazio Flacco, il quale per vendicarsi
dei colpi ricevuti per avventura dalla ferula di
lui sulle mani e sulle spalle, lo ha marchiato, in una
delle sue Epistole, qualificandolo plagosus[220], quasi
produttor di piaghe, per aver fatto uso co’ suoi scolari
di sferze e di flagelli.
[236]
Nè doveva essere, a quanto pare, codesto sciagurato
vezzo esclusivo di Orbilio, ma generale ne’ pedagoghi,
s’anco Giovenale vi fece aperta illusione in quel
verso della Satira I, sui Costumi:
Et nos manum ferulæ subduximus.....[221]
e del barbarico costume, come avvien d’ogni cosa
brutta, è arrivata la tradizione infino a noi; perocchè
io non sappia davvero se dappertutto, malgrado i
divieti severi delle leggi e delle autorità, e più ancora
i postulati della civiltà, sia stato ovunque per
Italia diradicato, di gravi e sanguinose punizioni inflitte
da’ maestri a fanciulletti avendo a’ giorni di mia
infanzia udito più d’una volta lamentare.
Non chiamato a fare una completa monografia degli
studj in Roma e nelle Colonie a lei soggette, non ne
dirò ora che a larghi tratti, siccome è richiesto dalla
economia dell’opera.
Presso questo popolo gagliardo e primitivo, dedito
prima alle cure dei campi, poi a quelle dell’armi, gli
studj, o furono quasi e per lungo tempo sconosciuti,
o ne furono tardo pensiero. Il linguaggio medesimo
era ben lungi dall’avere quella sonorità, armonia e
maestà che assunse di poi nelle opere ammirabili
de’ suoi scrittori: aspro e duro, era più proprio a
comandar a’ soldati nelle battaglie; e se, al dir di
[237]
M. Catone, fu costume delle genti italiche di cantare
ne’ loro antichi dialetti inni e canzoni guerriere o
nenie pei caduti in guerra, sposandole al suono delle
tibie, ciò non attesta a favore di una avanzata civiltà.
Imperocchè consuetudine siffatta si riscontri
in tutte le genti rozze e bellicose. Ossian e i bardi
caledonici non cantarono che le imprese di eroi d’una
patria guerriera sì, ma non colta e civile. Ho già
toccato altrove, parlando delle origini del teatro,
come prima di Livio Andronico, Roma non avesse
teatro proprio, paga delle Sature degli istrioni d’Etruria,
e Andronico non fiorì che al principiar del
sesto secolo. Meglio dimostrerà la condizione intellettuale
e la nessuna coltura il singolarissimo rito usato
ancora nel quinto secolo per la numerazione degli
anni. Consisteva esso nel piantare nel muro del tempio
di Giove, che era il più venerato di Roma, un
grosso chiodo. Ciò facevasi alle idi di settembre solennemente
per mano de’ pontefici, e dove alcun
altro straordinario avvenimento si fosse voluto raccomandare
alla memoria de’ posteri, eleggevasi all’uopo
un dittatore che figgesse altro chiodo. E
questi chiodi, in mancanza di lettere, segnarono per
lungo tempo l’epoche più famose di Roma. Ecco le
testuali parole di Tito Livio: Eum clavum, quia raræ
per ea tempora erant litteræ, notam numeri annorum
fuisse ferunt[222]. L’aritmetica e la geometria non si
[238]
conoscevano se non tanto, quanto era necessario per
misurare un campo, o per far le faccende giornaliere.
Le loro cifre numeriche, osserva giustamente Francesco
Mengotti, rappresentano espressamente le dita
delle mani, che sono la prima aritmetica de’ fanciulli,
dei villici e della natura[223].
La medicina stessa, reclamata dalla sollecitudine
del corpo, distinta in sacerdotale e magica, rimase
involuta lungo tempo nelle ubbie superstiziose. Solo
poi, 263 anni prima di Cristo, Valerio Messala recò di
Sicilia un quadrante solare, come già dissi a suo luogo,
e appena 159 anni vennero da Scipione Nasica Corculo
introdotti gli orologi ad acqua o clessidre. Prima
i Romani erano rimasti per molti secoli senza neppure
conoscere la divisione in ore del giorno e della
notte e senza stromento alcuno per la misura del
tempo. Plinio il Vecchio scrisse che le Dodici Tavole,
compilate al principio del quarto secolo, non distinguevano
che il nascere e il tramontar del sole[224]:
dopo vi fu aggiunto il meriggio, che annunciavasi
dal banditor del console, quando il sole si trovava
fra la tribuna e la grecostasi. Allorchè dalla Colonna
Menia il sole inclinava alle carceri, era sera.
Pel corso di parecchi secoli i Romani non posero
alcun pensiero alla filosofia. Essi la conoscevano a
[239]
mala pena di nome. Occupati da principio in difendersi,
poi in rassodare la loro potenza sui vicini popoli
che avevan soggiogati, interamente pratica era
la sapienza che dalla esperienza avevano attinta. Un
mirabile buon senso derivò loro dalle difficoltà dell’esterna
lor posizione e dal godimento di una libertà
sempre perturbata, ma che per le stesse sue commozioni,
rinvigoriva gli animi e gli ingrandiva. Si è
voluto attribuire alla filosofia pitagorica qualche influenza
sulle instituzioni di Numa, e si è potuto con
tanto maggiore facilità unire insieme a quest’uopo
qualche tratto di rassomiglianza, in quanto che è
probabile aver Pitagora inserito nella sua filosofia
alcuni frammenti delle dottrine sacerdotali alle quali
Numa non era straniero. Ma ecco dove fermar si
deve ogni comunanza fra il greco filosofo e il re secondo
di Roma[225]. Forse invece di queste dottrine sacerdotali
di Numa e di altri legislatori a lui succeduti,
la ragione e l’origine dev’essere ricercata altrove, in
Etruria come verrò a notare.
Bisogno di studi elementari e di intellettuale coltura
si sentì, più per ispirito d’imitazione che per
altro, dopo che i Romani conobbero i Greci. Già sa
ognuno di là dedotte le leggi delle Dodici Tavole: là
unicamente reputavasi infatti la sede della scienza,
della poesia, dell’arti.
[240]
Erasi, è vero, per l’addietro usato mandar in Etruria
i giovani, per apprendervi i riti augurali, senza di
che non avrebbero acquistato valore i pubblici atti,
ed era molto se di là recavasi qualche tintura o conoscenza
di lettere. E sì che colà la coltura e la sapienza
erano più antiche che in Grecia, a cui per
avventura e da essi e dagli Atalanti, i progenitori
nostri, era ogni lume di civiltà e di sapere derivato.
Fu altrimenti adunque, quando ebbe luogo mercè le
conquiste fatte dalle armi romane, il contatto con la
Grecia: il dirozzamento cominciò ad operarsi tra’
Romani, e n’ebber merito in principalità gli Scipioni,
che tolsero a proteggere i letterati venuti di Magna
Grecia in Roma. Ogni partito volle avere schiavi
greci e, come sarebbesi scelto fra quelli sventurati
il celliere ed il cuoco; così venne cercato il pedagogo,
onde a’ figliuoli apprendere la lingua di
Omero. E la lingua greca divenne di moda, nè uomo
aspirar poteva al vanto di educato, se a lui famigliare
non fosse stato quel magnifico idioma. Quinto Catulo
comperò Dassi Lutazio per duecento mila sesterzj;
Livio Salinatore procacciò maestro a’ suoi figli quel
Livio Andronico, del quale tenni parola dicendo de’ Teatri;
Paolo Emilio riempì la casa di filosofi, di retori, di
grammatici, di pedagoghi e d’artisti d’ogni maniera; Scipione
l’Africano protesse Plauto e Terenzio, ed ebbe
amico e compagno di sue militari spedizioni Quinto
Ennio di Rudia in Calabria, che era stato richiamato
[241]
da Catone l’antico da Sardegna in Roma, e che, in
buona fede o no, affermava in lui trasmigrata l’anima
d’Omero.
Contuttociò, riguardavano i Romani gli studj, più
che altro, oggetto di adornamento e di ricreazione, e
Sallustio lasciò scritto: che i più assennati attendevano
agli affari, nessuno esercitava l’ingegno senza
il corpo; ogni uomo grande volea men tosto dire
che fare, e lasciava che altri narrasse le imprese di
lui anzichè narrar esso le altrui.
E poichè ho nominato ancora Andronico ed Ennio,
dirò che anche dopo l’epoca in cui i Romani strinsero
i legami coi Greci d’Italia e di Sicilia, essi non
iscorgevano tuttora che leggerezza, mollizie e corruzione
appo questi popoli, i quali dal lato loro li riguardavano
quai barbari[226]. Verso il fine della prima
Guerra Cartaginese, i Romani principiarono a conoscere
la drammatica letteratura de’ Greci. Alcune
tragedie greche tradotte da Andronico, il quale voltò
pure in versi latini l’Odissea, presero il luogo de’
versi fescennini, de’ giuochi scenici degli Etruschi, e
delle rozze farse Atellane degli Osci, come già sa il lettore
per quel che ne ho discorso, trattando de’ Teatri.
In quanto ad Ennio, non pago egli della buona
riuscita che ottenevano simili imitazioni, volle riportare
un nuovo trionfo, mercè una traduzione dell’istoria
[242]
sacra di Evemero, di quell’Evemero che
fu il primo a pretendere che i numi della Grecia non
fossero che uomini divinizzati, nati come noi e come
ogni ordinario mortale anche defunti. Appresso qualunque
altro popolo, un gran passo sarebbe stato codesto
nel filosofico agone, e forse tale era l’intendimento
del latino autore; ma sembra che i Romani non
abbian veduto di primo slancio delle ipotesi di Evemero
che un frivolo argomento di curiosità. Meno
sospettosi degli Ateniesi eran dessi, perchè nessuna
esperienza ancora gli avvertiva delle conseguenze
della filosofia sopra la falsa lor religione. Lo stesso
avvenne rispetto alla esposizione del sistema di Epicuro
fatta da Lucrezio. Queste due opere erano germi
gettati sopra un terreno non ancor disposto a riceverli.
De’ libri avevasi quindi sospetto, quasi intaccassero
le istituzioni e la religione patria; epperò essendosi,
durante il consolato di Cetego e Bebbio, dissotterrati
alcuni libri di filosofia, Plinio scrisse essersi
poi ordinato dal console Petilio di abbruciarli: combustos,
quia philosophiæ scripta essent[227].
È nondimeno nel senso che la coltura si venisse
più generalizzando e perfezionando per i Greci ed
importando nuove forme nella drammatica, che si
dovrebbero intendere i versi di Orazio, che altre volte
appuntai in addietro:
[243]
Græcia copia, victorem cœpit et artes
Intulit agresti Latio[228];
non già per dire che veramente l’importazione prima
della letteratura venisse proprio di là. Notai come
anzi gli incunaboli della poesia drammatica avessero
avuto nelle sature e nelle atellane origine assai prima
tra noi, e le Muse sicelides e i vari poeti e vati della
Magna Grecia fossero stati nostri.
A questi Greci, schiavi o liberti, che popolavan Roma,
dispensandovi la scienza, dai patriotti guardavansi in
cagnesco, e si giungeva perfino a trattarli da ladri e
peggio, e si poneva in canzone il loro grave sussiego
assai volentieri, e ridevasi di cuore alle tirate contro
essi in teatro, e il popolo tutto applaudiva. Così fu
all’entrar in iscena di Curculione in Plauto al declamar
di que’ versi:
Tum isti Græci palliati, capite operto qui ambulant,
Qui incedunt suffarcinati cum libris, cum sportulis,
Constant, conferunt sermones inter se drapetæ:
Obstant, obsistunt, incedunt cum suis sententiis
Quos semper videas bibentes esse in thermopolio:
Ubi quid surripuere, operto capituto, calidum bibunt
Tristes atque ebrioli incedunt....[229]
[244]
Marco Tullio, nel libro II de Oratore, c. LXVI, rammenta
del proprio avo, Marco Cicerone, come avesse
a dire: nostros homines similes esse Syrorum venalium;
ut quisque optimi græce sciret, ita esse nequissimum[231]:
lo che dimostra come non fosse disapprovata
questa grecomania dal volgo soltanto, ma ben
anco da uomini austeri e di autorità; perocchè quel
vecchio uomo dovesse nel suo municipio aver avuto
considerazione e voce, se aveva potuto con frutto farsi
oppositore a M. Gratidio, che proponeva la legge tabellaria.
Ma quantunque si affettasse questo publico sprezzo
per cotesti schiavi o liberti greci, nè si volesse far
credere che alle lettere nazionali si anteponesse la
stima e lo studio di quelle di Grecia; quantunque si
armasse perfino l’autorità del governo con editti e
leggi contro l’irruenza della straniera dottrina; pur
nondimeno accadde che gli uomini illuminati di un’età
[245]
più matura, astretti ad eleggere tra l’abbandono di
ogni filosofica speculazione, e la disobbedienza al
governo, furono condotti ad attenersi a quest’ultimo
partito dall’amore delle lettere, il quale allorchè ha
posto radice, cresce ogni giorno, perchè ha in sè
stesso la sua fruizione. Nè ciò fu tutto; avvegnacchè
tutti i patrizi non solo e i più facoltosi, ma
eziandio tutti quelli che appena l’avessero potuto,
dopo i primi studj in patria compiti, mandassero
per ciò i loro figli a perfezionarsi in Grecia. Era
una vera colonia di distinta gioventù romana, che
si trovava per conseguenza in Apollonia, in Rodi, in
Mitilene ed in Atene, eclettica e nella sua filosofia,
come ne’ suoi costumi; e sotto le ombre severe dell’Accademia
e nei giardini d’Epicuro si informava
essa a giganti progetti di guerra, egualmente che alle
severe discipline della vera eloquenza e della poesia.
Orazio medesimo, sebben figlio di liberto, si trovò
alla sua volta condiscepolo di Marco Bruto alla
scuola di Teonesto e di Cratippo; e fu colà per avventura,
che stringendosi in amicizia con quel fiero
repubblicano, potè per di lui mezzo ottenere dipoi il
comando d’una di quelle legioni, che soccombettero
nei campi di Filippi, e dove ei, gittando lo
scudo, certo non fe’ prova di molto valore.
Buon per lui nondimeno che nella Grecia aveva potuto
il suo genio spaziare più libero, aggraziarsi, profumarsi
e così preparare lo spirito a quelle innovazioni
[246]
nella poesia, da poter esser detto il primo de’ lirici
latini, anzi quello che creò la lirica latina. Inceppata per
lui, come per gli altri, era stata la educazione della
mente in Roma: essa erasi voluto costringere a limitarsi
alla sola conoscenza e studio delle cose antiche e già
troppo viete; ma con Livio Andronico, con Ennio, con
Nevio, Pacuvio, Accio ed Afranio soltanto non s’andava
innanzi. Va bene, dice Orazio, che sian codesti altrettanti
modelli; va bene che Roma tragga a’ teatri ad
applaudirli: il popolo talvolta vede giusto, ma talvolta
anche s’inganna. S’egli ammira gli antichi
autori, s’ei gli esalta al punto di nulla trovare che li
sorpassi, niente che loro regga a petto, s’inganna a
partito; ma s’egli ammette che ad ogni tratto si incespichi
con essi in termini che han fatto il loro tempo, e
in uno stile bislacco, è nel vero, e la pensa come noi.
Io non l’ho contro a Livio, nè penso che sieno da
annientare i suoi versi che mi dettava fanciullo Orbilio
di piagosa memoria; ma è egli poi giusto che
per qualche concetto, qui e qua brillante, per un
paio di versi un po’ meglio scorrevoli de’ restanti,
abbiasi ad andare in visibilio?...
Jam Saliare Numæ carmen qui laudat, et illud,
Quod mecum ignorat, solus vult scire videri:
Ingeniis non ille favet plauditque sepultis;
Nostra, sed impugnat, nos, nostraque lividus odit.
Quod si tam Graiis novitas invisa fuisset,
[247]
Quam nobis; quid nunc esset vetus? aut quid haberet
Quod legeret, tereretque viritim publicus usus?[232]
Del resto, come già notai, Plauto e Terenzio, che
pur formavano la delizia de’ romani teatri, avevano
dedotto le loro commedie dal greco; più liberamente
Plauto, che le ama almeno adattate a foggia nazionale;
meno invece Terenzio, ch’ei medesimo proclama
d’aver fedelmente tradotto Menandro e se ne reca
a vanto.
Ritemprata così la letteratura latina nella greca,
si preparò quello che si disse il secolo d’oro della
latinità. Tito Livio, Crispo Sallustio, Giulio Cesare,
Tacito e Cornelio Nipote nella storia; Cicerone, Ortensio,
Crasso, Cornelio Rufo, Licinio Calvo ed
altri molti nell’eloquenza, la quale però coll’avvenir
dell’impero perdette di sua libertà e di molta parte
di suo splendore; Catullo, Tibullo, Virgilio, Orazio,
Properzio, Ovidio, Cornelio Gallo nella poesia, chiamano
ancora la nostra ammirazione e formano tuttavia
[248]
l’oggetto de’ nostri studi: essi poi capitanavano
una schiera di molti altri ingegni minori.
Coll’eloquenza, di cui ho ricordato i campioni, pur
la giurisprudenza offrì le egregie sue prove e i suoi
valorosi cultori. Sesto Elio Peto (184 anni av. G. C.)
publicò l’Jus Civile Elianum e furono celebri giureconsulti
M. Porcio Catone, P. Mucio e Quinto Mucio
Scevola, che indagarono primi i veri principj del diritto
ed applicarono alla giurisprudenza la dottrina
morale degli stoici. Quando poi il potere supremo si
accolse nelle mani di un solo, i rescritti, i decreti,
gli editti e le costituzioni degli imperatori dischiusero
nuova fonte alla scienza del diritto, che si vide
collegata alla filosofia. I più rinomati giureconsulti
del tempo di Cicerone furono L. Elio, Servio Sulpizio
Rufo e A. Ofilio; sotto Augusto C. Trebazio
Testa, P. Alfeno Varo, autore de’ Digestorum, Libri XL,
che si conservarono nel Digesto. M. Antistio Labeone
e C. Ateio Capitone originarono due sette, che discordavano
tra loro ne’ principj da seguire nelle
consulte: il primo inclinando al rigoroso diritto; il
secondo all’equità. I loro discepoli Masurio Sabino
(20 anni dopo C.) e Sempronio Proculo (69 anni
dopo C.) diedero a tali sette estensione maggiore, i
primi attenendosi alle sentenze degli antichi giureconsulti;
i secondi ai principj generali del diritto.
Più sopra accennai come nei primi cinque secoli
Roma si trovasse sprovveduta affatto d’ogni nozione
[249]
di matematica: essa quindi le attinse, come per gli
altri rami dello scibile, a fonti greche, piuttosto occupati
della pratica applicazione nello scompartimento
dei terreni, nella disposizione degli accampamenti
e nella costruzione dei grandi e sontuosi edifizi.
Tra gli scrittori che si distinsero in siffatta materia,
primeggia Marco Vitruvio Pollione, coll’opera
sua De Architectura in dieci libri, a lui commessa da
Augusto ed alla quale ho tante volte in questa mia
ricorso, perocchè sia utilissima per la storia e la
letteratura dell’arte presso gli antichi e contenga viste
elevate e filosofiche, comunque talvolta pecchi
di oscurità, e di disordine.
Lo studio della natura vantò a suo principale cultore
Cajo Plinio Secondo Maggiore o il Vecchio (23-79
anni dopo G. C.) del quale ho già a lungo parlato
nel dire del cataclisma pompejano; l’Economia rurale
mette innanzi L. Giunio Moderato Columella, che
scrisse dodici libri De Re Rustica; e la Geografia
Pomponio Mela che ne dettò, circa al tempo di Nerone,
un compendio in tre libri: De situ Orbis, tratto
in gran parte dalle opere greche, ma con molta accuratezza,
giudizio e critica.
E così fiorirono parimenti le scienze. Ho già notato
le cause per le quali il nascimento e lo sviluppo
d’una filosofia nazionale in Roma, fosse pressochè
impossibile, giacchè il genio speculativo dovesse necessariamente
essere alieno dallo spirito pratico politico
[250]
e guerriero dei Romani. Essi infatti non entrarono
mai nella sfera dei problemi filosofici per esercitarvi
la loro attività individuale. Si accontentarono
di scegliere e di adattare fra i sistemi della greca filosofia
quelli che lor parvero più acconci alla vita
politica ed alle abitudini private e solo a quando a
quando si risvegliò tra essi qualche interessamento
e di gusto per la filosofia quando fu creduta mezzo
di sviluppamento intellettuale o di progresso. La filosofia
stoica era la più consentanea all’indole romana
e in tempi di corruzione e di despotismo essa
fu il rifugio delle anime temprate a robusto sentire,
ch’ebbero forza di levarsi al disopra del depravamento
del proprio secolo. Negli ultimi anni della Republica
la filosofia platonica vi fu favorevolmente
accolta, perocchè offerisse all’oratore negli ajuti della
sua dialettica e dottrina di verisimiglianza alcuni
reali vantaggi; ma poi quando i costumi degenerarono,
i Romani divennero seguaci per lo più della
filosofia di Epicuro, come quella che porgesse ad essi
ciò che ad essi abbisognava, un codice, cioè, di prudenza
e le norme del piacere; finchè più tardi, sotto
l’imperio di Marco Aurelio per breve momento
sfolgoreggiò una più vera filosofia. Quella di Aristotele,
che in Grecia aveva trovato sì gran numero di
proseliti, in Roma parve oscura, nè ebbe attrattive
per menti straniere alle astratte speculazioni e più
curiose che meditabonde; e non fu quindi che più
[251]
secoli dopo che invadesse le scuole in Italia e che,
puossi dire, essere stata regolatrice delle medesime
infine al chiudersi del medio evo; onde fosse nel
vero l’Allighieri, quando di questo sommo ebbe a dire:
Vidi il Maestro di color che sanno
Seder tra filosofica famiglia:
Tutti l’ammiran, tutti onor gli fanno[233].
Si è voluto rinfacciare alla filosofia d’Epicuro, anzi
alla filosofia in genere, la cagione della caduta della
libertà, e si è accusata leggieramente di secolo in
secolo con una maravigliosa facilità, come quella che
avesse condotto la rovina di Roma: ma tale accusa
fu ingiusta. Tutti gli uomini che difesero la republica
furon filosofi. Varrone meritò di essere proscritto dai
Triumviri, e scampandone appena dalle persecuzioni,
perdè la biblioteca e i suoi scritti: Bruto amava siffattamente
le greche dottrine, che non eravi al suo
tempo, come ci narra Plutarco[234], setta alcuna che
da lui conosciuta non fosse. Catone morì leggendo
Platone. Cicerone, durante il corso della sua operosa
e gloriosa carriera di tanto vantaggio al libero reggimento
di Roma sì che la salvasse dalla cospirazione
di Catilina, mai non cessò di consacrare alla filosofia
tutti i momenti che potè ritogliere a’ suoi doveri
di oratore, di soldato e di cittadino. Fin dalla sua
[252]
infanzia intimo amico di Diodoto, poi discepolo di
Possidonio e protettor di Cratippo, egli aveva caro di
ripetere che andava tenuto della sua dottrina e della
sua eloquenza molto più alla filosofia, che non alla
retorica propriamente detta, e mostrò saperla mettere
in pratica, quando seppe ricevere il mortal colpo
senza dar segno di debolezza, castigandosi per tal
modo d’avere sperato in Ottaviano.
La storia pel contrario non ci trasmise che i distruttori
della romana libertà nutrissero per la meditazione
un pari amore.
Non ci vien narrato che Catilina fosse filosofo; Cesare,
al principio di sua funesta carriera, professò
in senato principj di triviale irreligione e grossolani
assiomi, cui probabilmente questo giovane cospiratore
aveva raccolti ne’ suoi intervalli delle sue dissolutezze
e delle sue trame. Il voluttuoso Marc’Antonio,
l’imbecille e codardo Lepido e tutti quelli avviliti
senatori e que’ centurioni feroci, di cui gli uni
tradirono, gli altri dilaniarono Roma spirante, non
si erano, a quanto si sappia, formati a nessuna
scuola di filosofia.
Tutto questo movimento letterario e scientifico in
Roma per altro non era che un possente riflesso
della greca letteratura e dottrina, e della quale fu anzi
tanta l’influenza che, se il latino idioma doveva necessariamente
essere il linguaggio della magistratura,
il greco divenne quello della coltura e dell’eleganza.
[253]
Questo si parlò nella conversazione, nella
famiglia e perfin nell’amore, dove trovasi più soave
appellar l’amica, come notò con derisione Marziale,
dicendola ζωή, ψυχὴ, cioè vita e anima; e Orazio raccomandò
nell’Arte Poetica, a’ Pisoni il continuo studio
dei greci esemplari:
vos exemplaria græca
Nocturna versate manu, versate diurna[235].
Già qualche cosa, parlando della lingua usata in
Pompei, trattai della coltura in questa città: ora con
quanto ho testè detto di Roma, rimane completato
per riguardo a Pompei; perocchè ripeto le provincie
e più ancora le colonie seguissero in tutto l’andamento
della capitale.
Gli schiavi poi applicati a copiar manoscritti provvidero
i privati di buone biblioteche. Già Paolo Emilio
aveva dato l’esempio di cosiffatta raccolta, trasportando
a Roma quella di Perseo re di Macedonia da
lui vinto: Silla aveva fatto altrettanto trasportando
da Atene quella di Apellicone Tejo; e più ricca l’ebbe
il fastosissimo Lucullo: Cicerone aveva di libri fatto
egli pure incetta; ma tutte finallora erano state proprietà
private. Chi pensava a dotarne di una il publico,
quale era stata a Pergamo ed Alessandria, incaricandone
[254]
Varrone, reputato il più dotto de’ suoi tempi,
fu Cesare, ajutato poi in questo suo egregio pensiero
da Asinio Pollione, dopo che Cesare era stato da
morte impedito di condurlo ad effetto. P. Vittore
conta ventinove biblioteche in Roma, ultima fra le
quali quella di Marziale, che ne’ suoi epigrammi non
può resistere all’amor proprio di ricordarla.
Pompei non aveva biblioteche pubbliche, nè forse
l’ebbe pur Ercolano: almeno traccia di esse non presentarono
finora gli scavi; ma e di una città e dell’altra
ho già a suo luogo nondimeno osservato quanti
papiri siansi raccolti mezzo arsi e con sommo artificio
svolti e interpretati; quantunque finora non si possa
dire d’essersi vindicato dall’azione distruggitrice del
tempo un’opera qualunque che fosse di una grande
importanza.
Volendo or qui toccare alcun che del modo tenuto
nello scrivere, poichè altrove ho già detto delle tavolette
cerate, e pur altrove ed anche adesso de’
papiri e delle pergamene, accennerò come su queste
ultime scrivessero in fogli non ritagliati e quadrati,
nè da ambe le facciate, come usiamo noi; ma per il
lungo, e da una sola parte, ed acciò la grandezza
non cagionasse impedimento nello scrivere, per fissarla,
usavano d’una bacchettina di cedro o d’ebano,
con capi d’oro o di gemma, indi piegassero la carta
arrotolandola, e per questo rivolgimento avesse a
nascere il vocabolo di volume, volumen.
[255]
La gente d’umile condizione scriveva pel contrario
d’ambe le facciate; lo che venne mano mano in
uso anche degli scienziati; onde Cicerone scrivendo
ad un suo famigliare, avesse a dire d’aver sentito
gran dispiacere nel leggere la prima facciata della
lettera di lui e grande contentezza nel voltar l’altra[236];
Giovenale parlasse di una certa tragedia scritta in
questa foggia[237]; Marziale ad accennare del proprio
libro stesso così scritto[238]; e Plinio il Giovane, finalmente,
scrivendo a Marco, dandogli conto d’alcune
opere eredate dallo zio, l’illustre naturalista, in ispecie
gli narrasse di censessanta commentarii scritti da una
facciata e dall’altra[239].
Le iscrizioni e titoli delle opere, secondo ne fa fede
Vitruvio[240], venivano ornate con minio, e le carte
stropicciate sottilmente con olio di cedro, proveniente
dal Libano, non tanto per conservarle dal tarlo,
quanto per renderle odorose; onde Orazio, nell’Arte
Poetica, a significare opera meritevole d’immortalità,
in quel modo che si credevano durar le cose unte
coll’olio di cedro, usò di questo concetto:
. . . . . cedro digna locutus;
e Ovidio non meno vi fece allusione nel primo libro
Dei tristi, in quel verso:
[256]
Nec titulus minio, nec cedro charta notetur.
Detto di queste particolarità, progredendo nel mio
tema, eran pure per la più parte fra gli schiavi, od
erano stranieri coloro che si applicavano alle discipline
mediche e chirurgiche: la prima però affidata
più all’empirismo che alla vera scienza.
Valga il seguente aneddoto:
Il figlio di Marc’Antonio, dando una cena a’ suoi amici,
vi convitava altresì Filota medico d’Amfrisso. Tra le
argomentazioni ch’era in uso a que’ tempi di proporsi a
tavola, Filota uscì in questa: V’è una certa febbre che
si vince coll’acqua fredda; chiunque ha la febbre,
ha una certa febbre; dunque l’acqua fredda è buona
per chiunque abbia la febbre.
L’insulso paralogismo, degno d’un puerile scolasticismo,
si meritò dallo spensierato Anfitrione i
più ricchi donativi.
E valga pure il notare il passaggio, che fu anche
satireggiato da Marziale, di un medico alla vile condizione
del gladiatore:
Oplomacus nunc es, fueras ophthalmicus ante:
Fecisti medicus, quod facis oplomacus[241].
La medicina fu, tra le scienze, quella che a Roma
ottenne poco favore e vi fece minori progressi. Non
[257]
è già che ivi si mancasse delle cognizioni ausiliarie
su cui poggia la teoria della medicina; ma fino ai
tempi di Plinio il Vecchio venne abbandonata quale
occupazione illiberale, come già dissi, agli schiavi,
a’ liberti od a’ forestieri. In questa, come nelle altre,
i Greci la fecero da maestri, e fu Arcagato (535 di
Roma), a quanto ne attesta lo stesso Plinio[242], il
primo medico greco che gli iniziasse alla medicina.
Lucullo, Pompeo ed altri illustri Romani invitarono in
Roma parecchi greci di condizione libera per esercitarvi
quest’arte. Sotto Cesare, montarono in grande
stima, che vieppiù s’accrebbe regnante Augusto. Quest’ultimo
accordò loro rilevanti privilegi, i quali allettarono
più romani a dedicarsi, quantunque liberi,
allo studio e alla pratica di questa scienza.
V’ebbero così medici pubblici e privati. Questi ultimi
erano per lo più schiavi o liberti che abitavano
col padrone e lui e la famiglia sua unicamente assistevano,
o gli aderenti di casa.
I medici publici, ben lontani dal sentire la dignità
degli odierni, esercitavano il loro mestiere in una
bottega, alla quale ricorrevano coloro che avessero
[258]
avuto d’uopo di salassi, di operazioni chirurgiche
o di avere strappati i denti; suppergiù come anche
adesso in certi rioni di Napoli vedasi sulla bottega
di barbiere annunciato che si fanno anche salassi.
E si andava a tastone. Una determinata cura non
era riuscita a guarire una malattia, ebbene per essa
si ricorreva a farmachi affatto contrarj. Narrasi di
Antonio Musa, liberto di Augusto e amicissimo di
Virgilio, medico di corte e celebratissimo, tal che
gli furono eretti, a cagion di lode, statue e monumenti,
che avendo veduto che i bagni caldi non
avevano punto giovato al padrone aggravatissimo,
gli consigliasse i bagni freddi e questi adottati, l’avessero
a guarire. E del chirurgo Arcagato, del quale
ho parlato più sopra, come primo introduttore della
medicina in Roma, si racconta essere stato cotanto
sanguinario, che il datogli soprannome di vulnerario
gli venisse presto mutato in quello di carnefice.
Come maravigliare allora di quel che menzionò
Plinio il Vecchio dell’antico Catone avere scritto al
figlio: jurarunt inter se Barbaros necare omnes medicina.
Et hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit, et facile
disperdant. Nos quoque dictitant Barbaros, et spurcius
nos quam alios Opicos appellatione fœdant. Interdixi de
medicis[243].
[259]
Quindi è che ottenne fama e voga Asclepiade di
Prusia in Bitinia, che recatosi a esercitar medicina in
Roma un secolo prima di Cristo, deducendo le differenti
malattie da viziosa dilatazione o stringimento
de’ pori, e riducendo la medicina a rimedi che producessero
l’effetto contrario, voleva una cura limitata
a dieta, ginnastica, fregagioni, vino, uso di semplici
e divieto d’ogni farmaco violento ed interno. A lui
si attribuisce l’invenzione delle doccie, che si designarono
col nome di balneæ pensiles. Furonvi altri
medici che conseguirono celebrità, come il dottissimo
Aulo Cornelio Celso, vissuto a’ tempi d’Augusto, che
nulla per altro innovò, solo spiegando buon criterio
nell’adottare le dottrine de’ suoi predecessori, dettando
que’ libri, De Artibus, de’ quali otto sono ancora
superstiti[244]; e come Scribonio Largo Designaziano,
siculo o rodio del tempo di Claudio, che nel trattato
[260]
De Compositione Medicamentorum, che sussiste tuttavia,
ed è tenuto in poco conto, cercò combinare le dottrine
metodiche coll’empirismo, insegnando a non levare
il dente leso, ma levarne solo la parte guasta, e suggerendo
l’applicazione della elettricità pel mal di
capo, mediante una torpedine viva; ed Erodico da
Leonzio, che trovò la medicina ginnastica, curando
con violenti esercizj susseguiti da bagno, a un di
presso come farebbesi oggi a Grafenberg.
Claudio Galeno di Pergamo, di vastissimo ingegno,
studiosissimo della natura e dell’anatomia, non venne
in Roma che più tardi, al tempo, cioè, di Marco Aurelio
imperatore.
Piacemi qui ad ogni modo segnalare come la città
di Crotone, la formidabile rivale di Sibari, nel golfo
di Taranto, fosse celebrata fin dall’antico per l’eccellenza
de’ suoi medici e chirurghi.
La professione del medico era lucrosissima. Manlio
Cornuto prometteva duecentomila sesterzj a chi
l’avesse guarito dal lichene, malattia alla faccia; altrettanto
si fece pagare Carmide un viaggio in provincia,
egli che tuffava tutta Roma e fino i consoli
e i senatori decrepiti nell’acqua gelata; Alcmeone
raggranellò una fortuna di dieci milioni di sesterzj;
Quinto Stertinio riceveva cinquecentomila sesterzj
dagli imperatori, e dalla clientela in Roma seicentomila
all’anno, e congiuntamente a suo fratello, lasciò
un patrimonio di trenta milioni di sesterzj, oltre
[261]
all’aver dotata Napoli di opere superbe. Dieci milioni
ne lasciò Crinate, dopo di averne consacrati altri
dieci a rialzare le mura di Marsiglia sua patria: e
Valente ed Eudemo, medici e drudi di Messalina e
di Livia, disponevano a capriccio del talamo e del
tesoro imperiale.
Tranne questi medici principali e forastieri, per lo
più greci, vessati del resto anch’essi e costretti anzi
a partire da Roma, dove non ritornarono che più
tardi, gli altri medici erano per lo più schiavi o liberti,
e quindi i primi esposti in caso di mala riuscita,
alla battitura e alla catena, e i secondi alla
condanna da parte della giustizia ad ammende considerevoli.
Le cortigiane poi che non erano sotto la vigilanza
dell’edile, affidavansi a certe vecchie medichesse, medicæ
che non solo erano levatrici, ma addette eziandio
alla magia ed alla medicina empirica. Trovasi infatti in
Grutero, un’iscrizione che ricorda una Seconda medichessa:
Secunda L. Livinæ Medica.
Aniano, nelle sue annotazioni al codice teodosiano,
ricorda le medicæ juratæ, le medichesse giurate, che
non erano che levatrici autorizzate a studiare medicina.
A Pompei la medicina doveva trovarsi presumibilmente
non impari ne’ progressi a quella di Roma. Lo
si può dedurre almeno dalla moltiplicità ed esame
[262]
degli stromenti chirurgici ritrovati negli scavi, che
appunto per essi fu assegnata ad una casa, scoperta
nel 1771, la denominazione di Casa del Chirurgo
nella via Domiziana, a fianco della casa detta delle
Vestali.
Questa casa abbastanza grande ha tredici camere,
talune adorne di pitture e con pavimenti in mosaico.
Nel fondo, a destra dello xisto, vi è una camera sulle
cui pareti è dipinta la Toeletta di Venere, egual soggetto
trattato così stupendamente dal morbido e grazioso
pennello di Guido Reni. Pur dalle pareti di
queste sale furon tolti altri dipinti rappresentanti un
pittore che dipinge un busto, una testa, una Baccante
ed una quaglia, che si depositarono, come tutte le
altre cose pregevoli di Pompei e d’Ercolano, al Museo
Nazionale.
Ma all’argomento mio importa tener conto adesso
e parola dei suddetti arnesi chirurgici, che vi si ritrovarono.
Nella più vasta sala dell’abitazione, che verosimilmente
doveva essere la sala anatomica e la scuola di
medicina, ben quaranta stromenti di chirurgia si rinvennero,
e quantunque si riconoscano di piuttosto
grossolana fattura, se si paragonano agli odierni,
lavorati con tutta la finitezza e talvolta con eleganza,
riescono tuttavia assai interessanti, riscontrandosene
pure taluni che rassomigliano molto ai moderni, ed
altri di diverso disegno e per usi che non si sanno
forse indovinare.
[263]
Con siffatta scoperta si è conosciuto che cosa mai
fossero le cucurbitæ o cucurbitulæ, usate in medicina,
rammentate pur da Giovenale in questo verso:
Jam pridem caput hoc ventosa cucurbita quærat[245]
e si comprese che se dovevano essere coppette fatte
della scorza di questi frutti, o piccole zucche, potevano
essere anche di bronzo, siccome queste trovate in Pompei.
Fu inteso egualmente meglio, anche il passo di
Celso, che allude a ventose di bronzo e di corno[246]. — Queste
ventose pompejane sono a foggia di mezze
ampolle con quattro buchi, che solevansi otturare con
creta, che poi si levava onde distaccarla dalla pelle
che il vuoto aveva attratto. Si riconobbe eziandio
lo strumento per saldare le vene, gli scalpelli escissorii
a guisa di picciole punte di lancetta da una parte e
dall’altra aventi il malleo per la frattura delle ossa;
le spatule di diverse forme; gli specilli concavi da un
lato e dall’altro a forma d’oliva; un catetero bucato
colla sua guaina mobile; un unco per estrarre il feto
già morto; ami, aghi, forbici dentate a guisa di tenaglia,
circini escissorii, bolselle a denti, sonde urinarie,
lancette, bisturi, siringhe auricolari, seghe, coltelli ecc.
tutti del rame più puro, con manichi di bronzo e
riposti in astuccio pur di rame e di bosso. I soli
[264]
bottoni per l’applicazione de’ cauterj erano in ferro.
A chi ne voglia sapere di più consiglio ricorrere
alla dotta dissertazione di Louis Choulant: De locis
Pompejanis ad rem medicam facientibus, Leipzig 1823,
ed alla descrizione illustrata da disegni del cav. Leonardo
Santoro di Napoli, inserta nelle Memorie dell’Accademia
di Napoli: non che al trattato edito nel
1821 a Parigi dal dottor Savensko di Pietroburgo, e
da cui risulta che già si conoscessero a’ tempi di
Pompei strumenti chirurgici che si credono invenzione
de’ nostri giorni, e che pur allora si possedessero
mezzi dall’arte chirurgica che non son oggi neppur
sospettati.
Cesare Cantù poi ricorda[247] che all’accademia di Parigi
fossero dal signor Scouteten presentati i seguenti
strumenti, dissotterrati a Pompei ed Ercolano: una
sonda curva, una dritta, pei due sessi e per bambino;
la lima per togliere le asprezze ossee; lo specillo
dell’ano e dell’utero a tre branche; tre modelli di
aghi da passar corde o setoni; la lancetta ed il cucchiajo,
di cui i medici si servivano costantemente
per esaminare la natura del sangue dopo il salasso;
uncini ricurvi di varia lunghezza, destinati a sollevar
le vene nella recisione delle varici; una cucchiaja (curette)
terminata al lato opposto da un rigonfiamento
a oliva, all’uopo di cauterizzare; tre ventose di forma
[265]
e grandezza diversa; la sonda terminata da una lamina
metallica piatta e fessa, per sollevare la lingua nel
taglio del frenulo; molti modelli di spatule; scalpelli
a doccia piccolissimi per legare le ossa; coltelli dritti
e convessi; il cauterio nummolare; il trequarti; la fiamma
dei veterinarj per salassare i cavalli; l’elevatore
pel trapanamento; una scatola da chirurgo per contenere
trocisci e diversi medicamenti; pinzette depilatorie,
pinzette mordenti a denti di sorcio, una a
becco di grua, una che forma cucchiajo colla riunione
delle branche; molti modelli di martelli taglienti
da un lato; tubi conduttori per dirigere gli stromenti
cauterizzanti.
Se la medicina per sì lungo tempo rimase un vero
empirismo, nè si sollevò che più tardi colla coordinazione
dei fatti e risultamenti all’onore di scienza:
puossi argomentare facilmente come in ricambio si
dovesse ricorrere a prodotti chimici, ad empiastri,
ad erbe, a beveroni, a dettame di que’ cerretani nelle
cui mani trovavasi l’arte salutare. E v’erano donne
altresì che la pretendevano a sapienza nelle scelte e
distillamento delle erbe e componevano filtri, che la
superstizione e i pregiudizi d’ogni maniera facevano
credere atti a dare o togliere l’amore, a portare o
distruggere la fortuna e vie via a secondare ogni
sorta di passioni, ma principalmente quella degli
appetiti sfrenati e lussuriosi onde dicevansi afrodisiaci.
Ma essi, grida Ovidio, non recano vantaggio
[266]
alle fanciulle, ma nuocono alla ragione contenendo
i germi della pazzia furiosa.
Questi empirici, antidotari e farmacisti erano però
venuti nell’universale disprezzo, quantunque i più
vi ricorressero: a un dipresso come vediamo adesso
derisi magnetizzatori e sonnambule, tiratrici di carte
e indovini, ma, ciò malgrado, contar numerosa clientela
e raggrannellar ricchezza. Orazio li mise a fascio
colle sgualdrine ambubaje in quel verso che nel capitolo
dell’Anfiteatro ho già citato:
Ambubajarum collegia, farmacopolæ.
Fra questi empirici si distinsero nondimeno molti
dotti botanici e manipolatori ingegnosi. Sotto Tiberio,
Menecrate inventor del diachilo, componeva empiastri,
spesso efficaci contro le erpeti, i tumori e le
scrofole; Servilio Democrate fabbricava eccellenti
emollienti.
Pharmacopolæ appellavansi i venditori di farmachi,
ma non per questo si possono dire pari agli odierni
farmacisti, perocchè questi or vendano i semplici e
manipolino i medicamenti giusta le prescrizioni dei
medici; mentre quelli fabbricavan rimedj di proprio
capo e li spacciavano, come fanno gli odierni cerretani;
onde Catone, presso Gellio, fosse nella ragione
allorchè disse: Itaque auditis, non auscultatis,
tanquam pharmacopolam. Nam ejus verba audiuntur,
verum ei se nemo committit, si æger est[248].
[267]
Erano i Seplasarii che vendevano i semplici, e
spacciavano pure profumi, droghe, unguenti ed
aromi.
Sotto il nome di sagæ venivano le specie diverse
di venditrici d’unguenti e di filtri, che fabbricavano
spesso con magici riti inventati nella Tessaglia.
Ignoranti assai sovente della efficacia delle erbe che
trattavano, non è a dirsi se causassero anche di funeste
conseguenze. Così perirono anzi tempo Licinio
Lucullo amico di Cicerone, il poeta Lucrezio e tanti
altri.
Orazio, che era stato amante d’una Gratidia, ch’era
una tra le più celebri sagæ di Roma, stando a quanto
ne scrissero i suoi scoliasti, rimproverò a costei,
che raccomandò co’ suoi versi immortali alla esecrazione
dei posteri sotto il nome di Canidia, il funesto
potere delle sue pozioni amorose, che gli tolsero
gioventù, forza, illusioni e salute[249].
In Pompei, sull’angolo d’un viottolo, si credè ravvisare
una fabbrica di prodotti chimici. Sulla sua
facciata si lessero diverse iscrizioni, tra cui l’una che
accenna a Gneo Elvio Sabino; un’altra a Cajo Calvenzio
Sellio. La fabbrica consta di due botteghe:
[268]
a destra dell’atrio vi è un triplice fornello destinato
a tre grandi caldaje disposte a differenti altezze.
Nella casa si conteneva gran quantità di droghe
carbonizzate. Nel 1818, in faccia alla via Domiziana,
sull’angolo d’un’isola triangolare, si sterrò
una taberna di seplasarius o farmacista. Per mostra
aveva dipinto un grosso serpente che morde
un pomo di pino. Il serpe era l’attributo di Igea, la
dea della salute, e di Esculapio: esso è ancora
l’emblema delle odierne farmacie. In Pompei, come
abbiamo altrove notato, valeva ad altri scopi eziandio,
nè quindi avrebbe certo bastato a fissare la designazione
a questa taberna di officina farmaceutica,
dove non si fossero trovati nell’interno diversi altri
medicamenti, preparazioni chimiche, vasi con farmachi
disseccati e pillole, e spatole e una cassetta
in bronzo a comparti contenente droghe, e una lama
di porfido per distendere e stemprare gli empiastri.
Questa cassetta conservasi al Museo in un con un
bel candelabro di bronzo.
Dyer poi[250] scrive essersi colà trovato eziandio
un gran vaso di vetro capace di contenere due galloni
(9l, 086), nel quale vi era un gallone e mezzo
(6l, 814) d’un liquido rossastro che si pretende fosse
un balsamo. Essendo stato aperto il vaso, il liquido
[269]
cominciò a svaporare rapidissimamente, onde si affrettò
a chiuderlo di nuovo ermeticamente.
Questo è quanto pare a me compendj brevissimamente
la condizione dello scibile d’allora e il suo
insegnamento.
Finora non si raccolsero dati essere esistite altre
scuole in Pompei fuori di quelle che ricordai nel presente
capitolo, nè forse gli Scavi altre ne metteranno
alla luce. Si sa del resto, per gli usi generali in Roma,
e quindi anche nelle colonie, che vi fossero scuole
private, in ciò che per la puerizia delle classi agiate
ogni famiglia avesse il suo schiavo, destinato a dare
i primi rudimenti letterarj; poi erano i grammatici
che subentravano ad ammaestrare nello scrivere e
nello studio degli scrittori e nel greco, e dopo avea luogo
il perfezionamento in Grecia nelle discipline della filosofia.
Reduci in patria, o era nell’esercito che
eleggevano la carriera e traevano alle guerre, di cui
Roma non aveva penuria mai, o entravano nella magistratura,
o praticavano dagli oratori più rinomati
ad apprendere l’eloquenza del foro; assai sovente poi
tutte queste professioni volta a volta esercitando,
cioè passando dal foro alle cariche civili, e da queste
a’ gradi militari, ora magistrati e ora soldati.
Non vi volevano che i vizj e le scelleraggini dell’impero
per chiamare su Roma e l’Italia il torrente
barbarico e far iscomparire istituzioni e civiltà, e
quando questa potè far di nuovo capolino e ricomparire
[270]
sulle rovine indagate del passato, si è procacciato
di ricostruire, senza che finora si possa dire
che da noi siasi fatto meglio de’ nostri gloriosi maggiori.
Ad ogni modo, anche la sapienza odierna spesso
piacesi confortare sè stessa dell’autorità della sapienza
romana, che invoca come oracolo sacro e senza
appello.
[271]
CAPITOLO XVII.
Tabernæ.
Istinti dei Romani — Soldati per forza — Agricoltori — Poca
importanza del commercio coll’estero — Commercio marittimo
di Pompei — Commercio marittimo di Roma — Ignoranza
della nautica — Commercio d’Importazione — Modo di
bilancio — Ragioni di decadimento della grandezza romana — Industria — Da
chi esercitata — Mensarii ed Argentarii — Usura — Artigiani
distinti in categorie — Commercio al minuto — Commercio
delle botteghe — Commercio della strada — Fori
nundinari o venali — Il Portorium o tassa delle derrate
portate al mercato — Le tabernæ e loro costruzione — Institores — Mostre
o insegne — Popinæ, thermopolia, cauponæ,
œnopolia — Mercanti ambulanti — Cerretani — Grande e
piccolo Commercio in Pompei — Foro nundinario di Pompei — Tabernæ — Le
insegne delle botteghe — Alberghi di
Albino, di Giulio Polibio e Agato Vajo, dell’Elefante o di Sittio
e della Via delle Tombe — Thermopolia — Pistrini, Pistores,
Siliginari — Plauto, Terenzio, Cleante e Pittaco Re, mugnai — Le
mole di Pompei — Pistrini diversi — Paquio Proculo,
fornajo duumviro di giustizia — Ritratto di lui e di sua moglie — Venditorio
d’olio — Ganeum — Lattivendolo — Fruttajuolo — Macellai — Myropolium,
profumi e profumieri — Tonstrina,
o barbieria — Sarti — Magazzeno di tele e di stoffe — Lavanderie — La
Ninfa Eco — Il Conciapelli — Calzoleria
e Selleria — Tintori — Arte Fullonica — Fulloniche di Pompei — Fabbriche
di Sapone — Orefici — Fabbri e falegnami — Profectus
fabrorum — Vasaj e vetrai — Vasi vinarj — Salve
Lucru.
Sotto questo nome di tabernæ, chè così i latini chiamavano
le botteghe, il capitolo presente è chiamato a far
[272]
assistere il lettore al movimento dell’industria pompejana
e del suo commercio. La storia del commercio
romano non corre sempre parallela, come nelle altre
cose che abbiam osservato finora, colla storia del
commercio della piccola città di Pompei: tuttavia
essa si comprende nella storia generale di quello
della gran Roma, come la parte nel tutto, che però
dovrò riassumere brevemente, e di tal guisa saran
raggiunti i miei intenti, e il lettore si avrà così anche
questa parte importante della vita di quella repubblica
famosa, che compendia tutta l’Italia antica.
Quando si pensa che i Romani fondarono la più
vasta e formidabile monarchia del mondo, parrebbe
che si dovesse argomentare che essi avrebbero dovuto
avere una corrispondente ricchezza e floridezza
di commercio; ma non fu veramente così. Come
abbiam veduto delle scienze, che non presero a mostrarsi
in Roma che cinque secoli dopo la sua fondazione;
così fu anche del commercio e dell’industria.
Insino alla prima Guerra Punica, i Romani
non erano per anco usciti d’Italia, nè pur potevano
avere stabiliti commerci coll’estero. Poveri e soldati, non
ebbero tampoco nozione alcuna di commercio, e neppure
ne sentirono il bisogno. Erasi infatti ai primi giorni
dell’infanzia di un popolo, divenuto poi conquistatore,
che era ai prodromi di quelle convulsioni che l’avrebbero
di poi così violentemente agitato. Fin dalle origini,
più che impaziente di gittarsi alle conquiste, come da
[273]
non pochi scrittori si volle far credere, ciò desumendo
piuttosto dai moltissimi fatti onde si ordì la sua storia,
che dal più diligente studio del suo primitivo
costume e delle sue abitudini; forzato ad essere soldato
per difendersi dagli incessanti attacchi dei Sabini,
degli Etruschi e dei Sanniti; tanto il carattere
suo che le sue leggi naturalmente assumer dovevano
una tinta militare; e però l’educazione doveva
piegare alla più severa disciplina, alla più passiva
obbedienza. Sì certo; il popolo romano era per istinto
pastore e lo si può credere a Catone, che così ce lo
attesta nella prefazione all’opera sua, De Re Rustica:
Majores nostri virum bonum ita laudabant:
bonum agricolam, bonumque colonum. Amplissime
laudari existimabatur qui ita laudabatur[251]. Conquistando
adunque l’universo, non fece che difendere
o proteggere la propria indipendenza, nè combattè
che per assicurarsi le dolcezze della pace, alla quale
continuamente aspirava. Properzio mostra che pur
a’ suoi tempi la si pensava così della patria romana,
quantunque l’epoca sua ribollisse per la febbre delle
conquiste, in quel verso:
Armis apta magis tellus quam commoda noxæ[252];
[274]
ciò che del resto affermava pure Sallustio, quando,
narrando della Guerra Catilinaria, qualificava la romana
razza genus hominum agreste, sine legibus, sine
imperio, liberum atque solutum[253]; e più innanzi così
enunciava gli scopi de’ loro fatti militari: hostibus obviam
ire, libertatem, patriam, parentesque armis tegere[254].
Ciò non tolse che il dovere star sempre all’erta
e dover respingere tanti e innumerevoli nemici,
avesse a modificare le primitive inclinazioni.
Epperò l’occupazione generale doveva essere di
ginnastiche esercitazioni, di ludi bellici, di studio,
di violente imprese, e si hanno così le ragioni di
que’ fatti d’armi gloriosi che si succedevano senza
posa l’un l’altro e di quelle virtù eziandio primitive
che si videro scemare man mano che crebbe la potenza
romana e con essa le passioni individuali.
I Romani inoltre situati fra tanti popoli e nazioni prodi
e bellicosi, che dovevano diventare? Altrettanti soldati,
risponde il Mengotti nell’opera sua, Il Commercio
dei Romani[255]. Bisognava o distruggere o essere distrutti.
Stettero dunque coll’armi alla mano per quattro
secoli, rodendo pertinacemente i confini ora di
[275]
questo, ora di quello stato, finchè superati tutti gli
ostacoli, dominati i Sanniti e vinto Pirro, o piuttosto
non vinti da lui, si resero signori d’Italia. In appresso
l’orgoglio, che ispira la felicità delle prime
imprese e la smoderata cupidità di bottino, gli stimolarono
a divenir conquistatori della terra. Questo
fu il genio che si venne necessariamente formando
e il carattere de’ Romani. La guerra, dopo che divenne
indispensabile, fu la loro educazione, il loro
mestiere e la loro passion dominante. Essi furono
quindi soldati per massima di stato, per forza di istituzione,
per necessità di difesa, per influenza di religione,
per esempio de’ ricchi e dopo altresì che divennero
ricchi e potenti in Italia, conservarono la
stessa ferocia e la stessa tendenza a crescere di stato
per il lungo uso di vincere e per impulso delle prime
impressioni.
Un popolo poi fiero e conquistatore riguarda allora la
negoziazione come un mestiere ignobile, mercenario
ed indegno della propria grandezza. Le idee vaste, i
piani magnifici, i progetti brillanti, i pensieri ambiziosi
di gloria e di rinomanza, lo splendore e la celebrità
delle vittorie, la boria de’ titoli, la pompa ed
il fasto de’ trionfi non si confacevano con le piccole
idee e coi minuti particolari della mercatura. Lo stesso
Cicerone preponeva ad ogni altra virtù la virtù militare:
Rei militaris virtus præstat cæteris omnibus;
[276]
hæc populo romano, hæc huic urbi æternam gloriam
peperit[256].
All’agricoltura, la passione e virtù d’origine, si sarebbero
piuttosto nei giorni di calma e in ricambio
rivolti, tornando più confacente a que’ caratteri indomiti;
e così que’ grandi capitani che furono Camillo,
Cincinnato, Fabrizio e Curio alternavano le
cure della guerra con quelle del campo, infra i solchi
del quale era duopo che i militari tribuni andassero
a cercarli quando avveniva rottura di ostilità
coi popoli limitrofi.
Quindi nulle le arti, povere le manifatture, rustico
il costume. Grossolane le vesti, venivano confezionate
dalle spose pei mariti; onde si diceva della
donna a sommo di lode, domum mansit, lanam fecit[257],
e i capi stessi non permettevansi lusso maggiore;
sì che si legga nelle storie di Roma della toga di
Servio Tullio, lavoro di sua moglie Tanaquilla, che
stesse gran tempo, siccome sacra memoria, appesa
nel tempio della Fortuna.
Colle spoglie de’ vinti nemici si fabbricarono e ornarono
persino i templi: nulla insomma si faceva in
casa propria.
Quali arti dunque, chiede ancora il Mengotti,
[277]
seguite pur dal Boccardo, qual industria, quali manifatture,
qual commercio potevano avere i Romani
senza coltura, senza lettere, senza scienze?
Le arti tutte e le scienze si prestano un vicendevole
soccorso e riflettono, per dir così, la loro luce, le une
sulle altre. Tutte le cognizioni hanno un legame ed
un’affinità fra di loro. La poca scienza della navigazione
presso i Romani contribuì finalmente ad impedire
che il traffico progredisse.
Tuttavia noi abbiam veduto diggià, nel ritessere
la storia di Pompei, come questa città fosse emporio
di commercio marittimo e così erano pure città commercianti
tutte quelle littorane. Ma esse erano quasi
divise allora dalla vita e partecipazione romana. La
Sicilia contava floridi regni, che hanno una propria
ed onorifica istoria, e la Campania, ed altre terre
che costituiron di poi lo stato di Napoli, popolate da
gente di greca stirpe, giunse a tale di prosperità, da
essere appellata dai Greci stessi Magna Grecia. Navigarono
questi commercianti della Campania lungo le
coste d’Italia e delle isole vicine, visitarono la Sicilia,
la Sardegna, la Corsica, e fino in Africa pervennero
a vendervi e scambiarvi i ricchi prodotti
del suolo. Del commercio di Pompei con Alessandria
ho già trattato, allor che dissi dell’importazione fatta
dagli Alessandrini in Pompei; fra l’altre cose, pur
del culto dell’egizia Iside.
Istessamente abbiam qualche dato che attesta il
[278]
commercio marittimo di Roma con l’Africa. Nell’anno
che seguì l’espulsione dei re da Roma, venne, al dir
di Polibio[258], conchiuso fra questa repubblica e Cartagine
il primo trattato di commercio, che fu di poi
rinnovato due volte. Vuolsi dire per altro che nelle
loro relazioni con Cartagine i Romani comprassero
più che non vendessero, importando di là tessuti
rinomati per la loro leggerezza, oreficerie, avorio,
ambra, pietre preziose e stagno; e però può aver
ragione il succitato Mengotti nel credere che fossero
stati piuttosto i Cartaginesi, sovrani allora del mare,
i quali fossero andati ai Romani, anzi che questi a
quelli; giacchè dove avessero avuto vascelli o navi
proprie e conosciuta la nautica, se ne sarebbero valsi
a respingere Pirro dal lido italico, nè le tempeste
e gli scogli avrebbero distrutte sempre le loro flotte;
tal che la strage causata dai naufragi fosse sì
grande, che da un censo all’altro si avesse a trovare
una diminuzione in Roma di quasi novantamila cittadini[259].
Porran suggello a questo vero dell’imperizia de’
Romani nella nautica, le frequenti disfatte toccate da
essi nei mari, la guerra de’ Pirati, che li andavano
ad insultare sugli occhi proprj, e le parole di Cicerone
che l’abbandono vergognoso della loro marina
[279]
chiama labem et ignominiam reipublicæ[260], macchia
e ignominia della Repubblica.
Ma le cose migliorarono, convien dirlo, dopo Augusto,
se Plinio ci fa sapere che i Romani portassero
ad Alessandria ogni anno per cinque milioni di mercanzie,
e vi guadagnassero il centuplo, e se tanto
interesse vi avessero a trovare, da spingere la gelosia
loro a vietare ad ogni straniero l’entrata nel mar
Rosso.
Roma per cinquanta miglia di circonferenza, con
quattro milioni di abitanti[261], con ricchezze innumerevoli
versate in essa da conquiste e depredamenti
di tante nazioni, con infinite esigenze di lusso e di
mollezza da parte de’ suoi facoltosi, opulenti come i
re, doveva avere indubbiamente attirato un vasto
commercio, certo per altro più di importazione che di
esportazione. Il succitato Plinio ci informa come si
profondessero interi patrimonii nelle gemme che si
derivavan dall’Oriente, negli aromi dell’Arabia e della
Persia; che dall’Egitto poi si cavasse il papiro, il
grano ed il vetro, che si cambiavan con olio, vino,
e Marziale ci avverte anche con rose in quel verso:
[280]
Mitte tuas messes; accipe, Nile, rosas[262]
e dell’Etiopia, profumi, avorio, fiere e cotone, che Virgilio
chiama col nome di molle lana:
Nemora Æthiopum molli canentia lana[263].
La Spagna forniva argento, miele, allume, cera,
zafferano, pece, biade, vini e lino; le Gallie rame, cavalli,
e lana, oro de’ Pirenei, vini, liquori, panni, tele
e prosciutti di Bajona; la Britannia stagno e piombo;
la Grecia il miele d’Imetto, il bronzo di Corinto assai
pregiato, vino, zolfo e trementina, le lane d’Attica,
la porpora di Laconia, l’elleboro di Anticira, l’olio
di Sicione, il grano di Beozia, nardo, stoffe, pietre preziose
e schiavi. L’Asia Minore mandava ferro dell’Eusino,
legno della Frigia, gomma del monte Idea,
lana di Mileto, zafferani e vini del monte Tmolo,
stoviglie di Lidia, profumi e cedri e schiavi della
Siria, porpora di Tiro e formaggi.
Ma tutto questo commercio colle nazioni straniere,
osserva il Mengotti, come fosse sempre passivo per
i Romani; ma se ne ricattavano, osservo io, e colmavano
il disavanzo del bilancio colle conquiste, riprendendosi
ben presto con la forza ciò che le nazioni
commercianti avevano loro spremuto con l’industria,
[281]
così che non potessero mai esaurire la loro
ricchezza per quanto si studiassero di abusarne, siccome
è detto in Sallustio: Omnibus modis pecuniam
trahunt, vexant; tamen summa libidine divitias suas
vincere nequeunt[264]. Il quale Sallustio che così scriveva,
attingeva pure a questa limacciosa fonte per
abbellire i suoi famosi orti, e l’infame sistema veniva
sanzionato dalla religione, essendosi giunto perfino
ad erigere un tempio a Giove Predatore.
Non sono quindi d’accordo coll’illustre scrittore
del Commercio de’ Romani, che fosse per questo traffico
passivo e rovinoso ch’essi cadessero nella povertà
e nella barbarie. Le cagioni della decadenza e
della barbarie voglion essere attribuite prima alla
decrescente prosperità agricola che degenerò presto
in rovina e ne fu causa principale la concentrazione
dei piccoli poderi in vaste possessioni; quindi la sostituzione
del lavoro degli schiavi a quello degli uomini
liberi, del quale Plinio espresse gli effetti perniciosi
in memorande parole: Coli rura ergastulis pessimum
est ut quidquid agitur a desperantibus[265]. Altre
[282]
e più efficaci cause di desolazioni dell’Italia furono
le incessanti guerre. I generali vittoriosi solevano ripartire
ai loro soldati le terre conquistate. Codesti
barbari d’ogni nazione, dice lo stesso Mengotti, Galli,
Germani, Illirii e Numidi, senza affetto per l’Italia,
che riguardavano non come patria, ma come una
preda e un guiderdone dovuto ai loro servigi, cercavano
di emungerla, non di coltivarla; sicchè lo sconvolgimento
e la forza, le emigrazioni erano continue
e cresceva ogni giorno l’abbandono e lo squallore
delle campagne.
Nè fu estranea alla decadenza la diminuzione
della popolazione, effetto delle proscrizioni e delle
guerre; onde fin sotto di Cesare si pensasse a far
provvide leggi, ut exhaustæ urbis frequentia suppeteret,
onde sopperire, cioè, alla deficienza di popolazione
della esausta città.
La corruzion del costume diede il colpo di grazia.
Ingolfandosi i Romani nella mollezza e nel vizio e
venendosi essi così eliminando dal servizio attivo dell’armi,
presero il loro posto soldati e capi stranieri
e così si scalzarono ben presto da quella antica grandezza,
per sostituire altri i loro propri interessi. Divenuto
l’impero oggetto di disputa e cupidigia, messo
all’incanto perfino dalla prepotenza e rapacità de’ pretoriani,
gli stranieri impararono la via di casa nostra,
vi si stabilirono da padroni e tiranni, e ci fecero a
misura di carbone pagare le passate colpe.
[283]
In quanto all’industria, nei primi tempi, pochi uomini
liberi cercavano ne’ lavori manuali una professione
lucrativa: l’agricoltura era la naturale e, se
non l’unica, almeno la più onorevole occupazione dei
cittadini romani. Ma quando la popolazione di Roma
crebbe e la piccola proprietà di una famiglia povera
non bastò a nutrir tutti i suoi membri, molti dovettero
cercare la loro sussistenza nel lavoro manuale.
Questi operai liberi uscivano quasi sempre dalla classe
degli schiavi che esercitavano specialmente siffatti lavori
e continuavano ad occuparsene, quand’essi avessero
ricuperata la loro libertà. Di tal guisa l’industria
migliore era esercitata a Roma massimamente dai
liberti, che rimanevano clienti dei loro antichi padroni.
Si comprende così perchè l’industria, esercitata
da cittadini d’ultima classe, da liberti e da
schiavi, dovesse essere negletta e disprezzata. I mestieri
manuali e il commercio di dettaglio erano considerati
come professioni basse, sordida negotia. Cicerone,
che per l’altezza dell’ingegno avrebbe dovuto
essere superiore ai pregiudizii volgari, pur nondimeno
divideva questo contro gli industriali. Noi, scrive
egli, dobbiam disprezzare i commercianti che ci provocan
l’odio contro di essi. È basso e non è istimabile
il mestiere di questi mercenari che locano le
loro braccia e non il loro ingegno. Per essi il guadagno
non è che il salario della loro schiavitù: mettiamo
al medesimo livello l’industria di quelli che
[284]
comprano per rivendere, perchè per guadagnare, è
bisogno che mentiscano. Che mai v’ha di nobile in
una bottega? Quale stima accorderemo noi a questa
gente, il commercio della quale non ha per oggetto
che il piacere, come i pescivendoli, i beccaj, i pizzicagnoli,
i cuochi e i profumieri? Concediamo la nostra
stima alla medicina, all’architettura, se si voglia;
ma in quanto al piccolo commercio, esso è sempre
basso: il solo grande non è spregevole tanto.
E così la pensava tutta Roma.
Infatti nel grande commercio non esitavano ad entrare
persone dell’ordine equestre, in vista dei forti
lucri, grazie ai quali, sotto il nome dei loro liberti,
esercitavano spesso la banca, chiamati que’ liberti,
mensarii de argentarii, equivalenti ai moderni banchieri.
Così ne originava quella schifosissima e fatal
piaga che fu l’usura, che divenne anzi prontamente
più forte e deplorevole che non la sia de’ nostri giorni.
A conoscerne la misura, citerò quella che si faceva
da’ più virtuosi, senza pur credere di mancare alle
leggi dell’onesto. Pompeo Magno prestava 600 talenti
ad Ariobarzane al 70 per cento, e il severo Bruto,
l’ultimo e virtuoso republicano alla esausta città di
Salamina mutuava pur forte somma al 48 per cento.
Vuolsi attribuire a Numa Pompilio la distribuzione
degli Artigiani in differenti categorie. Le corporazioni
dei mestieri erano in numero di otto: i suonatori
di tibia, gli orefici, i falegnami, i trattori, i vasai, i
[285]
fabbricatori di cinture, quelli di corregge, i calderaj e
fabbri ferraj, e tutti gli altri artigiani non compresi
fra costoro formavano una nona corporazione. Ciascuna
corporazione poi aveva i suoi capi, magistri: i
fabbri, falegnami o ferraj, che servivano nell’esercito
erano sotto gli ordini di un prefetto, præfectus fabrorum,
e quelli che si occupavano di costruzioni
formavano una categoria particolare, spesso impegnati
da un intraprenditore, chiamato ædificator, o
magister structor.
In quanto al commercio minuto, vi aveva a
Roma, come da noi, quello delle botteghe, tabernæ,
e della strada.
Il commercio di strada si faceva principalmente
nei fori, detti nundinari, o venali. La ragion del nome
ho già dato, intrattenendo il lettore nel capitolo I Fori.
Era stato Servio Tullio che, a regolare il commercio
fra Roma e la sua campagna e sottometterlo a sorveglianza,
aveva stabilito che la popolazion campagnuola
venisse tutti i nove giorni alla città a comperarvi ciò
che le fosse di bisogno, ed a vendere le sue derrate.
Ho già ricordato in quell’occasione e il forum boarium
o mercato de’ buoi; il suarium o quello dei
porci; il piscarium, o de’ pesci; il pistorium, o del
pane; cupedinis, o de’ frutti e delle confetture. V’era
anche il forum macellum destinato alle carni non
solo, ma a designare l’insiem de’ mercati, che tutti
erano vicini, lungo il Tevere, facili così a essere vigilati
[286]
dagli Edili, che spezzavano i falsi pesi e le
false misure, e gettavano alle onde di quel fiume i
generi di cattiva qualità. Era sulla piazza stessa del
mercato che gli Agenti del tesoro venivano ad esigere
dai venditori il portorium, o tassa su tutte le
merci che vi apportavano.
Oltre i mercati, vi erano anche botteghe. Erano
queste il più spesso semplici baracche in legno, coperte
di tavole ed adossate alle case. Dovevano essere
per conseguenza anguste, male arieggiate e
peggio illuminate, ma di tal prezzo di locazione che
Cicerone ci apprende che molti ricchi proprietarj ne
facessero costruire tutt’all’intorno delle loro magnifiche
dimore, ricavandone enormi somme. Non mancavano
del resto di coloro, che allettati dalla cupidigia
del denaro, facessero tenere per loro conto da
schiavi, liberti, o mercenari, che si dicevano institores,
quelle botteghe, massime a vendita di pane e
di carni.
Presso a tutti i luoghi publici, come bagni, teatri,
circhi, trovavansi mercanti di vino, di bevande calde
e cibi cotti. Al disopra delle botteghe mettevansi insegne
a pittura. Ho già in altro capitolo recato all’uopo
un passo d’Orazio che attesta questo costume;
nè ciò bastando, si esponevano fuor della porta in bella
mostra le mercanzie. Le più ricche erano quelle dei
Septa Julia e attiravano il più gran numero di avventori.
[287]
Era certo che tutte queste baracche che costeggiavano
le case dovessero essere di grande ingombro
alle vie, che non erano sempre così larghe, come si
potrebbe credere. L’inconveniente — a togliere in
qualche parte il quale, aveva contribuito l’incendio di
Nerone, — durò fin sotto Domiziano, che finalmente
vietò che si costruissero presso le case, appunto perchè
restringessero esse di molto la via publica, e
Marziale, sempre pronto ad incensare quel Cesare,
che dopo morte vituperò, così ne lo loda del savio
provvedimento:
Abstulerat totam temerarius institor urbem,
Inque suo nullum limine limen erat.
Iussisti tenues, Germanice, crescere vicos;
Et, modo quæ fuerat semita, facta via est.
Nulla catenatis pila est præcincta lagonis:
Nec prætor medio cogitur ire luto.
Stringitur in densa nec cæca novacula turba:
Occupat aut totas nigra popina vias.
Tonsor, caupo, coquus, lanius sua limina servant.
Nunc Roma est; nuper magna taberna fuit[266].
[288]
Le botteghe avevano differenti nomi, secondo la
natura delle merci che vi si vendevano. Così le taverne
in cui si vendevano i cibi cotti si chiamavano
popina, ed erano per lo più frequentate da’ ghiottoni
che vi trovavano eziandio delicati manicaretti e gustose
bevande, come si raccoglie da quel verso di
Plauto:
Bibitur, estur, quasi in popina haud secus[267],
Thermopolia erano le taverne dove si vendevano
bevande calde; caupona dicevasi l’albergo, o piuttosto
la bottega dove si vendeva a bere ed a mangiare,
l’odierno trattore, e caupo denominavasi il conduttore.
La Caupona serviva anche di alloggio e tavola
a’ forestieri: nelle grandi città equivaleva solo alle
odierne taverne od osterie, canove, mescite e birrerie ed
œnopolia chiamavansi. Lo stesso poeta che già citai,
Plauto, ne trasmise la notizia che agli œnopolia traesse
il vicinato a provvedere il vino necessario all’uso
giornaliero, in quel passo dell’Asinaria:
[289]
Quom a pistore panem petimus, vinum ex œnopolio,
Si œs habent dant mercem[268].
Œnophores quindi appellavansi gli schiavi destinati
a portare l’œnophorum o cesta a mano per mettervi
gli urcei, ampolle o fiaschi di vino che s’andava
a comprare ai venditori summentovati.
Venendo fra poco a dire delle Tabernæ, o botteghe
scoperte in Pompei, vi troveremo altre denominazioni
ed altre industrie.
Nè mancavano a Roma antica i mercanti ambulanti,
come li abbiamo oggidì, che gridavano e vendevano
le loro derrate per via; e Marziale pur ricorda venditori
di zolfanelli, che scambiano la loro merce contro
frammenti di vetro rotto; mercanti di minuti cibi,
che spacciano alla folla; cerretani che mostrano vipere
e serpenti, vantandone i pregi e le abilità, nè più
nè meno insomma di quel che veggiamo e udiamo
far oggidì per le nostre piazze.
Venendo ora a ricercare se le medesime condizioni
commerciali fossero in Pompei e se l’industria e i mercanti
al minuto vi esistessero eguali, poco mi resta a
dire, per provare come pur eguale vi fosse la baraonda,
perocchè già sappia il lettore, per quel che se ne è
[290]
detto, che in quanto al grande commercio e al marittimo,
vi si notasse una tale attività, da indurre
perfino i molti a ritenere fra le etimologie del suo
nome quella di emporio, quasi appunto fosse Pompei
un ridotto di merci e di commercianti. L’essere in
riva al mare e in quella costa meridionale che è più
aperta alle negoziazioni degli stranieri, le relazioni
create dalla omogeneità delle razze fra la sua popolazione
e le popolazioni greche, da cui forse derivava,
dovevano mantenervi animato il commercio marittimo.
La speciale condizione sua d’avere inoltre il Sarno,
siccome già sappiamo, di non dubbia importanza, che
comunicava col mare, e che allora era così grosso
da permettere la navigazione, se ben dissero gli scrittori,
vi creavano eziandio un forte movimento commerciale
interno, comunicando così con città vicine da
cui ricevevano e cui trasmettevano mercanzie. L’importanza
delle cose rinvenute negli scavi, la ricchezza
e valore delle pitture, delle statue, de’ musaici,
della quantità degli ori e delle gemme provano
che molto si faceva arrivare dall’estero; come del
resto si argomenta dai canti de’ poeti e dalle pagine
degli storici, che da queste sponde partissero i vini,
le granaglie, le frutta, gli olj, di cui è fornitore larghissimo
il territorio.
I suoi abitatori poi, che sappiamo in buona parte
agiati e ricchi, come rilevasi e dalla entità de’ monumenti
e da quanto si è trovato nelle loro case, oltre i
[291]
tanti facoltosi che da Roma traevano a villeggiarvi,
dovevano necessariamente richiedere assai animato
anche il piccolo commercio, e se già si è in grado
di parlare di parecchie tabernæ, perchè si scavarono
e se ne riconobbe l’uso, queste essendo nella parte
più distinta della città, perchè verso la marina; è
dato argomentare che nella parte superiore e non
ancora esumata ve ne fossero assai di più, in numero,
cioè, da soddisfare ai bisogni tutti della sua
popolazione.
Anche Pompei aveva il suo Foro nundinario o venale,
e il lettore se ne rammenta, chè di esso ho parlato
nel Capitolo intorno ai Fori. Colà, come a Roma,
sarà stato il mercato ove recavansi dagli abitanti
delle campagne circostanti le derrate; colà saran venuti
a scambiare le loro derrate colle merci cittadine.
Ivi pure avranno i contadini pagato il portorium
e ivi gli edili pompejani avranno esercitata la loro
vigilanza sui pesi e sulle misure, non che sulla bontà
delle derrate e, se cattive, gittate al mare non di molto
discosto.
Se non che le botteghe o tabernæ, come si dicevano
allora, non saranno state a Pompei, come a
Roma, nè povere baracche di sconnesse tavole, nè indecentemente
adossate alle muraglie delle case. L’angustia,
che abbiam già veduto delle vie pompejane, vietava che
tale costumanza si introducesse nella città: perocchè
dove ciò fosse avvenuto, sarebbesi resa assolutamente
[292]
impossibile la circolazione. D’altronde i rialzi che costeggiavano
le vie si opponevano a ciò. Le tabernæ
adunque erano in Pompei come le botteghe delle moderne
città, facenti parte delle case ai piani terreni,
che si aprivano sull’esterno delle case. Avevano esse
pure le loro indicazioni di vendita, e le loro insegne
esteriori, e suppergiù vi si spacciavano quelle merci
che già conosciamo vi si vendessero nelle botteghe
di Roma.
Venga ora meco il lettore a visitarle.
Percorrendo le vie lungo le quali erano aperte, e
che or si veggono vuote, conservando appena da un
lato dell’ingresso que’ banchi di pietra o di materia
laterizia, che servivano o per esporvi la merce, o per
contarvi i denari che vi si esigevano, veggonsi in più
d’una ai lati le scanalature per entro alle quali scorrevano
le porte che chiudevano le botteghe, e pure
a’ fianchi di codeste o superiormente alle medesime,
ravvisasi qualche scultura o pittura, che serviva d’insegna
spesso allusiva alla qualità di merce che nella
bottega si spacciava. Così su di una vedesi una capra
in terra cotta, che vi dice che là vi si vendesse il
latte; su di un’altra una pittura rappresenta due uomini,
l’un de’ quali cammina davanti l’altro sorreggendo
ciascuno l’estremità di un bastone nel mezzo del
quale pende sospesa un’anfora, a significare ch’ivi
era un œnopolium o vendita di vino; altrove era dipinto
un mulino girato da un asino, che annuncia il
[293]
magazzeno del mugnajo; e su d’altre botteghe scorgesi
ancora l’avanzo di qualche emblema, come uno
scacchiere, un’àncora, un naviglio. Già ho ricordato
altrove il dipinto, onde era ornata la bottega presso
alle Terme, rappresentante un combattimento di gladiatori,
ed ho riferita l’iscrizione che a tutela della
medesima vi si era graffita sotto: Abiat Venerem
Pompejanam iradam qui hoc læserit; e così presso la
bottega di panattiere, o pistrinum, leggesi quest’altra
iscrizione: Hic habitat felicitas[269], la quale, se non
accenna alla natura del commercio che vi si esercitava,
vi attesta almeno che la famiglia che la conduceva,
paga di sè stessa, potevasi proclamare felice.
Tre pitture, ora affatto scomparse, in tre distinte botteghe,
raffiguravano un sagrificatore conducente un
toro all’altare su d’una; su di un’altra una gran
cassa da cui pendevano diversi vasi, e sulla terza
un corpo lavato, unto e imbalsamato, che indicava
forse un unguentario, al quale pure incumbeva la
preparazione de’ cadaveri, giusta l’uso che vedremo
nell’ultimo capitolo di quest’opera.
Altre insegne vedremo al loro posto toccando delle
varie botteghe, che più specialmente chiameranno la
nostra attenzione, e delle quali anzi il Beulé si
valse per uno studio complementario, che intitolò
appunto Le commerce d’après les peintures nella sua
[294]
opera uscita in questi giorni in Francia, dal titolo
Le Drame du Vésuve[270].
Ma prima di tutto, nel trattar del commercio bottegajo,
intrattener debbo il lettore degli alberghi e
popinæ. Hospitia dicevansi con vocabolo generale
quando fornivano al viaggiatore o forastiero comodità
di cibo o d’alloggio, e con esso li troviamo designati
in Cicerone e in Tito Livio[271] e da un esempio in Pompei
stessa, che riferirò più sotto. Popina chiamavasi
la taverna, rosticceria od osteria, in cui erano venduti
cibi cucinati: lo stesso Cicerone e Plauto vi
fanno cenno[272]. Il più spesso l’hospitium era simultaneamente
una popina: questa invece non implicava
l’idea di albergo.
Ho, nel Capitolo quarto di quest’opera, favellato già
alcun poco dei due publici alberghi, l’uno detto di
Albino e l’altro di Giulio Polibio e Agato Vajo di
Pompei. Ho creduto argomentare come il primo dovesse
aver servito a stazione di posta, e che il secondo
non avesse dovuto servire che all’uso de’ mulattieri
e carrettieri, ciò desumendo dalla natura de’ locali e
degli attrezzi e altri oggetti rinvenuti. Diciamone
ora, poichè meglio ne cada in taglio il discorso,
qualche cosa di più.
[295]
L’albergo e popina di Albino è la prima casa che
si presenti a destra entrando nel Corso principale dal
sobborgo o Via delle Tombe. La porta è larga undici
piedi e mezzo, è atta al passaggio de’ carri, essendone
piana la soglia d’ingresso ed a livello della
strada publica. Da essa si passa in alcune vaste camere,
ove per avventura collocavansi le merci. Sonvi
de’ focolari con sottoposti ripostigli per le legna; dei
banchi laterizi per la distribuzion delle vivande: due
botteghe per vendita d’acque calde e liquori, comunicanti
fra loro, con fornelli ed altri accessori per
la cucinatura delle vivande e per il riscaldamento
delle pozioni, non che alcune camere per ricettar avventori.
In un secondo cortile si scende in un sotterraneo,
il più spazioso e meglio conservato in tutta
Pompei, di centocinque piedi di lunghezza, di dieci e
mezzo di larghezza e di tredici di altezza[273]. Corre
parallelo alla strada e viene illuminato da tre finestre:
vi si ritrovarono molte ossa di diversi animali:
forse vi si gettava l’immondezza e forse poteva essere
anche ad uso di stalla. Il nome del proprietario
era dipinto in nero davanti alla porta, e nella sommità
del limitare stava scolpito in un mattone un
gran segno itifallico, che ho già altrove spiegato essersi
usato collocare dagli antichi, non a indizio di
[296]
luogo di prostituzione, come taluno può correre facilmente
a pensare, ma per cacciar la jettatura, come
direbbesi ora a Napoli, o contro il fascino o malocchio,
come dicevasi allora. Ne’ marciapiedi, che circondavano
le botteghe laterali dell’albergo, vi sono
de’ buchi obliqui, che avran servito, come è generale
opinione degli scrittori, per attaccar le bestie da
soma. Due scheletri di cavallo colle loro testiere e
briglie furono ritrovati negli scavi di questo albergo.
Quantunque l’altro albergo di Giulio Polibio e Agato
Vajo fosse frequentato da’ mulattieri, come lo fa presumere
l’iscrizione che ho già riferita nel summentovato
Capitolo Quarto; tuttavia gli scavi offersero alcun
che di interessante in esso. Avanzi d’iscrizioni
sopra l’intonaco de’ muri esterni vi apparivano già
cancellate. Annunziavano esse combattimenti gladiatorj
e cacce nell’Anfiteatro ed indicavano più nomi proprj.
I poggi delle botteghe annesse a quest’albergo erano
assai eleganti, rivestiti al di fuori di marmi: avevano
più fornelli, in uno de’ quali si trovò un cácabo, o
stoviglia di bronzo col suo coperchio. Nel davanti
erano ornati di due medaglioni con cornici di legno
che rappresentavano due teste di donne in rilievo.
Nell’angolo del poggio o banco era attaccata al muro
una piccola statua di terra cotta coperta di una vernice
verde, del genere degli amuleti, la quale ora si
conserva nel Museo di Napoli. Ivi si trovò pure altro
amuleto di bronzo, che sosteneva dei campanelli sospesi
a catenelle di bronzo.
[297]
Un terzo albergo era quello di Sittio, detto anche
dell’Elefante, dall’iscrizione che vi si leggeva così
espressa:
SITTIVS RESTITVIT ELEPHANTVM[274]
e dall’insegna rappresentante un elefante con enorme
serpente all’intorno ed un nano. Che dovesse essere
un albergo, lo dice quest’altra iscrizione più grande
che vi fu letta:
HOSPITIVM HIC LOCATVR
TRICLINIVM CVM TRIBVS LECTIS
ET COMM.[275]
L’interno è assai piccolo, povere le decorazioni:
meschinissimo ritrovo a gente di nessuna fama, come
non poteva essere altrimenti, avendo di fronte il lupanare.
Vi si rinvennero una testa di Giove in pietra di
Nocera grossolana, tre stili per iscrivere, utensili di
cucina, un sarracum o carro agricolo sia per veicolo
di persone, che per trasporto di derrate al mercato,
bottiglie di vetro, una asta di ferro, un peso di piombo
e monete di bronzo.
[298]
Un albergo e scuderia era pure nella via delle Tombe,
quasi rimpetto alla casa che si presume di Cicerone.
Consta d’un portico con botteghe, e nel mezzo v’era una
fontana con abbeveratojo. Gli scavi offrirono qui dei
vasi, de’ secchi di bronzo, un mortajo di marmo, delle
bottiglie di vetro, dei vasi in terra cotta, dadi, un
candelabro e avanzi di bilancia. Nella scuderia che
vi è attigua, si trovò la carcassa di un cavallo col
morso in bronzo, se pure era un morso l’ordigno che
aveva la figura di un D, e dei pezzi di un carro. A
fianco dell’ingresso v’erano due fornelli con pentole,
in cui dovevano esservi i commestibili che vi si esponevano
e vendevano. Al di sopra di queste botteghe
eravi pure un piano superiore, a cui si saliva per
iscale di legno. In una di queste botteghe si ravvisarono
scritti sullo stucco diversi nomi in caratteri
rossi, ma di essi non si potè leggere che appena
quello di STAIVS PROCVLVS.
Nella via di Mercurio vedesi pure una popina. Su
di un panco di fabbrica rivestito di marmo sono incassati
tre vasi: v’è uno scalino pur di marmo, per
collocarvi le coppe e i bicchieri ed un fornello per
cuocervi le vivande, sotto il quale è dipinto un angue
in atto di divorar le offerte disposte su di un’ara.
In un salotto vicino vi stavano dipinti degli amori;
Polifemo e Galatea, e Venere che pesca coll’amo. Sotto
vi è rappresentata una caccia; a qualche distanza un
cane ed un orso accomandati ad un palo che ardono
[299]
assalire un cervo. A sinistra della popina evvi una
altra sala con una porta segreta nel viottolo di Mercurio.
Gli scrittori ricordano come qui vi si trovassero
tre pitture oscene ora distrutte. Un’altra pittura
rappresenta un soldato vestito d’una singolar tonaca,
somigliante ad una pianeta, o dalmatica de’ nostri
preti, il qual soldato porge da bere ad un popolano.
Sopra vi è graffita questa iscrizione:
MARCVS FVRIVS PILA MARCVM TVLLIVM[276].
Anche un’altra popina era sull’angolo della Via
delle Terme, e si denomina di Fortunata, perchè
viveva un’iscrizione nella parte esterna che recava
un tal nome, ma che ora è affatto scomparsa. Vi si
vendevano commestibili.
Due osterie erano dirimpetto alle Terme: ivi stavano
molti vasi di vino o dolia, come appellavansi allora,
e focolari per ammanire vivande. Vi si scoprì uno
scheletro d’uomo, che al momento della catastrofe
s’era per avventura rifugiato sotto di una scala e
stringeva ancora il suo piccolo tesoro, consistente
in un braccialetto in cui erano infilati tre anelli, uno
de’ quali con vaga incisione d’una baccante, due orecchini,
il tutto d’oro; settantacinque monete d’argento
e sessantacinque di bronzo, con cui voleva sottrarsi
a sì generale rovina.
[300]
A queste cauponæ e popinæ ed œnopolia e tabernæ
vinariæ erano quasi sempre congiunti, come abbiamo
veduto, i thermopolia, ossia botteghe per vendita di
bevande calde e liquori, come sarebbero a un dipresso
i moderni caffè; poichè si tenesse allora comunemente
più delizioso il bever caldo. Fin il vino si usava
imbandir caldo: lo si cuoceva e lo si dolcificava e
medicava con mirra, come pur di presente usasi in
certe circostanze unirvi droghe, e si dava sopratutto
idromele, giusta quanto si apprende in Plauto:
Quid, si opus sit, ut dulce promat indidem ecquid habet?
Rogas?
Murrhinam, passum, defrutum mellinam, mel cujusmodi.
Quin in corde instruere quondam cœpit thermopolium[277].
Pur tuttavia v’erano molti e speciali termopoli.
Sul corso principale evvi quello di Perennio, o Perennino,
Ninferoide, così interpretandosi la cancellata
epigrafe PERENIN NIMPHEROIS. Vi si osserva ancora il
[301]
fornello, il davanzale di marmo bianco, in cui riscontransi
le impronte lasciate dalle tazze colme di liquori,
e una nicchia, contenente una testa di fanciullo in
marmo, e alcuni gradini su cui disponevansi le tazze.
Quivi pur si trovò un phallus di bronzo con campanelle,
vasi di terra d’ogni forma e una lampa e varj
oggetti di vetro colorato.
Vicino al Ponderarium, che già conosciamo, per
averne trattato nel Capitolo Quarto, sonvi due altre
tabernæ, ch’erano egualmente termopolii, o mescite
di bevande calde, e vogliono essere ricordati per esservisi
trovati una cassa col coperchio di rame, uno
scheletro umano e due d’animali.
E così da codesti venditorj di vino e di bevande
calde, di liquori e di commestibili, da quelli soltanto,
cioè, che già si sono scoperti, vuolsi a ragione
inferire che ne dovessero in Pompei sussistere in
quantità; perocchè nel restante della città ancor sepolta
abitasse, come sappiamo, la parte più povera della
popolazione, e la quale più di tali vendite e mescite
dovesse necessariamente abbisognare, da che la classe
meglio provveduta avesse modo di prepararsi nella
propria casa di cosiffatte bevande.
E poichè sono a dire delle taberne e commestibili,
parmi vi possa star presso il discorso de’ pistrini o
delle taberne da panattiere, o pistores od anche siliginari,
come venivano chiamati, esprimendo il primo
nome piuttosto l’operazione del macinare, il secondo
[302]
invece quella dell’impasto, da seligo, latinamente
detta farina di frumento.
Pistrinum era dunque dapprima presso i Romani il
luogo in cui veniva il frumento ridotto in farina. Usavasi
a ciò un profondo mortajo detto pila, e d’un grande
e forte stromento che ve lo pestava e stritolava dentro
chiamato pilum, che per la sua grandezza adoperavasi
a due mani, a differenza dei pistillum, il nostro
pestello, a testa grossa, con cui si polverizzavano
o impastavano nel mortarium altre sostanze, come
droghe e pasticci. Più tardi, quando si pensò a sostituire
altro stromento che stritolasse maggior quantità
di grano e si inventò la macina, mola manuaria
o trusatilis, o mulino a mano, pistrinum valse ancora
a designare il mulino, che veniva messo in movimento
continuo, di giorno e di notte, o da schiavi o da bestie
da soma, cui si bendavan gli occhi, o da acqua[278]:
nec die tantum, verum perpeti etiam nocte
prorsus instabili machinarum vertigine membrabant pervigilem
farinam[279], come disse Apulejo.
Ne venne così che il pistrinum si usasse comunemente
per luogo di punizione degli schiavi rei d’alcuna
colpa, che vi venivano condannati a subire un
periodo di prigionia con lavoro forzato, lo che era
[303]
una ben miserevole pena per quegli sventurati pareggiati
alle bestie.
Di questi pistrini se ne trovarono parecchi in Pompei,
onde è dato fornirne ora la più esatta descrizione.
Tutti appajono costruiti d’un solo sistema, consistente,
cioè, in due grosse pietre tagliate ora in forma
di due vasi o campane, l’una arrovesciata sull’altra,
che posa su d’una base, che è l’altra pietra, ed ora
in forma di colonna che vien mano mano incavandosi
o riducendosi a’ fianchi, pur posata sulla egual base
cilindrica di un metro e mezzo di diametro ed uno in altezza.
Da essa sorge uno sporto conico alto circa sessanta
centimetri, che forma la macina inferiore, meta, ed
ha un pernio di ferro infisso nel vertice. La pietra
esterna, catillus, è fatta in forma di due vasi, come dissi,
ed anche di oriuolo a polvere, clessydra, siffattamente,
che una metà di esso si adatti come un berretto sopra
la superficie conica della pietra inferiore, ricevendo
il pernio summenzionato in un buco, forato a posta
nel centro della sua parte più stretta tra i due coni
vuoti, che serviva al doppio fine di tenerla fissa al
suo posto e di scemare od eguagliare l’attrito. Il grano
era quindi versato nella coppa vuota in cima, che
così serviva di tramoggia e scendeva a mano a mano
per quattro buchi forati nel suo fondo, sul solido
cono di sotto; dov’era macinato in farina tra la superficie
interna ed esterna del cono e del suo berretto,
vie via che questo era fatto girare attorno dagli
[304]
schiavi che lo movevano coll’ajuto d’una stanga di
legno infissa in ciascuno de’ suoi fianchi. La farina
cadeva dall’estremo orlo in un canale tagliato tutto
intorno alla base per riceverla.
È a questo sistema ed alla miseria che vi pativano
gli schiavi, che si condannavano a metterlo in movimento
marcati in fronte d’una lettera infame, rasati
da una parte i capelli e con un anello al piede[280],
che Plauto allude in questi versi:
Num me illuc ducis ubi lapis lapidem terit?
Quid istuc est? aut ubi est istuc terrarum loci?
Ubi fient homines, qui polentam pransitant[281].
E il povero Plauto se l’intendeva, o piuttosto la
fortuna doveva farlo passare per queste dolorosissime
prove, poichè guadagnato colle sue produzioni al
[305]
teatro un bel gruzzolo di denaro, avventuratolo poscia
in ispeculazioni, da cui poeti e letterati debbono
sempre star lontani, e quelle fallite, fu ridotto per
campare la vita a girar macine da mugnajo. Plautus
fuit pistor, scrisse lo Scaligero, cum trusatiles molas
versando operam locasset. Quia vero pistura illa et
labor grana conterendi omnium gravissimus erat, factum
ut Pistrinum locus plenus fatigationis et negotii operosi
viresque conficientis diceretur[282]. Terenzio e Cleanto
vuolsi abbiano fatto altrettanto, quantunque fossero
costoro lontani dai tempi e dai costumi, nei quali,
sulla fede di Plutarco, Talete, essendo nell’isola di
Lesbo, avesse udito una schiava straniera, girando
una mola cantare: «Macina, o mulino, macina, poichè
Pittaco, Re della gran Mitilene, si reca pur a piacere
di volgere la mola[283].»
Apprendiamo poi, a questo proposito, da Catone
come Pompei fosse rinomata per le sue mole, per
[306]
le quali usufruttava del tufo vulcanico di che abbonda
tutto il suo suolo così vicino al Vesuvio, e costituiva
la fabbricazione e vendita di esse un ramo non indifferente
del suo commercio.
Veniamo ora a parlare delle particolarità dei singoli
pistrini che si scopersero.
Nella casa detta di Sallustio in Pompei si scoprì
un Pistrino, che si locava dal proprietario a tale publico
uso, e dove la costruzione del forno per la cottura
del pane parve de’ nostri tempi, tanto si accosta
alla odierna maniera. Il lavoro della volta è in guisa
che con poco combustibile si dovesse riscaldare. Aveva
nella bocca un coperchio di ferro, e presso stavano
vasi per contener acqua. Vi si trovarono tre macine,
come quelle testè descritte. Annessa era la camera
per impastare il pane, col focolare per l’acqua calda,
ed ivi si trovarono altresì l’anfora colla farina e
parecchi acervi di grano.
Nel forno publico della Casa di Modesto, così designata
dal nome MODESTUM, dipinto in rosso sul muro
e dove si rinvenne una quantità di pani della più perfetta
conservazione, deposti parte nel Museo di Napoli
e parte in quel di Pompei, il forno si presentò
più solido e più ingegnoso ancora. Vi si vede la camera
o stufa in cui manipolavasi il pane; un’altra
ove ponevasi a fermentare su tavole disposte l’una
sull’altra lungo il muro, e quindi una terza ove riponevasi
già cotto. Presso era la stalla degli asini
[307]
che giravano le mole, secondo il metodo più usitato.
In questo pistrino si trovarono quattro macine un
po’ più basse delle consuete d’altrove, formate da un
cono concavo che si volge su di un altro convesso,
anfore di grano e farina, e sul muro del Pistrino,
vedesi un dipinto che esprimeva un sagrificio alla
Dea Fornace e diversi uccelli. È forse la panatteria
migliore che si scoperse finora.
Un altro forno publico è nel lato sinistro della casa
di Fortunata presso quella di Pansa, con tre mulini,
sull’un dei quali leggesi Sex. Sulla bocca del forno
vi era un phallus colorito in rosso ed al di sopra
scritta la leggenda HIC HABITAT FELICITAS, novella
prova che l’emblema non fosse unicamente a segno
di mal costume, ma piuttosto a felice augurio ed a
scongiuro di disgrazia, come già ebbi il destro di
sostenere. Nella bottega attigua di panatteria esisteva
una pittura rappresentante un serpente, simbolo di
una divinità custode, e rimpetto una croce latina in
basso rilievo. Sarebbe questo segno un indizio del
sospetto da me già espresso che la religione di Cristo
fosse già penetrata in Pompei? Faccio voti che i futuri
scavi abbiano ad offerire maggiori dati, che il
sospetto e l’induzione abbiano a mutare in certezza
assoluta.
Sull’angolo della via del Panatico, un’altra panatteria
ha un gran forno con quattro mulini. Su due
d’essi leggonsi le parole SEX e SOHAL in caratteri
[308]
rossi e sopra il forno vedevasi una figura rappresentante
evidentemente un magistrato che distribuiva
pane al popolo.
Nella viottola della Fontana del Bue, si è pure trovato
un pistrino con tre macine, un gran forno a corrente
d’aria e delle madie foderate di piombo.
D’un’ultima panatteria terrò conto, scoperta nel 1868
ed appartenente a Paquio Proculo, al quale apparteneva
pure la casa. Essa è nella Via Stabiana (Regione
VII, Isola II). Il chiarissimo Minervini lesse dipinta
sulla parete sinistra della casa la seguente
epigrafe, che oggi è frammentata per la caduta dell’intonaco:
PROCVLE . FRONTONI
TVO . OFFICIVM . COMMODA
Questa raccomandazione, scrive il dotto signor G.
De Petra, illustrando nel Giornale degli Scavi la casa
e il pistrino di P. Paquio Proculo[284], così per la
sua forma, come pel luogo dov’è scritta, mi pare indubitato
che Frontone la rivolgesse al padrone della
casa, il quale perciò doveva chiamarsi Proculo. Con
tal cognome occorrono più di frequente nei programmi
pompejani due persone, P. Paquio Proculo e Q. Postumio
Proculo; ma considerando che in una colonna
dell’atrio è graffito il nome di Pacuia, la figlia
[309]
di Paquio, rimane provato che col nome di questo
debba intitolarsi la casa. Donde si fa ancora probabile
che l’altra raccomandazione elettorale publicata
dal ch. Fiorelli (Giornale degli Scavi, 1862, p. 47, n. 4):
Sabinum aed (ilem) Procule fac, et ille te facient, fosse
indirizzata allo stesso P. Paquio, che pare sia stato
un uomo assai influente e popolare. Diffatti il ch. Garrucci
(Bull. arch. Nap., n. 5, tom. II, p. 52) fece nota
questa epigrafe che sinora non trova riscontro di
sorta fra le reminiscenze elettorali: P. Paquium Proculum
ii. Vir. i. d. d. r. p. universi Pompejani fecerunt;
nondimeno chi era questo Proculo, che i Pompeiani
unanimi sollevarono alla somma dignità di
duumviro giusdicente? Niente altro, come si vedrà,
che un panattiere! Il qual fatto ci autorizza a conchiudere,
che in Pompei le magistrature municipali
non eran monopolio dei soli ricchi, e che questi conoscevano
di buona voglia (universi fecerunt) la convenienza
di farvi partecipare anche i più autorevoli
e migliori cittadini di condizione plebea. — Lezione
buona pei nostri tempi, in cui le elezioni amministrative
e politiche sembrano infeudate all’aristocrazia
del sangue e del denaro: colpa precipua del popolo
stesso che si ostina, a parole, a gridar contro i ricchi
e gli uomini di grande autorità, ma in fatto è poi
sempre lo stesso peccatore, che religiosamente serba
il suo stolido feticismo per chi tiene di classe a sè
superiore; salvo a ricominciare di poi le sue maledizioni
[310]
contro gli eletti proprj, che ignari de’
suoi bisogni, fanno leggi a sproposito e a detrimento.
Anche all’ingresso della viottola della Fontana del
Bue, sulla muraglia a sinistra, una bella e ben conservata
pittura di simboliche serpi è sormontata, oltre
che da un piccolo larario, anche da varie iscrizioni,
parte in oggi cancellate dalla rovina, fra le quali leggesi
la seguente, che ognor più avvalora e l’influenza
e la ricchezza di questo importantissimo panattiere
in Pompei:
P. PAQVIVM PROCVLVM
II VIR . I . D . THALAMVS CLIENS[285].
Io non mi divagherò a descrivere la casa di questo
P. Paquio Proculo, che qui l’argomento ne sarebbe
spostato: verrò invece difilato al pistrino che vi è in
essa, e che è nel lato destro. Vi si riconosce la camera
del panificium, e ciò si argomenta, scrive il De Petra,
dai cinque podii di fabbrica per sostegno di tre tavoloni
di legno su cui rimaneggiavasi la pasta, da varii
recipienti per conservar l’acqua, quali sono una vaschetta
quadra fabbricata, un gran dolio sepolto a
metà nel suolo e un’anfora murata in uno de’ poggiuoli,
infine dalle traccie degli assi di legno che sostenevano
le tavole su cui disponevansi i pani. Una
porta priva di soglia dava il passaggio da questo luogo
[311]
a quello dov’è il forno; ma tra l’una e l’altra stanza,
per uno scopo limitato, cioè per la sola cottura del
pane, v’era una comunicazione anche più diretta e
sollecita. Si notarono tre molæ per isfarinare il grano,
avendo una di esse la base ricoperta da una lamina
di piombo, la meta di una quarta mola senza il catillus
e la base circolare per una quinta; due serbatoj
d’acqua fabbricati, un pozzo con coperchio, un piccolo
dolio contenente calce e tre poggiuoli.
Il dipinto larario solito a incontrarsi nei pistrini,
non è mancato in questo, ma sventuratamente tornò
a luce poco conservato. Sotto un verdeggiante festone
è la Dea Vesta ammantata con lo scettro nella sinistra
e il dritto braccio proteso sopra un focus. Dietro
a Vesta è l’asino, l’animale, come dissi, usato più
spesso a girar le macine; rimpetto alla Dea v’è un
giovane in piedi che nella sinistra ha la cornucopia,
e stende la diritta sull’ara.
A sinistra del forno v’è un ampio locale in cui
probabilmente si conservavano saccula di grano o di
farina.
Di questo P. Paquio Proculo e di sua moglie, nel
tablinum della loro casa, si rinvenne il ritratto dipinto
sulle pareti gialle. Cedo la penna all’egregio De
Petra. «Questo dipinto, offre la volgare fisonomia di
Paquio, che ammantato dalla bianca toga magistrale,
stringe nella destra un volume col rispettivo titolo di colore
rosso. Gli è a fianco la sua donna, cui pendono sulla
[312]
fronte i ricciolini sfuggiti alla fascetta che le stringe
i capelli; ha pendenti di perle alle orecchie, e rossa
la veste; avvicina alle labbre la punta dello stilo che
tiene nella dritta ed ha i pugillari aperti nella sinistra[286].
Donde si può inferire, che l’anzidetta positura
sia stata convenzionale nei ritratti, poichè l’atteggiarsi
dell’uomo e della donna trovasi ripetuto esattamente
in due scudetti publicati nelle Pitture d’Ercolano
(tom. III, tav. 45) e in quegli altri due che ornano
il tablino d’una casa nella Regione Settima,
isola 10, propriamente quella che vien dopo la casa
del Balcone Pensile. Oltrecchè l’atteggiamento della
donna si confronta con la scrittrice dipinta nell’atrio
della casa di Popidio Prisco (Reg. VII, Is. 11, n. 20)
e con un’altra delle Pitture d’Erc. (t. III, tav. 46)[287].
Quale simbolo dell’amor conjugale di P. Paquio e sua
moglie, vedevasi al di sopra dei loro ritratti un grazioso
ed importante quadretto, ora nel Museo, rappresentante
Amore e Psiche teneramente abbracciati.
Il bacio e l’amplesso di essi, ovvio in tanti altri monumenti,
è ritratto in questa pittura pompejana in
una movenza nuova, sebbene non molto diversa
delle altre conosciute.»
[313]
Nella Via degli Augustali, come dipendenza della
Casa detta dei Capitelli figurati, aprivasi poi una taberna
da pasticciere, pistor dulciarius, il quale, come
ne fa sapere Apulejo, panes et mellita concinnabat
eduleia. Vi si videro parecchi mulinetti, pistrillæ, che
un sol uomo bastava a girare; ma destò la speciale
attenzione il forno, dalla forma del quale direbbesi
a riverbero, costituendosi di due cavità sovrapposte,
accendendosi il fuoco nella cavità inferiore da cui il calore
ascendeva per un’apertura, nella cavità superiore,
ove si deponevano a cuocer le pasticcerie. Due
pasticcetti si trovarono negli scavi e si conservano
nel Museo di Napoli.
Toccato de’ pistrini, vediamo ora le altre botteghe
e spacci pompejani di merci attinenti i cibi e gli
alimenti.
Una taberna o venditorio d’olio si scoprì nel 1852
nella via di Stabia, quasi all’angolo della viottola
della Fontana del Bue. Il podio o banco della bottega
era di marmo cipollino e grigio antico, con in
mezzo dello specchio davanti un medaglione di porfido
verde e due bei rosoni. Su di esso vi erano incastrate
otto belle ed ampie scodelle in terra cotta.
Nell’interno si ritrovò un pozzo, un fornello e l’ingresso
del ripostiglio dell’olio. La quantità degli ulivi
che si coltivavano nell’agro campano doveva necessariamente
far luogo ad una produzione assai abbondante
di olio. Anche gli scavi hanno offerte conserve nell’olio
[314]
di grosse ulive, che dovevano probabilmente
aversi dalle famiglie pompejane fra le consuete ghiottornie.
Presso la casa di Cornelio Rufo e quella di Messinio
nella Via di Stabia evvi una casetta, che l’illustre
Fioretti, seguendo le indicazioni di Pompeo
Festo e di Varrone, qualifica per un Ganeum, o Ganea,
specialmente per avervi vedute pitture ed iscrizioni
licenziose[288]. Era la Ganea o il Ganeum, come meglio
piaccia al lettore di appellarlo, secondo essi, un ritrovo
nascosto di meretrici, le camere da letto delle
quali erano a pian terreno, come i cenacoli nella
parte superiore delle case, ed io ne toccherò poi
nel capitolo del Lupanare; ma Bréton, nella sua Pompeja,
avendo constatato nell’area del peristilio sette
grandi coppe, o giare, misure di capacità pei liquidi,
e sette dolii coi loro coperchi, senza manichi, fu indotto
a credere che questa casa potesse essere al contrario un
magazzeno d’olio. Si sono poi trovati negli scavi dei
particolari mulini che si sono creduti atti alla macinazione
dei grani oleosi: l’uno fu rinvenuto nelle vicinanze
del Foro Triangolare o Nundinario.
Prima di entrare nel Foro Civile, sulla diritta, stava
la taberna di un venditore di latte. L’insegna di essa
è in terra cotta e rappresenta una capra. Sotto di
essa vi si lesse questa iscrizione in caratteri rossi, all’epoca
[315]
del suo sterramento, ma che ora non si distinguono
più.
M. CASELLIVM AED. DIF. FAC.
FIDELIS...
Nel podio di materia di fabbrica, come d’uso nelle
taberne di liquidi, v’erano incassati dei vasi.
Nell’isola intorno al Tempio d’Augusto si constatarono
diverse botteghe di commestibili. Una di venditori
di pesci salati, forse ciò argomentandosi dai
pesci che si videro dipinti sulle pareti, della natura
di quelli che si vendono nella salamoja, e già sappiamo
che Pompei era nota e famosa pel suo garo
che sapeva preparare e del quale ho già intrattenuto
il lettore sulla fine del Capitolo Quinto. Un’altra di
fruttivendolo, nè in questa si errò di certo, poichè vi
si accogliessero fichi secchi in abbondanza, uva
passa, susine, frutta in vasi di vetro, lenti, semi di
canape; oltre una ciambella, vari frammenti di pasta
e di pane, molto denaro, una staderina e varie bilancie.
I fruttivendoli in Pompei dovevano essere di
molti, così essendo lecito di pensare dalla iscrizione
che fu letta sul pilastro che separa la Fullonica, di
cui dirò qui appresso, dalla Casa della gran Fontana,
scritta, come il più spesso, in caratteri rossi e che
sembra riferirsi al magistrato, del quale abbiam veduto
come la statua decorasse il teatro:
[316]
M. HOLCONIVM PRISCVM II VIR. I. D.
POMARI VNIVERSI CVM HELVIO
VESTALE ROGANT[289]
I fruttivendoli pompejani si raccomandano ancora
in altre due iscrizioni, che si lessero nella strada ove
è l’arco di trionfo. L’una è così concepita:
IVLIVM SABINVM AEDILEM
POMARII ROGANT
e l’altra così:
MARCVM CERRINIVM AEDILEM
POMARII ROGANT
Ciò che vuol essere osservato si è che in queste
botteghe, che sono circostanti al Tempio di Augusto,
si sono rinvenuti molti oggetti preziosi e d’arte, fra
quali una statuetta di bronzo rappresentante una Vittoria
con armille d’oro alle braccia; un’altra in marmo;
Venere che si asciuga i capelli, come sorgesse allora
dalle spume dell’Ionio mare, colla parte inferiore velata
da un drappo dipinto in rosso; una bella tazza
d’alabastro, anelli d’oro, gemme, sistri isiaci, un vaso
di vaghissimo lavoro, amuleti, strigili e diverse monete.
Sarà negli ulteriori scavi che verrà dato indubbiamente
di scoprire taberne d’altre cose mangerecce,
e soprattutto lanienae, o botteghe da beccai e macelli,
la principale opera e materia prima dei quali veniva
somministrata dai templi, per le continue vittime che
[317]
vi si immolavano, per lo più in buoi, giovenche e
pecore; e se agli Dei si bruciavano ciocche di lana
e qualche inutile interiora, tutt’al più spruzzate da
vino e mescolate di fiori, il meglio veniva accortamente
goduto dai sacerdoti pel loro uso, e venduto
nuovamente ai gonzi, di cui si costituisce la maggior
parte del pubblico, che a ragion di divozione avevano
fatto prima l’offerta. I macellai dell’antichità erano
adunque principalmente i sacerdoti.
Della bottega del Chirurgo e del Seplasarius o farmacista
e di quella di prodotti chimici, ho già detto
nel Capitolo delle Scuole; di quella dello scultore mi
occuperò nel venturo delle Belle Arti, come anche
del mercante de’ colori; perocchè meglio vi si trovino
in essi collocati, come materia che a que’ capitoli
ha tutto il suo riferimento.
Nella stradicciuola di Mercurio, gli scavi trovarono
nel 1853 un Myropolium, o bottega da profumiere,
detta anche, come la vediam nominata in Varrone e
Svetonio, unguentaria taberna[290]. Già superiormente ho
toccato dello spreco di profumi, aromi ed unguenti
che si faceva a quei tempi di grande effeminatezza
in Roma e in tutto l’orbe a lei soggetto. Non era
soltanto, cioè, del mondo muliebre; ma pur degli uomini.
All’uscire del letto, prima d’entrare nel bagno,
nel bagno e dopo, era costume di ugnersi e di profumarsi;
[318]
altrettanto facevasi nelle case prima del pasto
e avanti comparire in pubblico e prima di coricarsi;
ogni occasione era buona per ispargersi il corpo e
le vestimenta di odorose essenze, per ungere i capelli
e perfino per profumare camere ed appartamenti.
Già abbiam veduto nel capitolo dell’Anfiteatro come
si facesse eziandio all’aperto assai gitto di croco: si
può pertanto argomentare cosa dovesse essere negli
appartamenti chiusi: a suo luogo vedremo, specialmente
nel triclinio e ne’ funerali.
Ma più che tutto, era nell’amore che di profumi
si abusava, come eccitanti e preparatori allo stesso.
È noto, scrive Dufour[291], che il muschio, il zibetto,
l’ambra grigia e gli altri odori animali portati nelle
vesti, nei capelli, in tutte le parti del corpo esercitano
un’azione attivissima sul sistema nervoso e sugli
organi della generazione. Nè solo adoperavano esternamente
detti profumi, ma non temevano di far entrare
aromi e spezie in quantità nel giornaliero loro
alimento; onde a ciò si voglia ascrivere quell’appetito
e prurito continuo che tormentava la romana
società e che la spingeva in tutti gli eccessi dell’amor
fisico.
La lussuria asiatica portò seco tali profumi e d’allora
in poi, così prodigioso fu il consumo delle sostanze
aromatiche, che parve non bastare quanto inviava
[319]
la Persia, l’Arabia e tutto l’Oriente insieme.
S’era insomma venuto a tal punto, da aver ragione
Plauto, quando nella Mostellaria usciva in questi accenti:
Quia ecastor mulier recte olet, ubi nihil olet.
Nam istæc veteres, quæ se unguentis unctitant, inter poles,
Vetulæ, edentulæ, quæ vilia corporis fuco occulunt,
Ubi sese sudor cum unguentis consociavit, illico
Itidem olent, quasi cum una multa jura confudit cocus.
Quid oleant nescias, nisi id unum, ut male olere intelligas[292].
Profumi e cosmetici assumevano il nome dal paese
onde venivano: così furono celebrati l’unguento di
Cipri, il balsamo di Mende, il nardo d’Achemenis, il
malobutrum di Sidone, distillato in olio pei capelli,
l’olio d’Arabia, quello della Siria, il mirobolano di
Arabia; l’opobalsamum della Giudea, il cinnamomo dell’India,
la maggiorana di Cipri, la mirra dell’Oronte
e l’iride di Illiria, che Ovidio raccomanda nel suo
[320]
Poemetto De Faciei medicamine, e del quale facciamo
uso noi pure rinchiudendolo in seriche borse o sacchetti,
che poniamo, per profumarla, per mezzo la
biancheria.
Altri profumi e unguenti pigliavano il nome dal
loro inventore; come la Niceroziana ricordata da Marziale,
odore inventato da Nicerote, e il Foliatum, manipolato
da Folia, amica di Gratidia, che Orazio stigmatizzò
nelle sue Odi, coprendola delle più infami
accuse e vituperi, col nome di Canidia.
V’era poi l’unguento dipelatorio, detto dropax unguentum,
l’odontatrimna per i denti, le pastiglie dette
diapasmata contro l’alito cattivo, e vie via molti altri
unguenti che sarebbe troppo lungo l’enumerare.
Malgrado questo bisogno che si provava dell’arte
e dei prodotti del profumiere e del cosmeta, questi
bottegai erano nel comune disprezzo, forse perchè a
questo piccolo commercio s’applicassero cortigiane e
cinedi, lenoni e mezzane, quando l’età toglieva loro
ogni attrattiva e possibilità di continuare nel loro infame
mestiere, o mancava la clientela, e così a donna
ingenua ossia nata libera, il nome solo di profumatrice
e cosmeta sarebbe giustamente suonato come la più
fiera ingiuria.
Nelle case de’ ricchi eravi sovente il laboratorio
dell’unguentarius, a cui s’applicavano schiavi o liberti,
e le cosmete e gli unguentarii valevano eziandio
per le molteplici operazioni, che già conosciamo, de’
privati balinei.
[321]
La gente onesta e della buona società teneva a disonore
il mostrarsi publicamente nei myropolii o taberne
unguentarie, e però quando vi accedevano o
sceglievano le ore prime del mattino o quelle della
sera, e tiravano il lembo della toga sul volto: non
così gli sfaccendati che traevano a questi luoghi,
non che alle tonstrinæ o botteghe da barbiere, od a
quelle de’ medici e de’ banchieri, per raccogliervi novelle
e chiacchierare, come Plauto ne fa sapere quando
nell’Epidico fa che Apecide dica aver cercato ovunque
di Perifane:
Dii immortales, utinam conveniam domi
Periphanem! per omnem urbem quem sum defessus quærere:
Per medicinas, per tonstrinas, in gymnasia atque in foro,
Per myropolia, et lanienas, circumque argentarias
Rogitando sum raucus factus[293].
Spettava a’ profumieri l’imbalsamazion de’ cadaveri
e la vendita degli aromi pei sagrifici, e nel myropolium
di Pompei diffatti le insegne o pitture che vi
stavano nell’ingresso ed ora scomparse, e le quali
condussero a constatare od almeno a far credere essere
[322]
quella una taberna unguentaria, rappresentavano
l’una un sagrificatore che conduceva all’altare un
toro; l’altra quattro uomini che portavano una enorme
cassa, intorno alla quale stavano sospesi alcuni vasi.
Superiormente poi vedevansi dipinte alcune persone
intente a profumare un cadavere, prima d’essere portato
al rogo.
Dal profumiere, passiamo a vedere la taberna del
barbiere nella Via di Mercurio. È picciolissima: a
destra vi è un podio, sopra di esso due nicchie simili
a quelle che altrove servirono a larario, ma che
qui più probabilmente avranno giovato per collocarvi
cosmetici, vasi di profumi, pettini e novaculæ o lame
di metallo molto affilate colle quali radevano i capelli
della testa o i peli della barba, come i nostri rasoi. In
mezzo alla bottega v’è un sedile in materia da fabbrica,
dove l’avventore si sarà seduto, e in un dietro
bottega sta il fornello, che avrà servito per riscaldare
l’acqua. Non saprei spiegare come e perchè si trovassero
in questa seconda camera gli avanzi di un
mulino.
Circa questo mestiere del barbiere, tonsor, poco è
a dirsi. Lo si faceva consistere nel tagliare i capelli,
nel radere la barba, nel pareggiare le ugne e nello
svellere i peli parassiti colle pinzette, volsellæ. I ricchi
usavano a tutto ciò nella propria casa di uno schiavo
o di liberto; il popolo veniva alla bottega. A radersi
frequentemente la barba, si cominciò tardi in Roma,
[323]
nell’anno cioè 454, della sua fondazione, alla venuta
dalla Sicilia del primo barbiere: avanti di costui la
si lasciava crescere generalmente. Nelle tonstrinæ, — così
chiamate le botteghe di barbieri, e noi diremmo
barbierie, — era assai frequente che vi esercitassero
tal mestiere le donne, dette però Tonstrices; e Plauto,
fedel pittore di que’ vecchi costumi, nel Truculentus,
accenna appunto alla Sura barbiera:
. . . tonstricem Suram
Novisti nostram, quæ modo erga ædes habet[294].
e Marziale acerbamente morde la moglie d’un barbiere
che stava presso alla Suburra, e la quale co’
suoi artificii carpiva denaro alla gente:
Sed ista tonstrix, Ammiane, non tondet;
Non tondet, inquis? ergo quid facit? radit[295].
Non di meglio del resto aveva trattato lo stesso
poeta, Marziale, il barbiere Eutrapelo nel seguente
epigramma:
Eutrapelus tonsor dum circuit ora Luperci
Expungitque genas; altera barba subit[296].
[324]
Lo che dimostra che di buoni e grami barbieri ve
ne erano allora come ve ne hanno di presente. L’epigramma
adunque avrà sempre la propria attualità.
Di sarti finora gli scavi non rivelarono botteghe;
di calzolajo se ne sospettò alcuna giusta quel che
ne dirò tra breve, e così di tal’altre industrie e mestieri
attinenti il vestire, e quel che si sterrerà per
lo avanti, riguardando la parte più abitata dalla gente
operaja, verrà forse facendo al proposito interessanti
rivelazioni. Certo che nè le vestimenta, nè i calceamenti
erano a que’ dì complicati come di presente, da richiedere
specialità di artieri. L’importante quanto ai
primi era la finezza della stofa onde si facevano tonache
e mantelli, pepli e toghe e studio nel portarle
onde si acquistasse grazia ed eleganza. Gli schiavi,
le donne bastavano all’uopo e forse ognuno, anche
del popolo, in sua casa poteva dalle proprie donne
farsi preparare tutto quello che appunto riguardasse
il vestimento. Circa alle vestimenta poi della gente
rustica, ne abbiamo in Marco Porcio Catone, De Re
Rustica, ricordati i nomi: Tunicæ, saga, centones, centiculi,
manicæ de pellibus; e cuculli o cuculliones, pilei
e galeri a berrette o cappelli che si portavano
in testa, ed erano in tutti di pelli lanute. In quanto
ai secondi, cioè a’ calzolai, si può dirne qualche parola,
perchè in taluna pittura pompejana si vide riprodotta
la forma di qualche calzare, ma sarà tra
breve, come dissi, quando visiteremo la bottega del
cuojajo o conciatore di pelli.
[325]
Presso le Prigioni, che abbiamo nell’undecimo Capitolo
di quest’opera trovate nel Foro Civile Pompejano,
vedesi un locale che fu designato siccome un
ampio magazzeno in cui si vendevano tele e stofe ad
uso proprio del vestire. Così fu interpretato l’uso di
questo locale, fidandosi alla quantità dei buchi che
vi si videro, che dovevano aver servito a sostenere
gli armadj che contenevano quelle merci. Una pittura
scoperta in Pompei, scrive Bonucci, fa per avventura
allusione a questo Foro ed a questo magazzeno. Rappresenta
un uomo in piedi, che tiene nelle mani un
pezzo di stofa ch’egli offre ad una donna seduta.
Questa mostra il desiderio di comperarla, ma fa osservare
al mercante un difetto che si trova nel mezzo
della merce, e il mercante cerca dissuaderla con ragioni
che accompagna con gesti. Le due giovanette
sedute, la servente che è dietro di esse, il gruppo di
due altre donne che parlano con un uomo, e da ultimo
i panneggiamenti che si scoprono nel fondo del
quadro, possono indicare il luogo di che facciamo
parola.
Tele e lane servivano alla confezione degli abiti:
solo negli ultimi tempi, cioè a quelli dell’Impero, le
matrone, comperandola a carissimo prezzo, usavano
della seta che derivavano dall’Asia; ma questa consideravasi
come merce di smoderatissimo lusso, perocchè
costasse come l’oro. Ho già notato le maraviglie
che si fecero quando nel circo vennero distesi
[326]
velarii di seta: erano esse in ragione della preziosità
e rarità della stofa.
Nel Vicolo del Panatico, al lato destro, vi è un piccolo
stabilimento di lavanderia: per tale venne riconosciuto,
abbenchè tutto vi fosse rovinato e nulla di
particolare offra ad essere riferito. Due altre lavanderie
pure non di grande importanza, stanno nel Vicolo
della Maschera: più vasta è quella in Via del Lupanare
e detta di Narciso, scoperta nel 1862 e così
denominata da una superba statuetta di bronzo che
si conserva al Museo, rappresentante infatti questo
personaggio mitologico nell’atto che ascolta la voce
lontana della Ninfa Eco, che vien considerata come
una delle migliori rarità trovate negli scavi, sì che
Dognée giungesse a dire: Les fouilles n’eussent-elles
déterré que ce seul bronze, l’importation des principes
immortelles de l’art grec dans le vieux monde romain
eût été démontrée par une trace glorieuse dont la splendeur
indique incontestablement l’illustre origine[297]. È
una bottega, in cui si veggono vasche diverse di pietra,
in due delle quali era l’acqua condotta da un tubo di
piombo con un robinetto. Sotto di queste due vasche
è un fornello; ma giustamente osserva Bréton, siccome
il piombo non può sopportare un fuoco di
troppo ardente, si deve supporre, che in questi due
fornelli non si ponesse che della brace destinata solo
[327]
a tener caldo il liquido, nel quale si lavavano le stofe
di lana o di lino. Al disopra del lavatojo, nella muraglia,
vi sono dei buchi, ne’ quali erano infissi dei
chiodi per la biancheria. Il suolo della bottega ha un
certo pendìo verso un lato, per ivi condurre le acque
che vi scorrevano per uscire sulla via. A destra della
bottega, è una cameretta, in mezzo alla quale è una
tavola di marmo rettangolare d’un solo piede ornato
d’un corno d’abbondanza e d’una pàtera con tracce
di pitture. In fondo della stessa, scendendo quattro
gradini, si entra in una vasta corte in cui si vedono
le traccie dei chiodi cui si saran dovute accomandare
le corde onde distendervi le biancherie ad
asciugare.
Nella bottega sull’angolo della Via degli Augustali
e del Lupanare, designata per quella del Conciapelli,
coriarius o, come potrebbe essere, d’un calzolajo,
giusta l’opinione di Fiorelli e di Overbeck, appartenente
a Nonio Campano soldato della IX Coorte pretoriana,
come era scritto in grandi caratteri rossi sulla
bianca parete di essa, se non abbiamo speciali oggetti
a rimarcare, tranne alcuni utensili propri a questo mestiere,
l’argomento però ci obbliga a ricordare l’uso precipuo
de’ suoi prodotti, cioè quello de’ calzari e scarpe.
Sutor chiamavasi l’artefice che cuciva in cuojo,
adoperando la lesina, subula, e introducendo la setola,
seta; onde sutrina la bottega di lui. Dalla diversa qualità
del lavoro, dicevasi sutor crepidarius, o sutor caligarius,
[328]
o anche calcearius; onde la parola nostra calzolajo.
Facevansi pure da’ calzolai romani i coturni,
ed erano essi stivali di greco modello, di cuoio, usualmente
portato da’ cacciatori e copriva l’intero piede e
la gamba sino al polpaccio, allacciandosi sul davanti
ed arrovesciato in cima con una ritoccatura, ed
una suola diritta atta ad uno o all’altro piede, utroque
actus pedi, come scrive Servio scoliaste di Virgilio[298].
Uno stivale dello stesso genere, dice Rich, ma ornato
con più cura, è assegnato talora dagli artisti greci a
talune delle loro divinità, in ispecie a Diana, Bacco
e Mercurio e dai Romani nello stesso modo alla Dea
Roma ed ai loro imperatori, come un segno di divinità.
Così furono adottati da Marco Antonio, quando
si attribuì il carattere e gli attributi di Bacco[299]; ma
però non eran portati dai Romani come parte del loro
vestiario consueto. Cicerone biasima l’insolenza d’un
Tuditano, che si mostra in pubblico cum palla et cothurnis[300].
Il coturno portato dagli attori tragici sulla scena,
abbiam già visto avesse la suola di sughero. — I cacciatori,
oltre il coturno, portavano anche l’ocrea, specie
di moderne uose. Ocrea era anche la gambiera che
copriva lo stinco dal malleolo sino a poco sopra il
ginocchio: per lo più era di metallo e se ne scoprirono
degli esemplari in Pompei.
[329]
Crepida, era un calzare che si componeva d’una
suola alta, ornata di una bassa striscia di cuojo che
copriva solo il fianco del piede, ma aveva un certo
numero d’occhielli, ansæ, sul suo orlo superiore, attraverso
i quali passava una correggia piatta, amentum,
per allacciarla sul piede. Propriamente era peculiare
del vestiario nazionale greco ed usato dai due sessi
e si considerava come la calzatura conveniente a portarsi
col pallium e colla chlamys. Le crepidæ carbatinæ
erano poi le più ordinarie di tutte le calzature in uso
fra gli antichi e particolari ai contadini delle regioni
meridionali. Consistevano in un pezzo quadrato di
cuojo per suola, poi rivoltato all’insù a’ canti e sopra
le dita, legato sul collo del piede attorno la parte più
bassa della gamba con coreggiuoli passati attraverso
dei buchi sugli orli.
Calceus era una piccola scarpa o calzaretto, per lo
più portato dalle donne. Ne’ dipinti Pompejani si videro
tre distinti modelli di essi: tutti per altro giungono
a’ malleoli, con suola e tacco basso e così senza,
come con laccetti. Calceus invece era uno stivaletto
fatto sopra forma così per il piè destro, come per
il sinistro, in maniera da coprire interamente il
piede, a differenza dei sandali e delle pianelle che
non ne coprivano se non solo una porzione. Come
poi vediamo pur oggidì usarsi dalle nostre signore,
aggiungere tacco a tacco per render alta la persona;
così per le Romane, ad esempio delle Greche,
[330]
invece d’una, usavano di due e tre suole, onde la
solea pigliava allora il nome di fulmenia, sincope di
fulcimenia. Di queste duplici e triplici suole giovavansi
inoltre, come faremmo noi adesso, per difenderci
dalla umidità. V’era il calceus patricius che
portavano i senatori, di qualità diversa da quella degli
altri cittadini; di dove la frase di Cicerone calceos mutare[301],
per significare che alcuno diventava senatore,
e s’allacciavano con istringhe che s’incrociavano sul
collo del piede e poi s’avvolgevano attorno alla gamba
sino al principio del polpaccio; il calceus repandus,
scarpa con una larga punta ricurva in su o indietro. — Calceamentum
e calceamen erano poi termini generici
per esprimere ogni maniera di copertura del piede.
Da obstragulum, che era quella striscia di cuojo o
correggia con cui la crepida si allacciava attorno al
piede e che passava tra il pollice e il dito vicino e
che da persone affettate si portava talora tempestata
di perle, come lasciò Plinio ricordato[302], derivò
obstrigillum, ch’era una particolare sorta di scarpa,
che aveva i quartieri, per i laccetti, cuciti alla suola
da ciascun lato. Di queste scarpe se n’ha esempio
in una pittura pompejana.
Sandalum era una pantufola squisitamente ornata,
che portata dalle donne greche, venne poi introdotta
[331]
dalle signore di Roma. Pare che fosse d’una forma
intermedia tra il calceolus e la solea, avendo un suolo
ed un tomajo sopra le dita e la parte davanti del
piede, ma lasciando scoverte le calcagna e la parte
di dietro, come una pantufola nostra.
Finalmente v’era la solea, della forma più semplice
del sandalum, consisteva in una semplice suola sotto
la pianta del piede, legata con un correggiuolo attraverso
il collo del piede stesso, come a un dipresso
sono i sandali degli odierni cappuccini e si portava da
ambo i sessi. V’era poi la solea spartea, o stivale fatto
di ginestra spagnuola, ma non era ad uso degli uomini,
ma delle bestie da soma, a proteggere i loro
piedi quando malati.
La solea tuttavia non si portava fuori di casa: altrimenti
sarebbe stata sconveniente o indizio di affettazione
o di moda straniera, come avvertì Seneca ed
anche Cicerone[303].
Perones, Sculponeæ e Soleæ ligneæ, erano nomi con
cui si designavano i sandali e scarpe da famigli. I
primi due indicavano calzari fatti di cuojo; le soleæ
ligneæ erano, come esprime il loro aggettivo, di legno.
E qui s’arresta la mia erudizione in fatto di calzoleria
romana e pompejana.
Non però di quanto riguarda l’arte del coriarius,
o cuojajo, perocchè ad essa spettassero quelle altre
[332]
opere che or si direbbero da sellajo. Mi sbrigherò a
dirne, sommariamente, ricordandone le sole denominazioni
de’ relativi arnesi.
Lorea si chiamavano le briglie, o corregge; le redini
più propriamente dicevansi habenæ; capistrum la cavezza,
ma più precisamente quella dell’asino; helcia, i
tiragli, co’ quali cavalli o asini si attaccavano al timone;
erano essi o lorata, o spartea, o cannabina; stragula, la
fornitura, ephippia, la sella; clitellæ, il basto; soleæ,
le staffe.
E poichè avviene di ricordare tanti oggetti di selleria,
porgo qui le denominazioni di juga lignea, o
gioghi per appajare i buoi; oreæ, il morso; frenum,
il freno; murices, lupi, lupata si chiamavano altri freni
di ferro asprissimi, atti a diverse nature di giumenti.
Or passiamo alla ricerca delle altre taberne che
coi loro prodotti contribuivano al vestimento, o piuttosto
alla varietà e mantenimento di esso.
Presso la casa di Olconio eravi una bottega da tintore,
che i latini chiamavano taberna offectoris, perchè,
secondo spiega Pompeo Festo, colorum infectoris. Distinguevansi,
secondo lo stesso scrittore, gli offectores
dagli infectores: questi erano qui alienum colorem in
lanam conjiciunt: offectores qui proprio colori novum officiunt[304].
Nulla in questa bottega si rinvenne di particolare:
[333]
nel fondo di essa eravi il laboratorio, con
un fornello e vasche rivestite di cemento assai duro,
ma pur guasto evidentemente dagli acidi che venivano
usati nel tingere.
Nè io di più mi vi soffermerò, da che egual materia
mi chiami a più largamente trattare della Fullonica.
L’arte dei fulloni, che Plinio vuole sia stata trovata
da Nicia megarese, consisteva nel purgare, lavare
ed anche tingere i panni. Trattando dell’edificio
di Eumachia nel Capitolo XI di quest’opera, ho già
fatto un rapido cenno dell’importanza di quest’arte in
Pompei, che vi aveva anzi una speciale corporazione.
Che una congenere vi fosse anche in Roma lo si raccoglie
dalle Inscriptiones publicate dal Fabbretti, ricordando
come quel collegio litigasse assai lungamente
a proposito delle fontane[305]. Infatti non poteva
a meno che essere numerosa la classe de’ folloni,
per la necessità che dell’arte loro sentivasi per
la politura delle vestimenta. Riccio ne dà informazioni
dei folloni, da cui rivelasi come di essi si
giovasse allora come adesso noi de’ nostri lavandaj
e cavamacchie per rinettare ed imbiancare gli abiti,
dopo averli portati, effetto che ottenevano col pestare
co’ piedi i panni in larghe tinozze di acqua mischiata
con orina e terra di Sardegna. I nostri cavamacchia
di presente vi sostituiscono l’ammoniaca. Allora, onde
[334]
procacciarsi tanta materia quanta ne bastasse all’uopo,
ponevansi vasi agli angoli delle Vie, come già notai
nel Capitolo appunto che tratta delle Vie; onde aveva
ragione Marziale di mordere la puzzolente Taide, dicendola
più fetida del vaso d’un follone:
Tam male Thais olet, quam non fullonis avari
Testa vetus, media sed modo fracta via[306].
Il panno così lavato e netto distendevasi sulla
cavea viminea, o graticcio semicircolare, con sottoposta
fumigazione di zolfo, come si deduce da un
passo di Apulejo[307]; dopo di che passava al cardatore,
che col cardo fullonicus, vi risollevava il pelo,
d’onde poi mettevasi allo strettojo per quella che or
direbbesi cilindratura. Fin dall’anno 354 di Roma, la
legge fatta dal Censore Flaminio, riferita da Plinio,
aveva prescritta una maniera in parte diversa dall’or
detta, con cui i folloni dovevano condursi per
[335]
ben eseguire il loro lavoro. Così si esprimeva: «Si
lavin dapprima le stofe di lana colla terra di Sardegna
disciolta; si faccia quindi una fumigazione
di zolfo, poi si purghi con terra di Cimolo, di buon
colore, riconoscendosi la falsa in ciò che lo zolfo
si rode e s’annerisce. La vera terra di Cimolo ravviva
i colori impalliditi dal zolfo. La terra chiamata
saxum è la più conveniente alle stofe bianche
quand’esse sono state solforate: esso è però nocevole
alle stofe colorate. In Grecia in luogo della
terra di Cimolo, si serviva del gesso tinfaico di
Etolia.»
L’antica Fullonica di Pompei era sulla Via di Mercurio
e riusciva su quella a cui essa medesima diè
il nome: la sua pianta chiarisce l’importanza di
questo stabilimento scoperto e sterrato negli anni 1835
e 1836.
È una grand’area, chiusa da tre lati da largo portico
fiancheggiato da pilastri con archi. In fondo
della corte si trovano quattro bacini alti, ma alquanto
inclinati per lo scolo delle acque e dinnanzi ad essi
un lungo banco di pietra, all’estremità del quale
disposti due altri piccoli bacini e muricciuoli sono
per collocarvi le vaschette. Era qui che si imbiancavano
le stofe. All’ingiro de’ portici eran le camere
dei folloni: il proprietario doveva alloggiare nell’appartamento
più distinto. Vi si rinvenne un forno co’
suoi accessorj. Il piano superiore doveva avere delle
[336]
gallerie coperte; le colonne di esse caddero indubbiamente
nell’occasione dei cataclisma.
Una fontana elegantissima di marmo, dei pozzi con
condotti esterni dovevano somministrare ai bacini e
vasche dei lavoratori acqua in abbondanza. Presso
alla fontana vi son pitture su d’un pilastro che or sta
al Museo, rappresentante le operazioni diverse de’ folloni.
In colori ancor vivi veggonsi quattro giovani
operai che colle gambe nude pestano in altrettante
conche i panni, cui per tal modo tolgono il sucidiume.
Più su si vede uno schiavo che reca un utensile per
disseccare i drappi: un altro è occupato a passare il
cardo fullonicus di ferro su di un drappo sospeso. Sull’altro
lato del pilastro è figurato uno strettojo ornato
di ghirlande; poi una bella dama che sembra dar degli
ordini ad una donna e ad uno schiavo e presso a
loro sono distese delle stofe a disseccare. Sul pilastro
vicino è dipinto un altare, fiancheggiato da due serpenti,
un Bacco ed un Apollo.
Si ritrovò nello stabilimento di questa Fullonica
molto sapone, lutus fullonicus, parecchi vasi pieni di
calce, delle caldaje e delle mestole per rivolgere il
sapone e lavorarlo. In un ripostiglio si rinvennero
cinque vasi di vetro, l’uno contenente un liquore che
si disperse per inavvertenza, un altro contenente un
succo vegetale con olio e un terzo contenente delle
olive, galleggianti nell’olio, d’una conservazione prodigiosa.
Taluna di queste olive serbavano ancora il
[337]
picciuolo ed apparivan sì recenti, che sembravan
raccolte di fresco.
Per Nuova Fullonica si designa un vasto edificio sull’angolo
del Vicolo della Maschera e si trovarono infatti
molti fornelli ricoperti di piombo e vasche rivestite
di cemento; ma Bréton si domanda: se non sia
piuttosto una lavanderia più importante di quelle
che per tali vennero denominate, e si dichiara disposto
ad accogliere questa seconda supposizione.
Dopo le Fulloniche, occupiamoci delle due fabbriche
di sapone che si trovarono finora: l’una nel 1788
presso al mercante di pesci salati, e nella bottega si
vide molto sapone per terra ed anche molta calce di
buona qualità, ma impietrita. In un’altra camera attigua
vi erano sette vasche a livello del suolo per
la fabbricazione; l’altra nella Via degli Augustali, sull’angolo
della viottola, che nulla offrì di rimarchevole,
all’infuori d’un gran forno diroccato.
Una importante corporazione erano in Pompei gli
orefici, aurifices: essi abbiamo già veduto nel Capitolo
Quarto come in una iscrizione pregassero ad
essi propizio l’edile Cajo Cuspio Pansa, e pur senza
di questa particolarità, le mille preziosità d’oro raccolte
negli scavi e l’eleganza dei lavori, imporrebbero di aggiungere
loro la massima riputazione. Collane, monili
baccati o di pallottole vermiglie, braccialetti, orecchini,
sigilli, falere, anelli e cento altre bazzicature muliebri,
sono tutte eseguite col gusto più squisito e l’arte moderna
[338]
ha ritratto da quegli oggetti molti esemplari alle
proprie produzioni. Vi si facevano anche dagli orefici
oggetti da toletta, istromenti pei sagrifici, statuette di
numi e massime di lari, pàtere, coppe, utensili ed
altre moltissime cose, delle quali il Museo Nazionale
di Napoli ribocca e va fra i Musei del mondo ammiratissimo.
E sì leggiadre cose eseguivansi dalla oreficeria di
allora, che a rigore avrebbesi da me dovuto riserbarne
la parola al capitolo vegnente, che s’intratterrà
dell’Arti. E lodatissimi artisti si ricordarono
dalle storie, di origine greca, o non mai usciti di
Grecia, le opere de’ quali erano ricercatissime in
Italia. Così ci giunse la fama di un Pasitele, che non
metteva mano a nessun lavoro d’importanza senza
prima averne abozzato il modello in argilla od in
cera, conformemente al metodo raccomandato da Lisippo.
Di lui si vantò assaissimo la perfezione di un
piccolo gruppo d’argento da lui condotto, il quale
rappresentava Roscio bambino lattante e la sua nutrice,
che fremeva nello scorgerlo avvolto fra le spire
di un serpente nella sua culla. Zopiro, altro orefice
di non minore celebrità, non uscì mai di Grecia:
ma di lui Plinio ci lasciò descritte due tazze d’argento,
nelle quali aveva dimostrata la sua rara valentía:
su l’una veggonsi Oreste uccisore della madre,
ed accusato di tale delitto da Erigone innanzi
all’Areopago, su l’altra lo stesso Oreste assolto da
[339]
quell’augusto tribunale, per l’intervento di Minerva,
che opponendosi alla fatale sentenza, gli accordava
il proprio suffragio.
Ho già detto come, più che altrove, nella Magna
Grecia, e quindi anche in Pompei, attratti fossero
gli artisti greci, ed è infatti da tutti riconosciuto che
in ogni arte del disegno gli scavi misero in luce
oggetti di lavoro greco.
Dal lato destro della Via Domiziana, dietro la taberna
vinaria di Fortunata, v’era una bottega di fabbro,
che nulla offrì di rilievo, se non che una leva
terminata con un piede di cinghiale e molti istromenti
del mestiere; non che un forno publico di forma
ingegnosa ed un piccolo larario. Nelle quattro camere
attigue alla fucina si rimarcarono le vestigia di un
bagno e di una cella vinaria, o cantina, in cui stavano
delle anfore.
Di fabbri, tanto ferraj che legnarii e carpentarj,
dovevano del resto abbondare in una città come
Pompei, dove opere edilizie d’ogni maniera, come
templi, case, acquedotti esigevano la loro mano; ed
oltre ciò, ponti, navi e opere militari richiedevano
tal numero di lavoratori, da costituire una corporazione,
alla quale era preposto un magistrato: Præfectus
fabrorum. D’un prefetto dei fabbri, Spurio Turannio
Proculo Gelliano, nominato anzi per la seconda volta
a questa carica, ho già riferito la bella iscrizione
che si trovò nel tempio di Giove di Pompei, nel Capitolo
Ottavo di quest’opera.
[340]
Un’altra industria pompejana fu constatata nel 1838
nella fabbrica di vasi di terra cotta fuori di Porta
Ercolano nel sobborgo Augusto Felice. Quivi nel forno
a riverbero, costruito in pietra, rimarchevolissimo, la
cui volta è forata da piccoli buchi per lasciar entrar
le fiamme, si trovarono trentaquattro marmitte di terra
cotta, delle quali una munita di lungo manico. Nella
bottega v’erano molti altri vasi. La volta del detto
forno, dice Bréton[308] che esisteva ancora in parte
nel 1854, ma che oggi è interamente crollata, era la
parte più singolare della costruzione, costituendosi
di vasi di terra cotta gli uni negli altri incassati,
come si adoperò nel sesto secolo per la famosa cupola
di S. Vitale di Ravenna. Alcune aperture praticate
nelle pareti del forno e munite di tubi pure di terra
cotta permettevano di moderare il calore a piacimento.
Botteghe però di lavori di terra cotta e di vetri eransi
assai tempo prima scoperte in Pompei nella strada che
conduce dal tempio della Fortuna al Foro. In una
di queste botteghe si trovarono moltissimi oggetti di
tale industria e segnatamente un numero grande di
bicchieri, di tazze e coppe, fra cui delle pregevolissime
di color celeste, di piatti e tutti di vetro conservati
nella paglia. Di creta si rinvennero molte lucerne,
pignatte con coperchi, salvadanai, in uno dei
quali anche tredici monete di Tito e di Domiziano;
[341]
oltre poi 153 monete di bronzo, una statuetta di donna
e due di Mercurio. Nell’abitazione di una di queste
botteghe si raccolse un anello d’oro e una moneta
dell’imperatore Ottone, una statuetta di Mercurio e
un’altra con corazza d’argento, clamide e calzari, creduta
di Caligola fanciullo, una statuetta di Ercole;
una lucerna capricciosa, formata da una rozza figura
di vecchio che sostiene un priapo, un’altra di creta
in forma di navetta a quattordici lumi, un cucchiajo
d’avorio, ed inoltre uno scheletro d’uomo, che avrà
dovuto fuggire per la finestra della sua casa e non
lungi due altri: il primo trasportando seco un involto
con sessanta monete, una casseruola ed un piattino
d’argento.
In Pompei si facevano inoltre, poichè sono a dire di
opere da vasajo, i Dolia, che erano vasi maggiori,
come anfore grandissime e ventrute per la prima
collocazione dei vini, tenendo il luogo delle odierne
botti. Erano essi di certa pietra detta ofite, ed anche di
terra cotta, e ne ho vedute là di capacissime, ed una
anzi apparire cucita con filo di ferro e racconciata
del modo che con laveggi e tegghie farebbero i nostri
calderai. Nella cantina di Diomede se ne trovarono
pure. Presto poi si lavorarono anche in legno:
Plinio ne fa cenno ed assunsero così la figura poco a
poco delle botti che abbiamo adesso. Quando poi era
avvenuta la svinatura, si versava il vino, se di qualità più
peregrina, in anfore minori e caratelli detti cadi, come
[342]
si evince da Plinio, il quale aggiunge la particolarità,
che giova ricordare per l’origine d’un uso che venne
conservato, che si otturassero con turaccioli di sughero.
Erano anfore e cadi della materia stessa dei
dolii, talvolta cioè di pietra ofite e quindi bianchi, ma
il più spesso di color rossi, perchè di terra cotta;
onde Marziale ha il verso:
Vina rubens sudit non peregrina cadus[309].
In questi caratelli o bariletti si riponevano non i
vini soltanto, ma olio pure e conserve di pomi, fichi
secchi, fave; e Marziale ci dice anche miele, nel seguente
pentametro:
Flavaque de rubro promere mella cado[310].
In quanto alle anfore, che risponderebbero ai moderni
fiaschi, e se picciolette, alle bottiglie, servendo
principalmente alla conservazione dei vini e degli
olj, oltre l’esser fatte di ofite, o fittili, Petronio ci
fa sapere che fossero anche di vetro, in quel passo
che narra recate sulla mensa amphoras vitreas diligenter
[343]
gypsatas, quarum in cervicibus pittacia erant affixa
cum titulo: Falernum Opimianum annorum centum[311].
Come poi si lavorassero, per quel che è della terra
cotta, risponderò: nè più nè meno che fa oggidì il
vasajo; e Orazio ce lo ha tramandato in quell’immagine
Dell’Arte Poetica:
amphora cœpit
Institui, currente rota, cur urceus exit?[312]
Nella storia militare di Roma si dirà poi come dei
dolii si valessero come di stromenti guerreschi e
massime negli assedj. Quando seguiva l’assalto delle
città, gli assediati riempivano i dolii di sassi e con
impeto gli scagliavano sugli assalitori. Altrettanto facevasi
negli attacchi nemici, allor che essi seguivano
su alcun declivio.
Qui ha fine il mio dire intorno alle Tabernæ.
Chi sa che presto, dove si spinga più alacre lo
sterramento in Pompei, non sia dato di poter strappare
ai segreti del tempo qualche nozione di altre
industrie, qualche utile congegno antico e non rivendichi
al passato il vanto di certi trovati, che assai
[344]
più tardi nepoti vollero avocare a sè stessi? L’esempio
che ci ha fornito la Casa del Chirurgo, nella quale
molti strumenti si videro che si ritenevano prima
frutto di sapienza moderna, potrebbe ancora una
volta, in altre taberne che si torneranno alla luce,
rinnovare.
Discorso per tal guisa il commercio pompejano
nella visita ed esame delle sue tabernæ, ed essendoci
così fornita la ragione della fama che si aveva questa
città procacciata di speculativa e industriale, di leggieri
allora si può rendersi conto della iscrizione,
che pel musaico della soglia del protyrum o vestibolo
di sua casa, quel cittadino pompeiano volle esprimesse
il benvenuto al guadagno: Salve Lucru. Era tutta
una sintesi di quell’anima da mercante.
[345]
CAPITOLO XVIII.
Belle Arti.
Opere sulle Arti in Pompei — Contraffazioni: Aneddoto — Primordj
delle Arti in Italia — Architettura etrusca — Architetti
romani — Scrittori — Templi — Architettura
pompejana — Angustia delle case — Monumenti grandiosi in
Roma — Archi — Magnificenza nelle architetture private — Prezzo
delle case di Cicerone e di Clodio — Discipline edilizie — Pittura — Pittura
architettonica — Taberna o venditorio
di colori in Pompei — Discredito delle arti in Roma — Pittura
parietaria — A fresco — All’acquarello — All’encausto — Encaustica — Dipinti
su tavole, su tela e sul
marmo — Pittori romani — Arellio — Accio Prisco — Figure
isolate — Ritratti — Pittura di genere: Origine — Dipinti
bottegai — Pittura di fiori — Scultura — Prima e seconda
maniera di statuaria in Etruria — Maniera greca — Prima
scultura romana — Esposizione d’oggetti d’arte — Colonne — Statue,
tripedaneæ, sigillæ — Immagini de’ maggiori — Artisti
greci in Roma — Caio Verre — Sue rapine — La
Glittica — La scultura al tempo dell’Impero — In Ercolano
e Pompei — Opere principali — I Busti — Gemme
pompejane — Del Musaico — Sua origine e progresso — Pavimentum
barbaricum, tesselatum, vermiculatum — Opus
signinum — Musivum opus — Asarota — Introduzione del
musaico in Roma — Principali musaici pompejani — I Musaici
della Casa del Fauno — Il Leone — La Battaglia di
Isso — Ragioni perchè si dichiari così il soggetto — A chi
appartenga la composizione.
Nel corso omai avanzato di questa mia opera mi
avvenne le tante volte già di parlare di statue, di
bronzi, di pitture e di musaici, di stili architettonici
[346]
e di colonne, d’edifizi e di templi, che appena il lettore
si compiaccia di raccogliere in una le disseminate
notizie, può farsi diggià una ragionevole e conveniente
idea delle condizioni dell’arte in Pompei, sotto
qualsivoglia sua manifestazione la si voglia considerare.
Nè il consacrarvi per me un capitolo apposito
significar vuole ch’io presuma dir di tutto questo
argomento così largamente, da nulla, o poco men di
nulla lasciarvi addietro; perocchè a ben altro che ad
un capitolo ascender vorrebbe allora il materiale che
mi verrebbe tra mano, come può informare chi di
proposito vi si è messo intorno.
La grand’opera di Mazois, cominciata nel 1812 e
terminata nel 1838[313], non ha infatti per oggetto
principale che la descrizione e l’esatta rappresentazione
de’ monumenti architettonici. Essa era stata
per altro preceduta fin dal 1858 dalla stampa della
magnifica opera degli Accademici di Ercolano, che,
come ognun sa, fu di parecchi volumi in folio. Nel
1824 poi ebbe incominciamento la pubblicazione del
Museo Borbonico[314], destinato a riprodurre tutti gli oggetti
d’arte che formavano dapprima i musei di Portici
e di Napoli, e che poscia vennero concentrati nel
solo Museo Nazionale.
[347]
Importantissima del pari fu l’opera Le Case ed i
Monumenti di Pompei disegnati e descritti, edita in Napoli
che, iniziata dal cav. Antonio Nicolini architetto
della Casa Reale e Direttore dell’istituto di Belle Arti,
venne continuata dagli egregi fratelli Fausto e Felice
Nicolini, ed è tuttavia in corso di publicazione.
È sventura davvero che opere, come queste, degnissime
e che meriterebbero di andar diffuse e consultate,
non lo possano, perchè dispendiose di troppo. — Più
alla mano e pel sesto e per il prezzo riuscì l’altra
Ercolano e Pompei, che mandò fuori in Venezia il tipografo
Antonelli nel 1841, e furono publicati sette
volumi, voltandola dal francese di Bories e di Barré e
che si giovò di tutte le anteriori publicazioni, divisa
essa in due parti: Pitture e Scolture e Musaici e suddivisa
in più serie.
Nè vogliono essere pretermesse altre opere congeneri
e di merito singolare, come quella di Goldicutt
di Londra; di Ternite e Zahn di Berlino; di Goro di
Vienna, e meglio forse di tutte queste, quelle di William
Gell, della quale si fece una versione a Parigi
con moltissime aggiunte.
Intorno all’autenticità dei disegni publicati nelle più
antiche opere, molti dubbj elevar si potrebbero, da
che sia noto come prima il Governo Borbonico avesse
opposto formale divieto alla copia delle pitture antiche,
onde in quanto si avesse a diffondere di quelle
d’Ercolano e di Pompei non si potesse riscontrare
[348]
tutta quella esattezza e fedeltà, che non concede il
copiar di memoria.
Su di che tolgo al Barré l’aneddoto seguente, abbastanza
curioso e che mette conto di riferire.
In onta alle precauzioni alcuna volta esagerate, con
cui erano guardati gli affreschi del Museo che in
quel tempo era a Portici, alcune copie furtive fatte
vennero per mezzo di ricordi, e il publico le ricercava
con tanta maggior avidità, quanto ch’ell’erano
più rade, e con più riserbo vendute. Giuseppe Guerra,
pittore veneziano, stabilito a Roma, mentre mancava
di lavoro, quantunque non assolutamente sprovveduto
d’ingegno, imprese ad innalzare, con una frode anche
più ardita, l’edificio della sua fortuna. Guerra non
si avventurò solo a spacciar copie di antiche pitture,
ma vendette quelle pitture medesime. Egli dipinse
differenti affreschi di antico stile sovra frammenti di
intonaco, e li cesse ad alcuni amatori, confessando
loro, sotto sigillo di alto segreto, averli acquistati
egli medesimo da un qualche sovrintendente agli
scavi napolitani. Fecesi rumore per ciò a Napoli, dove
invano cercavasi il colpevole; ma per indizii positivi
ricavati da Roma, i direttori del Museo fecero in sulle
prime segretamente comperar tre degli affreschi che
giravano in questa capitale. Quindi uno dei loro
agenti portossi dal Guerra chiedendogli l’Achille e il
Chirone, dipinti pompejani di recente scoperti, allora
già incisi e publicati nel primo volume delle
[349]
Antichità di Ercolano. Guerra, senza diffidenza alcuna,
fece la copia, o meglio, l’imitazione domandata,
mentre egli non poteva lavorare coll’originale
sott’occhio. In questa copia da lui sottosegnata,
si conobbe esattamente lo stile dei tre affreschi acquistati;
i medesimi sforzi per raggiungere un modello
veduto alcun poco solamente da lungi; le medesime
differenze sfuggite in onta a questi sforzi e sovratutto
la perfetta analogia delle copie fra loro, quantunque
si scorgesse molta diversità ne’ modelli. Il Governo di
Napoli a nulla si valse della sua influenza nello
Stato Pontificio per far redarguire il Guerra. Limitossi
a esporre le quattro imitazioni unite agli originali,
con una illustrazione diffusa, onde por sull’avviso
i curiosi contro ogni frode di genere siffatto.
Guerra, più non potendo alienare false antichità, ripigliò,
non senza qualche profitto, l’uso legittimo del
suo pennello[315].
Tutto questo premesso, avanti entrare a parlare
partitamente delle preziose cose in fatto d’arte scoperte
a Pompei, oltre quel che già toccai e che il
lettor già conosce, non sarà inopportuno che io l’intrattenga
delle condizioni generali delle arti nel mondo
romano; onde questo mio lavoro illustrativo dell’antica
vita di Roma col mezzo delle scoperte pompeiane
non sia in questa parte cotanto importante difettivo.
[350]
Dopo che nel Capitolo antecedente ho chiarite le
ragioni per le quali da agricoltori che erano i romani
per nascita e per tendenza, passarono insensibilmente
a divenir soldati e conquistatori, ed ho tracciate le
cause che tolsero a Roma d’avere un florido commercio
coll’estero, non credo necessario ritessere i
motivi per i quali pur nelle arti non furono i romani
eccellenti, ma anzi piuttosto delle medesime
ignoranti. Sono essi identici a quelli che rattennero
lo sviluppo del commercio; onde il ragionamento
intorno all’arti romane vuol essere una logica deduzione
di que’ motivi, che però mi accorciano il dirne
qui particolarmente e più a lungo.
Architettura.
L’arte nondimeno, come ogni altra intellettuale coltura,
non aveva così le medesime sorti nelle altre parti
d’Italia. Nell’Etruria singolarmente era in fiore; la
sua architettura, o a dir meglio, il suo ordine che
serbò il nome di etrusco, comunque ne sia meno ornato,
si accosta al dorico. Nè io già reputo che importato
fosse, com’altri opina, da’ Pelasgi; ma dividendo
le opinioni del chiarissimo Mazzoldi, penso che la
civiltà etrusca fosse anteriore all’incivilimento di Grecia.
Gli scavi fattisi pure ai nostri giorni in diverse
parti di quella nobile provincia, oltre quanto è nelle
storie antiche consegnato, fornirono monumenti e dati
[351]
attissimi a comprovare queste condizioni antiche dell’arte
in Etruria. Nè diversamente nella Magna Grecia
e in Sicilia, dove alla coltura nazionale s’aggiunse
la greca importatavi dai più frequenti commerci.
E qui giova osservare che sotto la denominazione
di civiltà etrusca, vuolsi abbracciare come in essa
compresa tutta quella parte di territorio che dall’odierna
Toscana o dal piede dell’Alpi si distende fino
allo stretto di Sicilia.
Le prime opere infatti de’ Romani si assegnano ad
architetti etruschi. Così fu la Cloaca Massima, immaginata
per disseccare i terreni bassi situati nelle
circostanze del Foro, che, intrapresa sotto il reggimento
del vecchio Tarquinio e continuata da Servio
Tullio, venne compita sotto Tarquinio il Superbo[316]
e che somministra un dato interessante alla storia
dell’Architettura, venendo essa a provare che l’invenzione
dell’arco appartenga a’ Romani e non ai
[352]
Greci, poichè vi si vegga esso grandiosamente sviluppato
in un’epoca in cui, se esisteva in Grecia, non
era punto in uso. Sul qual proposito, osserva Hope
che l’arco già fosse introdotto in Etruria in monumenti
che sembrano anteriori alla costruzione della
cloaca ed alla fondazione di Roma[317]. Per i primi
cinque secoli, Roma pare non prendesse cognizione
affatto dell’arte architettonica, e i templi e i pubblici
e privati edifizj suoi si sa perfino che non sapesse
coprire che di stoppie mescolate all’argilla, come i
viaggiatori trovarono praticarsi pur oggidì in molte
terre selvagge. Nè l’acquedotto della Via Appia, che
fu costrutto nell’anno trecentodieci di Roma, può
fornir argomento che smentisca codesta asserzione,
perocchè la sua opera correndo tutta sotterranea,
non porga aspetto alcuno di forme architettoniche.
Tuttavia tracce di una architettura disciplinata addita
la storia in Roma nel sepolcro in peperino di
Scipione Barbato, il quale fu console nell’anno 456
della fondazione della città, sormontato da un triglifo
dorico pur sormontato da dentelli jonici, e tre secoli
avanti l’Era volgare si costrussero intorno al foro
portici per le tabernæ degli argentarii o banchieri.
Per le conquiste fatte nella Grecia, vennero di là
in Roma dietro il carro de’ trionfatori, colle scienze
[353]
e colle lettere, anche le arti, che pur vi accorsero
dalla Magna Grecia e dalla Sicilia, e delle spoglie
delle vinte città, fra cui oggetti pregevolissimi
d’arte, si fregiarono templi, monumenti e case de’
vincitori. Incominciò anche per Roma ad essere
pure l’architettura, che abbandonò da allora lo stile
etrusco, per adottare il greco, quel che disse il Milizia,
depositaria della gloria, del gusto e del genio dei
popoli, ad attestare ai futuri secoli il grado di potenza
o di debolezza degli stati. Così nel 205 avanti Cristo
si ornò da Cajo Muzio, su pensiero di Marco Claudio
Marcello, di fregi tolti a Siracusa, il tempio dell’Onore
e della Virtù, e si impiegarono marmi nella costruzione.
Metello nel 147 inviò dalla soggiogata Macedonia
pitture, statue e tesori; per cui si eresse coll’opera
di Ermodoro da Salamina il tempio periptero
a Giove Statore, e quindi quello sacro a Giunone,
prostilo e cinto da gran cortile con bel colonnato
all’intorno.
Altri templi si erano venuti erigendo nella stessa
Roma durante la seconda guerra cartaginese, al tempo
cioè d’Annibale, che fu intorno al 220 avanti Cristo;
ma, ripeto, che le discipline accertate e stabili dell’arte
architettonica non si venissero fondando che
colle conquiste e coll’arricchimento del Popolo Romano
e col diffondersi di sua coltura; perocchè ben
dicesse il succitato Milizia, che l’architettura non incomincia
ad essere un’arte presso i differenti popoli,
[354]
dov’ella può estendersi, che quando sono pervenuti
ad un certo grado di coltura, d’opulenza e di gusto.
Allora, allontanandosi sempreppiù dai lavori e dalle
occupazioni rustiche, gli uomini si rinchiudono nella
città, dove ai perduti piaceri della natura sottentrano
i godimenti delle arti imitatrici. Prima di quel tempo,
l’architettura non si deve contare che tra i mestieri
necessarj ai bisogni della vita, ed essendo fin allora
i bisogni limitatissimi, il suo ufficio si riduce a non
far che un ricovero contro le intemperie.
I tre ordini più nobili, il dorico, l’jonico e il corintio
del pari che la scultura, passarono dalla Grecia in
Roma belli e perfetti, portati da quella schiera di artisti,
che le nuove vie aperte dalle conquiste e il
desiderio di far fortuna sospinsero alla capitale del
mondo.
Cicerone ricorda fra coloro che si diedero ad architettare
in quel tempo i principali monumenti in
Roma, nello stile greco, un Cluazio, un Ciro e Vezio
liberto suo. E fu intorno alla medesima epoca che
si scrissero anzi opere su quest’arte e citasi a tal
proposito un Rutilio, che ne dettava una assai stimata
allora, sebbene incompleta; restato essendo il
vanto di questo più degnamente fare a Vitruvio, vissuto
al tempo d’Augusto, che però invano Hope,
con altri, dà per greco; ma che, per sentimento dei
più, vuolsi nascesse per contrario in Formia, posta ove
è oggi Mola di Gaeta.
[355]
Allora sul colle capitolino, settantott’anni avanti
l’Era volgare, sorse il Tabulario, di cui esistono tuttavia
considerevoli avanzi, uffizio od archivio nel
quale si conservavano i registri e documenti publici
e privati, i cui archi esterni si aprono tra mezze colonne
doriche; poi il tempio della Fortuna Virile e
il delubro funerario di Publicio Bibulo sullo stesso
colle; quello rinnovato per cura di Lucio Cornelio
Silla e dedicato a Giove Capitolino, quello all’Onore
eretto da Cajo Mario e quello finalmente sacro a Venere
Genitrice fatto costruir da Pompeo.
Ma quello che lasciò addietro ogni altro edificio,
per la sua magnificenza, fu il tempio alla Fortuna,
che il medesimo Silla fabbricò a Preneste, delle rovine
del quale si costruì ne’ secoli posteriori Palestrina.
Vuolsi vi si ascendesse per sette vasti ripiani,
nel primo ed ultimo dei quali correva per tubi latenti
e serbatoj copia di acqua e del quale serviva
a pavimento quel prezioso musaico, che Plinio il naturalista
afferma essere stato il primo che fosse lavorato
in Italia, e il quale andò poscia a costituire
uno de’ pregi precipui del palazzo Barberini in Roma.
Ventisei anni prima di Cristo, Vipsanio Agrippa,
genero di Augusto, dedicò a Giove Ultore il Panteon,
che fu una rotonda che riceveva la luce unicamente
dalla apertura della cupola, dell’altezza e
diametro di quarantatre metri, e il frontone della quale,
bello per sedici maestose colonne corintie di marmo
[356]
di un sol pezzo, dell’altezza di trentasette piedi e di
cinque di circonferenza, e, superstite, viene tuttavia
ammirato e sta in testimonio eloquente delle egregie
condizioni dell’architettura di quel tempo.
Io ho già descritto a suo luogo i templi, il foro
civile, la basilica e vie via altri publici edifizi di
Pompei: la loro architettura ne interessò: essa rimonta
per tutti ad epoche anteriori a Cristo e principalmente
vi dominano gli ordini greci; ciò che
forse scaltrisce come prima fors’anco che a Roma,
in ragione dei maggiori commerci, artisti di quella
contrada avessero visitato e lavorato nella Magna
Grecia. Ciò che di particolare vuol essere notato in queste
architetture pompejane si è che le colonne, parte
principale e caratteristica delle fabbriche greche, e
divenute ornamento nelle romane, quivi venissero mutate
da un ordine all’altro col rivestirle di stucco,
senza curarsi più che tanto dell’alteramento delle
proporzioni.
Ho già notato altrove come nelle sostruzioni degli
edifici pompejani si riscontrino traccie di una preesistente
e più antica civiltà, e come pei diversi cataclismi
intervenuti a quella città, appajano quelli
edifizj non di molto remoti, nelle date di lor costruzione,
da quella della loro ultima rovina: di qui è
dato argomentare che alla storia dell’arte italiana
tornerebbe più vantaggioso il disseppellimento della
città d’Ercolano. Ognun s’accorda nel ritenere che
[357]
Ercolano possa essere stata una città più artistica di
Pompei, perocchè in questa meglio si fosse dati alle
commerciali speculazioni, e in quella vi concorressero
invece più i facoltosi e fosse luogo meglio acconcio
alle villeggiature de’ più ricchi e voluttuosi
romani, non altrimenti che Baja, Bauli e Pozzuoli.
Infatti le pitture, i marmi, i bronzi che si rinvennero
in Ercolano, si riconobbero generalmente superiori
d’assai in merito alla maggior parte di quelli
che uscirono dalle rovine della città sorella, della
quale specialmente è il mio dire.
Se non che io non credo, e l’ho già detto, che, ciò
compiere si possa con quella grande facilità, che per
avventura sembrava al Beulé si potesse fare[318]; perocchè
non è vero che si riducano, com’egli dice, a due sole le
difficoltà che si incontrano al diseppellimento: le costruzioni
moderne che abbisogna espropriare e le
quantità delle ceneri che convien d’asportare. E le lave
e le ceneri petrificate? Vi hanno luoghi in cui le
prime hanno perfino diciotto metri di spessore e su di
esse si è fabbricato, tal che dove già s’era penetrato,
e s’erano tratte le più interessanti preziosità, si fu
costretti a rimettere il materiale cavato onde ovviare
alla rovina. Notisi poi che le costruzioni finitevi sopra
sono di tale natura da riuscire dispendiosissima la
[358]
espropriazione, nullamente è in proporzione dei mezzi
che sono messi a disposizione degli scavi. Del resto
l’età che corre è più cotoniera e trafficante che archeologa
e poeta, gareggiano con essa di pillaccheria,
in fatto di publica istruzione, i nostri uomini di governo
che parteggiano per la teoria, d’invenzione
del nostro tempo, delle economie infino all’osso[319].
Ciò che particolarmente dovrebbe chiamare la
nostra attenzione è l’architettura delle case private
di Pompei. Era essa etrusca? era greca? era romana?
Chi lo saprebbe, rispondo io, definire in modo irrecusabile?
I dotti questionarono tra loro e non s’intesero;
forse non va errato chi di tutti questi generi
d’architettura afferma riscontrare un miscuglio, che
non lascia tuttavia che vi campeggi, per la semplicità
ed eleganza degli ornati, la caratteristica greca. Chi
credesse peraltro immaginare alcun lontano riscontro
nella maniera odierna d’architettare, si ingannerebbe
a partito; l’architettura delle case pompejane è
quanto di più originale presenta lo studio della dissepolta
città. La massima parte di esse si costituisce
di due soli piani: rado avviene che se ne trovi alcuna
che lasci presumere essere stata di tre, e dico
che lasci presumere, perchè in nessuna il terzo piano
[359]
sussiste e solo è dato argomentarne la esistenza dalle
traccie delle scale del secondo. Anche il secondo
piano, che sarebbe il così detto solarium, o meglio
cœnaculum, era assai basso e destinato alla abitazione
degli schiavi addetti al servizio della famiglia. Esternamente
esse erano allineate tutte l’una dopo l’altra
in ogni via; se interruzione vi era circa l’altezza,
veniva prodotta da talun edificio publico, che sopravanzava.
Erano poi intonacate e colorate, non avevano
finestre respicienti sulla via, le camere venendo
rischiarate all’interno, rada era qualche apertura al
piano superiore, e balcone, come avverrà di vedere
nella casa del Balcone pensile. Per ciò che riguarda
la distribuzione interna, sarà argomento che procaccierò
trattare nel capitolo Le Case. Nondimeno fin
d’ora non mi è lecito di passar oltre senza far cenno
della picciolezza delle case pompejane, o piuttosto
delle camere ond’esse si componevano, la qual non
lascia di colpire chi per la prima volta visita questa
città. Nè forse potrebbe esserne una ragione quella
che i suoi abitatori suolessero, più che chiudersi dentro
delle medesime, vivere in piazza e per le vie, siccome
consentiva la dolcezza del clima; quando pure non
si voglia interamente ammettere, ciò che per altro io
credo verissimo, che per costumanze antichissime
greche, importate in Pompei, siasi appunto seguitata
la moda greca, che appunto assai picciole aveva tutte
le parti architettoniche delle abitazioni, procedendo
[360]
nondimeno una non dubbia eleganza dalla esatta
armonia delle medesime. Tuttavia voglionsi per alcuni
ritrovarvi altre cause, della cui aggiustatezza
lascio volontieri giudice chi legge. Si dice che occorrendo
nelle case per tanti usi svariati una quantità
di stanze, queste dovevano necessariamente risultare
nella maggior parte di piccole dimensioni, che l’occhio
però non se ne avvedesse troppo, mercè un
artificio di dipinture prospettiche sui muri e di decorazioni
combinate con accortezza[320]. Ma forse
queste ragioni, che potrebbero attagliarsi a taluna
casa costretta fra l’altre, non pajono troppo plausibili
per tutte, non vedendosi perchè, abbisognando di
molte camere, non si potesse procacciarsele, come
si pratica di presente, estendendo l’area de’ fabbricati.
Le decorazioni prospettiche, appunto per la soverchia
angustia degli ambienti, potevano esse poi
produrre tutti i loro effetti e simulare uno spazio
maggiore? Ne dubito e preferisco attenermi a quelle
altre ragioni che per me si sono recate.
Del resto fu solamente al cominciar dell’epoca imperiale,
cioè ai giorni d’Augusto, che l’architettura
divenne più fiorente e si sviluppò ne’ romani il gusto
delle costruzioni colossali. Prima, come in Pompei,
templi, edifizii pubblici e case private non avevano
[361]
che proporzioni esigue: in ragione della maggior vastità
di concetti politici delle conquiste e della crescente
ricchezza eransi venute ingrandendo ed assumendo
un proprio carattere nazionale. Nelle forme
esteriori poi si restò, è vero, fedeli allo stile greco;
ma per guarentirne la solidità dell’interno vi si introdussero
colonne ed archi.
Ma per seguire la cronologia delle opere più celebrate
in fatto d’architettura di quel tempo, uopo è ricordare
la basilica di Fano architettata da Vitruvio
e da lui descritta nella sua opera De Architectura;
i portici onde si cinse il circo Flaminio sotto l’impero
di Augusto, la piramide di Cajo Cestio, il teatro di
Marcello e il tempio di Giove Tonante. Quindi il mausoleo
di Augusto nel campo Marzio, divenuto ben
presto quasi una città marmorea e il Palazzo d’oro
fabbricato da Nerone sulle macerie degli edifizi da
lui incendiati, il quale abbracciava l’area del monte
Palatino, del Celio, dell’Esquilino e la frapposta valle
estesa quanto l’antica città, dove correva un portico a
triplici colonne della lunghezza d’un miglio, e dove nel
vestibolo, sorgeva la statua colossale in rame dell’imperatore,
opera del greco Ateneo, alta quaranta metri,
secondo alcuni, secondo altri di Zenodoro d’Alvernia,
alta cento metri. Dovunque poi e fani e colonne
ed archi, divenuti questi in breve distintivo
singolare della romana architettura, poichè ignoti
ai Greci. Il primo che sorse — giova allora ricordarlo — fu
[362]
139 anni prima di Cristo, e fu ad onore
di Fabio vincitore degli Allobrogi e degli Alvernii.
Anche in Pompei ho già segnalato l’esistenza di
quattro archi di trionfo, e rimangono essi novella
prova del modellarsi interamente delle colonie sugli
usi della capitale.
Il paragone della romana colla greca architettura
è così a un dipresso come l’ho già pur io superiormente
dimostrato, da Hosking istituito. «Benchè inferiore,
scrive egli, in semplicità ed armonia all’architettura
greca, la romana è evidentemente della
stessa famiglia, distinta per esecuzione più ardita ed
elaborata profusione d’ornamenti. Il gusto delle due
nazioni è espresso dal dorico pel primo, dal corintio
per l’altro: uno è modello di semplice grandezza,
perfetto nelle particolari convenienze e inapplicabile
ad oggetto diverso; l’altro è men raffinato, ma molto
adorno; sfoggia nell’esterno la bellezza di cui manca
nell’interno; imperfetto in ciascuna combinazione, ma
applicabile ad ogni proposito.»
La storia poi della romana architettura segna le
diverse fasi della sua politica, e come che Roma si
pose alla testa del mondo, anche la sua architettura,
più che ogni altra giganteggiò; perocchè sia anche
l’arte più alta a rappresentare la terribile e vastissima
grandezza di quel popolo.
Infatti a’ tempi più liberi e primitivi appartiene il
modo d’architettare derivato dall’Etruria, che si palesa
[363]
solido e severo: a que’ dell’impero se ne spiegò
la magnificenza: al declinar del medesimo si mostrò
cincischiata di fregi e deviò dal gusto antico; per poi
corrompersi affatto, parallelamente alla corruzion dei
costumi.
Nè questi caratteri e questa magnificenza furono
distintivi de’ publici edifizj soltanto: essi riscontransi
eziandio ne’ privati e nelle loro abitazioni. Così furono
celebri le costruzioni di Lucullo, di Lepido, di
Scauro, d’Aquilio, di Mamurra; così nel Capitolo che
verrà delle Case designerò pure in Pompei abitazioni
di cittadini magnificentissime. Per dare un’idea ancorchè
imperfetta di tanta magnificenza, basterà l’accennare
qui il grandissimo loro prezzo. La casa che
Cicerone possedeva sul monte Palatino, gli era stata
venduta da Crasso per tre milioni e cinquecento mila
sesterzi, che si vorrebbero ragguagliare in oggi a lire
nostrali 736,125. Quella di P. Clodio, che Cicerone
tanto avversò e che fu poi ucciso da Annio Milone,
era costata quattordici milioni ed ottocento mila sesterzi,
vale a dire 3.027,833 lire e centesimi trentuno.
Non credo fuor di proposito, dopo tutto il fin qui
detto, di qui soggiungere ora brevemente alcuni cenni
intorno a talune discipline dell’edilizia romana, al
tempo della Republica.
Allorquando accadeva di dover costrurre o riparare
un edificio, praticavasi ad un dipresso quello che
già notai si facesse in Pompei per le riparazioni delle
[364]
vie. I Censori mettevano l’opera al publico incanto,
quando pure essi medesimi non se ne fossero costituiti
direttori, o non si fossero fatti rappresentare da
loro delegati, duumviri, triumviri, quinqueviri. Compiuta
la costruzione, i censori o gli edili venivano da un
senato-consulto incaricati di collaudare e ricevere le
opere, il cui prezzo veniva pagato dal publico tesoro.
Spesso occorse che facoltosi uomini, in caccia di popolarità,
previo aver riportato un senato-consulto, costruir
facessero e riparare a propria spesa publici edificj:
nel primo caso essi ottenevano l’autorizzazione
di far iscrivere il loro nome sul monumento; nel secondo
essi avevano facoltà di scriverlo a fianco del
fondatore.
Pittura.
L’architettura interna delle case, per ispiegare tutto
quel lusso e magnificenza che superiormente dissi,
si giovò ben presto anche dell’arte sorella, la pittura;
e se sappiam per le istorie che Ludio coprisse le
pareti delle case di paesaggi, di vendemmie e di
scene campestri; gli scavi di Pompei ci hanno messo
in grado di stabilire con tutta certezza che altrettanto
si dovesse fare ovunque a que’ giorni.
Nè furono soltanto dipinti, fregi, festoni, fiori, uccelli,
delfini e animali, tritoni, sfingi, paesaggi, genj
od altri leggieri soggetti, che ne fecero le spese; ma
[365]
vi si istoriarono fatti mitologici e veri e perfino soggetti
di genere, come avvenne già di più volte mentovare
in queste mie pagine, nelle quali, in difetto
di meglio, dovetti ricorrere a cotali dipinti per chiarire
la natura di commerci e de’ mestieri che si esercitavano
nelle diverse tabernæ.
Ma dirò per ordine di tutte queste specie di pittura
e prima di queste che direi strettamente architettoniche.
Descriverle partitamente è impossibile all’economia
di quest’opera, per la loro infinita varietà, tal che
costituirono per chi lo volle fare i soggetti di più volumi:
basti adunque il constatarne per la massima
parte l’eleganza delle linee e dei fregi, l’interesse
delle storie che vi sono congiunte e la bontà de’ paesaggi,
i quali, se non sempre, tuttavia offrono talvolta
la conferma di quanto venne dagli scrittori d’arte
affermato, della profonda cognizione, cioè, che avevano
gli antichi delle discipline della prospettiva sì
aerea che lineare. Spesso giovano alle cornici, uccelli,
grifoni, ippocampi, pesci e bestie, frutta ed arbusti,
talvolta patere, genietti, Vittorie alate e Fame, e vie
via mille altre leggiadrie del miglior gusto. L’arte decorativa
de’ nostri giorni vi avrebbe indubbiamente
a studiare, desumere e guadagnare; nè chi s’è fatto
nome in essa, ha veramente lasciato di attingervi a
piena mano.
I colori rosso e giallo vi campeggiano nella parte
[366]
architettonica e nella decorativa: già l’osservai parlando
sovente de’ colonnati rivestiti di stucco di questi
colori e di altre parti di edificj e templi. È per altro
da notarsi come nelle più antiche pitture e in Pompei
ed altrove si facesse uso di un sol colore, dette perciò
monocromatiche, fondendosi quindi l’interesse nel
concetto e nel disegno.
Ma poichè sono a dir de’ colori, la riserva che ne
ho fatto nel Capitolo antecedente mi invita a parlare
della Taberna del mercante di colori, che fu rinvenuta
negli scavi pompejani e che doveavi necessariamente
essere in una città nella quale anche nelle più
modeste case si ammiravano buoni dipinti. Essa è in
quella località che vien designata dalle Guide per la
casa dell’Arciduca di Toscana, così chiamata, perchè
spazzata dalle ceneri nel 1851 alla presenza del principe
ereditario del granduca Leopoldo II; ed è segnata
dai n. 47, 48 e 49 che stanno su tre botteghe, in cui
vennero appunto trovati in grandissima quantità molti
colori, coi relativi mulini che li dovevano macinare,
suppergiù eguali a quelli di cui si valevano per la
macinazione de’ grani. La differenza consiste forse
unicamente nella maggior piccolezza loro.
Sottoposti questi colori alla analisi chimica, si conobbe
come vi fosse commista molta resina, che, per
quel che verrò a dire tra breve, serviva nella pittura
all’encausto, per far attecchire i colori colla azione
del fuoco e così fu in certo modo strappato al silenzio
[367]
dei secoli una parte del processo di che si valeva appunto
l’encaustica. Quantità di resina pura fu rinvenuta
nelle stesse botteghe, dove si raccolsero eziandio
quattordici scheletri; forse il personale tutto impiegato
in quella officina.
Uscendo adesso da questa interessante taberna, e
passando a dir della restante pittura, seguì ella, come
la scoltura e l’altre arti, le medesime origini, fasi e condizioni.
In Roma non si può dire che avesse avuto favore
dapprima: di pochi artisti pertanto romani è fatto
cenno dalle storie: Plinio ricorda appena tra essi
Fabio, Arellio, Amulio, Cornelio Pino e Accio Prisco,
pittori, oltre Pacuvio, che distinto poeta tragico, trattò
anche la pittura. La coltura delle arti consideravasi
poco più che opera servile, e se la rapacità de’ proconsoli
tolse a Grecia, per arricchirne Roma e le ville ad
essi spettanti, tanti preziosissimi oggetti; essi tuttavia
riguardavansi più come stromenti di lusso, che altro,
nè svegliavano quell’intellettuale interesse che si suscitò
di poi; se Virgilio non fu rattenuto dal sentimento
di nazionale orgoglio dal riconoscere che il
merito di foggiare marmi e bronzi da farne volti animati
e quello del perorar meglio le cause spettassero
a gente straniera:
Excudent alii spirantia mollius æra,
Credo equidem vivos ducent de marmore vultus,
Orabunt causas melius, cœlique meatus
Describent radio, et surgentia sidera dicent:
Tu regere imperio populos, Romane, memento:
[368]
Hæ tibi erunt artes; pacisque imponere morem,
Parcere subjectis, et debellare superbos[321].
Orazio, malgrado proclamasse i Romani giunti al
sommo della fortuna, faceva tanto conto dell’arti del
pingere e del cantare, da metterle a paro di quella
del lottare:
Venimus ad summum fortunæ. Pingimus atque
Psallimus, et luctamur Achivis doctius unctis[322].
e ascrisse in vizio a Grecia l’aver pregiato marmi,
bronzi e pitture:
Ut primum positis nugari Græcia bellis
Cœpit, et in vitium fortuna labier æqua:
Nunc athletarum studiis, nunc arsit æquorum,
Marmoris aut eboris fabros, aut æris amavit:
Suspendit picta vultum, mentemque tabella[323],
[369]
e prima di loro Cicerone vergognasse quasi di ricordar
i nomi di quei divini scultori che furono Prassitele
e Policleto e credesse menomar l’importanza loro
confessandosi, egli abbastanza vanaglorioso, dell’arti
belle ignorante.
Eccone i passi, perocchè paja tutto ciò veramente
incredibile e strano:
Erat aput Hejum lararium cum magna dignitate in
ædibus, a majoribus traditum, perantiquum: in quo signa
pulcherrima quattuor, summo artificio, summa nobilitate,
quæ non modo istum, hominem ingeniosum, verum
etiam quemvis nostrum, quos iste idiotas appellat,
delectare possent: unum Cupidinis marmoreum, Praxitelis.
Nimirum didici etiam, dum in istum inquiro, artificum
nomina.... Erant ænea præterea duo signa non maxima,
verum esimia venustate, virginali habitu, atque vestitu
quæ manibus sublatis sacra quædam, more Atheniensium
virginum, reposita in Capitibus, sustinebant. Canephoræ
ipsa vocabantur. Sed earum artificem quem? quemnam?
recte admone: Policletum esse dicebant[324]. Più tardi
[370]
invece sì l’arte del dipingere che quella dello scolpire
parvero crescere in maggiore estimazione, se Nerone
imperatore vi si applicò e distinse.
La più gran parte delle pitture antiche erano parietarie,
quelle che in oggi, dai diversi procedimenti
adottati nel pingere, chiameremmo affreschi. Nondimeno
anche allora non è escluso che si potesse da
quegli artisti dipingere sull’intonaco recente. Anzi
il dottissimo cav. Minervini ha constatato non dubbie
differenze nei diversi sistemi onde sono condotti gli
intonachi che ricoprono le pareti pompejane. Ne
ha distinti di più fini, per i quali, a suo credere,
gli antichi dipingevano a fresco le composizioni
meglio accurate, i paesaggi e le figure; mentre che
le semplici decorazioni erano dipinte a secco da
pittori inferiori.
Il più spesso rilevasi evidentemente come suolessero
dipingere a guazzo od all’acquerello con colori
preparati a gomma, ovvero con altro genere di glutine,
[371]
e se ne adducon le prove in gran numero di
dipinti pompejani esistenti nel Museo di Napoli, i
colori de’ quali si ponno separare e staccare dall’intonaco,
talvolta ben anco vedendosi ricomparire,
nel cadere lo strato superiore, la sottoposta tinta, ciò
che non può accadere di pitture frescate. Quando
poi si ponga mente che fra i colori adoperati allora
eranvi quelli che chiamavano purpurissum, indicum,
cæruleum, melinum, auripigmentum, appianum e cerussa,
e i quali non resistono alla calce[325], si mette in sodo
che il processo non poteva essere a fresco.
Uno dei metodi più usitati in quel tempo era del
pingere all’encausto, e se ne valeva assai per le pitture
sulle pareti. Più sopra nella taberna del mercante
de’ colori, abbiam trovato molti ingredienti che
servivano a tale scopo. Era l’encaustica l’arte di dipingere
con colori mescolati con cera e di poi induriti
coll’azione stessa del fuoco. Di qual modo si praticasse
in antico, di presente più non si sa, essendosene
smarrito il procedimento. Vero è che il conte
Caylus pretese averlo rivendicato e ne scrisse al proposito
un trattato; ma per general sentimento non
credasi che sia riuscito ad ottenerne i medesimi risultamenti.
[372]
Pare, scrive Rych[326], ch’essi seguissero
diversi metodi e conducessero l’operazione in differentissime
guise: o con colori mescolati con cera,
distesi con una spazzola asciutta e poi bruciati con
un cauterio (cauterium), ovvero marcando i contorni
con un ferro rovente (cestrum) si incideva sopra l’avorio;
nel qual processo non pare che la cera entrasse
punto, o infine liquefacendo la cera con cui i
colori erano mescolati, cosicchè la spazzola era intinta
nel liquido composto e il colore disteso in istato
di fluidità, come si fa all’acquerello, ma di poi rammorbidito
e fuso coll’azion del calorico.
Contrariamente a quanto afferma Bréton, che l’encausto
fosse bensì in uso allora, ma indubbiamente
solo pei quadri e non per le pitture di semplice decorazione[327],
vogliono altri che il metodo dell’encausto
fosse quello adottato in tutte le pitture pompejane,
come in quelle scoperte ad Ercolano. Mengs
per altro portava opinione che esse fossero invece
condotte a fresco[328].
Ho poi detto che la più gran parte dei dipinti fossero
parietarii, ciò che significa che non tutti lo fossero;
ben sapendosi come alcuna volta si dipingesse
sulle tavole di legno, ch’erano di larice, preparate
[373]
prima con uno strato di creta, specie di pietra tenera,
friabile e bianca, sì che tabula equivalesse, senz’altro,
a quadro, come a mo’ d’esempio leggasi
in Cicerone: Epicuri imaginem non modo in tabulis, sed
etiam in poculis et in anulis habere[329]; e altrove: Tabulas
bene pictas collocare in bono lumine[330], come istessamente
oggidì ogni artista domanda di collocare
sotto buon punto di luce le sue opere, per conseguirne
i migliori effetti. Plinio poi aggiunge che si
pingesse pure sovra pelli o membrane[331] ed anche
sulla tela. Su tela, per la prima volta venne dipinta
quella grande demenza che fu la colossale immagine
di Nerone, alta centoventi piedi, che fu consunta
dal fulmine, come disse lo stesso Plinio, nei
giardini di Maja: Nero princeps jusserat colosseum se
pingi CXX pedum in linteo incognitum ad hoc tempus.
Ea pictura cum peracta esset in Majanis hortis, accensa
fulmine cum optima hortorum parte conflagravit[332]. Nè
[374]
fu sola codesta prova del pingere sulla tela allora.
Un liberto dello stesso Nerone, dando al popolo in
Azio uno spettacolo di gladiatori, coprì i publici portici
di tappezzerie dipinte su cui rappresentavansi al
naturale i gladiatori e i loro inservienti.
Del resto anche le pitture pompejane offrirono dati,
di cui giova tener conto, in conferma di quest’uso di
dipingere a pittura sulla tela, avendosene una su
parete, la quale rappresenta una dama che sta dinanzi
al cavalletto intenta a dipingere un quadro o piuttosto
a copiare un Bacco che le sta davanti; un’altra
in cui si raffigura un pigmeo, che dipinge nella
medesima guisa, ed una terza, nella quale è un’altra
donna che pur così dipinge, la quale, scoperta nel
1846, gli Archeologi opinarono potesse essere la famosa
Jaia di Cizica conosciuta da Varrone e celebrata
da Plinio[333].
Recenti scavi fatti a Pompei (1872) rivelarono come si
dipingesse anche sul marmo. Su di una tavola appunto
marmorea, rinvenuta non ha guari, si ammirò una
buona pittura a più figure, che l’illustre Fiorelli interpretò
per la scena tragica dell’infelice Niobe; importante
scoperta codesta che viene ad aggiungere
una notizia di più alla storia della pittura.
Le Pitture di Pompei si possono classificare, oltre
quelle architettoniche e decorative, di cui dissi più
[375]
sopra, in istoriche — intendendo comprendersi in esse
tutti i soggetti mitologici od eroici — e giovan moltissimo,
oltre che a rischiarare quanto noi sappiamo di mitologia
e della storia dei secoli favolosi ed eroici, a fornire
altresì nozioni circa la scienza del costume, l’arte
drammatica e l’antichità propriamente detta; in quelle
delle figure isolate e di genere; di paesaggi e animali
e fiori; ommettendo per ora qui d’intrattenermi particolarmente
di quelle delle insegne delle tabernæ,
perchè ne ho già detto abbastanza nel Capitolo
antecedente, per quel che ne importava di sapere;
molto più che a rigore implicitamente io ridirò di
esse, favellando della pittura di genere a cui appartenevan
le dipinte insegne.
Ho più sopra, sulla fede di Plinio, ricordato alla
sfuggita i nomi di alcuni pittori conosciuti in Roma:
or ne dirò il giudizio che di loro opere fu lasciato ai
posteri. Per Fabio, l’arte non doveva essere che un divertimento,
perchè, come patrizio, non aveva d’uopo
d’esercitarla, ne diffatti riuscì grande la riputazion
sua come pittore. D’altronde così ragionava Cicerone:
«Crederemmo noi che ove si fosse fatto titolo
di gloria a Fabio l’inclinazione che mostrava per la
pittura, non fossero stati anche fra noi dei Polignoti
e dei Parrasii? L’onore alimenta le arti: ciascuno è
spronato dall’amor della gloria a dedicarsi ai lavori
che possono procurargliela: ma languono gli ingegni
ovunque sieno tenuti in non cale.» Pacuvio,
[376]
poeta e pittore, quantunque arricchisse de’ proprii
dipinti il Tempio di Ercole nel Foro Boario, sembra
nondimeno che queste sue opere d’arte non oscurassero
del loro bagliore la maggior fama acquistata da
lui colla tragedia di Oreste, ancorchè la drammatica si
trovasse in quel tempo nella sua infanzia. Arellio, vissuto
qualche tempo appena prima d’Augusto, si rese celebre,
ma fu rimproverato d’aver corrotto l’onore dell’arte
sua con una insigne turpitudine e quando toglieva
a pingere una qualche Iddia, le prestava i
tratti e le sembianze di qualche sciupata, della qual
fosse innamorato; suppergiù come fanno tanti dei
pittori odierni col dipinger sante e madonne, onde la
pittura sacra cessò di produrre que’ capilavori, che
ispirava ne’ tempi addietro la fede. Amulio invece
fu severo e si narra che la sua Minerva riguardasse
lo spettatore da qualunque parte le si fosse rivolto;
Accio Prisco si loda per accostarsi meglio alla maniera
antica, e quest’ultimo viveva ai tempi di Vespasiano,
quindi presso agli ultimi giorni di Pompei.
In questa città, più ancora che in Roma, risentono
le pitture del far greco: certo molti artefici greci
quivi furono e lavorarono. Voler tener conto, oltre
quelli che già rammentai lungo il corso dell’opera,
di tutti i dipinti di storia e di mitologia, non mi
trarrei sì presto di briga: d’altra parte ho accennato
in capo di questo articolo che tratta delle Arti belle,
le opere che ne discorsero in proposito partitamente
[377]
e ne riprodussero i disegni. Tuttavia, come non dire
del quadro di Tindaro e di Leda, meritamente considerato
come uno dei più preziosi avanzi della pittura
degli antichi? Vivacità di colorito, armonia di tinte
e leggiadria di composizioni fecero lamentare che i
suoi colori oggi sieno di tanto smarriti. Così la bella
Danae scoperta nella casa di Pansa; l’Adige ferito
nelle braccia di Venere, che diede il nome alla casa
in cui fu trovato; il Meleagro, onde fu detta la casa
in cui era, nella quale pur si trovarono Achille e Deidamia;
Teti che riceve da Vulcano le armi d’Achille;
Dejanira su d’un carro che presenta Ilio figliuol suo
ad Ercole, mentre il Centauro Nesso offre di tragittarla
sul fiume Eveno, e Meleagro vincitore del cinghiale
Calidonio; ambe rinvenute nella casa detta del
Centauro; Castore e Polluce, il Satiro ed Ermafrodito,
Apollo, Saturno, Achille fanciullo immerso nello
Stige, Marte e Venere, Endimione e Diana, Eco e
Narciso, Giove, La Fortuna, Bacco, pitture tutte scoperte
nella preziosissima casa che fu detta di Castore
e Polluce od anche del Questore; Venere che pesca
all’amo; Ercole ed Onfale, grande pittura scoperta
nella Casa di Sirico e i diversi subbietti spiccati all’Iliade,
che si giudicarono fra i dipinti più egregi
per composizione ed esecuzione finora tratti in luce,
che si videro nella Casa d’Omero, detta altrimenti
del Poeta; fra cui pure fu ammirata la bellissima
Venere, che Gell non esitò punto a paragonare per
[378]
la forma a quella sì celebrata de’ Medici, e pel colore
a quella non men famosa di Tiziano.
Fu nel peristilio della medesima casa di Sirico che
si trovò il Sacrificio di Ifigenia, copia del rinomato
quadro che fu il capolavoro di Timanto.
Certo che tutte le opere di pittura in Pompei non
hanno egual merito, nè vantar si ponno di molta
correzione; ma in ricambio quasi sempre vi è l’evidenza,
l’espressione, la verità, vivacità di colorito e
intonazione ad un tempo e la luce ben diffusa e tale
spesso da rischiarare di sè la piccola camera. «Et
quel mouvement dans toutes ces figures, sclama Marc
Monnier, che amo citare, perchè autorità di straniero,
quelle souplesse et quelle vérité!! Rien ne se tord;
mais rien ne pose. Ariane dort réellement, Hercule ivre
s’affaisse, la Danseuse flotte dans l’air comme dans son
élément, le centaure galope sans effort; c’est la réalité
simple (tout le contraire du Réalisme), la nature belle
qu’elle est belle, dans la pleine effusion de sa grâce,
marchant en reine parce quelle est reine et qu’elle
ne saurait marcher autrement. Enfin ces peintres subalternes,
vils barbouilleurs de parois, avaient à defaut
de science et de correction, le genie perdu, l’instinct
de l’art, la spontaneité, la liberté, la vie[334].
La quale splendida testimonianza che ho recata
colle parole del francese scrittore, applicar non si
[379]
vogliono — intendiamoci bene — a quelle principali
composizioni storiche o mitologiche che ho più sopra
annoverate, ma sì a quelle altre sole che superiormente
ho distinte nella classe delle Figure isolate.
Sentimento di quel critico, diviso pure da ben altri e
da me, è che alle più importanti opere di pittura,
alle storie onde si decoravano le pareti più ampie
delle case si ponessero artisti i meglio riputati, e che
invece a quelle isolate, si applicassero altri di minor
levatura.
Queste figure isolate servivano il più spesso a decorare
le pareti minori, quando pure le grandi non
venissero disposte a piccoli quadri, a decorar lacunari
ed agli effetti architettonici: erano il più spesso
Ninfe, Danzatrici, Baccanti, Centauri, Sacerdotesse,
Canefore e Cernofore, Genj alati, Amorini, Fame,
Vittorie e Fauni, Muse e Iddii. Ma non furon sempre
opere di poco momento o di merito secondario; perocchè
talune, che si ebbero conservate, fossero
altrettanti capolavori. Le raccolte infatti che si publicarono
de’ pompeiani dipinti, fra le tante figure
isolate, recarono i disegni di veri piccoli capolavori.
Tale a mo’ d’esempio è la imponente Cerere rinvenuta
nella Casa detta di Castore e Polluce o del Questore,
in cui sembrarono essere di proposito state accumulate
le più leggiadre opere di arte; il Giove che
stava nella casa detta del Naviglio di fronte ad uno dei
lati del tempio della Fortuna, e il quale ha tutta la
[380]
maestà del padre degli Dei. Ma forse la figura isolata più
pregevole, è per generale avviso la Meditazione seduta
su d’una sedia dorata, i lineamenti della quale sono
eseguiti con tanta cura e dotati di tanta espressione,
direbbesi individuale, da essere indotti a credere che
dovesse essere un ritratto. E poichè sono a dire di questo
genere di pittura, che è de’ ritratti, il lettore ricorderà
i due ritratti di Paquio Proculo e di sua moglie,
de’ quali m’ebbi ad intrattenere nel passato capitolo:
se non sono essi da collocarsi fra le migliori opere,
attestano nondimeno della costumanza che si aveva
fin d’allora di farsi ritrarre, oggi divenuta omai una
mania, atteso il buon mercato della fotografia.
Non vogliono poi essere passati sotto silenzio l’Apollo
Musagete, o duce delle Muse e le nove Muse,
isolatamente dipinti in tanti quadri, che si rinvennero
negli scavi nell’anno 1785 nella vicina Civita,
avente ognuna figura i proprj emblemi, e più che
questi, la propria peculiare espressione.
In quanto alla pittura di genere, non voglio dire
si possano vantare tante meraviglie quante se ne
ammirarono in quella istorica, e quel che ne vado a
dire ne fornirà le ragioni. In quella vece vuolsene
segnalare un certo pregio in ciò che a me, come
agli scrittori delle cose pompejane, giovarono alla
interpretazione di importanti cose attinenti l’arti e
i mestieri.
Fin da quando le scuole greche piegarono a decadenza,
[381]
per la smania del nuovo, molti artisti si buttarono
ad una pittura casalinga e di particolari, che
i moderni chiamarono di genere. Là, dove l’arte si ispirava
sempre al grande ed al meraviglioso ed era aliena
per conseguenza dal realismo, l’avvenimento non fece
che sollevare il dispregio e questi artisti si designarono
come pittori di cenci, e noi diremmo da boccali.
Tuttavia sulla mente del popolo que’ dipinti che si
esponevano ad insegna di bottega facevano impressione:
erano richiami influenti e que’ dipinti si ricercarono
a furia da merciai e venditori. Così Pireico
ottenne fama, sapendo dipingere insegne da barbiere e
da sarto; Antifilo, pingendo uno schiavo soffiante nel
fuoco ad una fabbrica di lana; Filisco un’officina da
pittore e Simo il laboratorio d’un follone[335]. Orazio
ci ha poi ricordato ne’ versi, che in altro Capitolo (Anfiteatro)
ho citati, un’insegna gladiatoria e nel capitolo
delle Tabernæ ne ho pur toccato: or ne dirò, poichè
mi cade in taglio, qualche cosuccia ancora.
L’Accademia d’Ercolano publicò ne’ suoi atti una
serie di quadri scoperti fin dal 25 maggio 1755 in
cui sono appunto espressi mercanti e lavoratori in
pieno mercato, forse nel Foro di Pompei, dal quale
appena differenziano i capitelli delle colonne, che in
quel di Pompei son dorici, mentre nella architettura
[382]
de’ quadretti summentovati appajono corintii; perocchè
nel resto tutto vi sia fedelmente riprodotto.
In uno si veggono due mercanti di drappi di lana,
che trattan di loro merce con due avventrici: in altro
è un calzolajo che in ginocchio prova a calzare delle
scarpe a un suo cliente e nel fondo appiccate veggonsi
al muro diverse calzature.
Un altro calzolajo è raffigurato in un altro quadro
e colla bacchetta alla mano con cui misura il piede,
porge un calzaretto a quattro pompejane sedute, di
cui l’una ha in grembo un fanciullo. Buona la composizione,
pessima ne è la esecuzione. Evvi un’altra
pittura, in cui sono due genietti pure calzolai: l’uno ha
nelle mani una forma, l’altro ha il cuojo che si dovrà
adattare su di essa, onde foggiarlo a calzatura. In
un armadietto a due battenti aperti veggonsi scarpe
diverse e presso un vasetto e un bacino contenenti
il colore per dare il lucido alle pelli. Evvi anche il
commerciante di forbici, fibule, spilloni; il vasajo e
il panattiere seduto alla turca sul suo banco.
Parlando della Fullonica, già dissi del dipinto che
vi si trovò nel 1826 e che reca tutto il progresso di
quell’arte de’ gualcherai, di esecuzione assai migliore
delle altre, nè mi vi arresterò di più: invece nelle
pitture di decorazione veggonsi fabbri, genietti alati
con arnesi fabbrili, altri recanti nelle mani quelli del
pistrino e del torchio.
Del pregio de’ paesaggi, che formavano soventissime
[383]
volte il fondo dei dipinti storici più importanti, dissi
più sopra, e noterò meglio ora, che pur frequenti volte
si trovino nei fregi e sotto altri dipinti di figura, riprodotti
animali, come buoi, lupi, pantere, capre ed
uccelli, talvolta condotti con non dubbia abilità.
Ora una breve parola della pittura de’ fiori. Nulla,
scrive Beulé, nulla è più grazioso che le pitture rappresentanti
piccoli genii che figurano il commercio
de’ fiori. La gran tavola coperta di foglie e di fiori,
i panieri che essi portano, che vuotano e riempiono,
le ghirlande sospese, tutto ci richiama Glicera, la bella
fioraia di Sicione che il pittor Pausia amava, e della
quale egli copiava i bei mazzi, tanto sapeva comporli,
disponendovi i colori ed ogni loro gradazione.
Le più leggiadre rappresentazioni in questo genere,
trovansi in quattro comparti decorativi d’una camera
sepolcrale che Santo Bartoli ha disegnati. V’hanno
fanciulli che colgono de’ fiori, ne riempiono i cestelli,
ne caricano le spalle loro, attaccati in equilibrio su
d’un bastone. Il picciolo mercante che va tutto nudo
recando questa serie di ghirlande, è veramente degno
di osservazione.
Scultura.
Veniamo ora alla parte statuaria, seguendo anche
in questo argomento l’egual sistema di trattar delle sue
condizioni generali nel mondo romano, particolareggiando
poi intorno alle opere pompejane.
[384]
Io intendo trattare in proposito non solo delle statue in
marmo, ma ben anco di quelle in bronzo e de’ bassorilievi;
perocchè sieno tutte opere attinenti la scultura;
solo omettendo di quelle ne’ più preziosi metalli, per
averne già toccato alcunchè parlando degli orefici e
delle orificerie in Pompei.
Anche nella statuaria l’Etruria precedette ogni
altra parte d’Italia. Se le sue prime produzioni presentarono
un genere presso che eguale alle produzioni
de’ popoli incolti, presto per altro assunsero
una propria maniera: anzi dai molti saggi recati alla
luce dagli scavi in più località praticati, e di cui
sono arricchiti i nostri musei, si può asserire che
due fossero le maniere, o stili affatto distinti di
disegno. Del primo, dice Winkelmann, esistono ancora
alcune figure e somigliano le statue egiziane,
in quanto che hanno esse pure le braccia pendule
ed aderenti alle anche, ed i piedi posti parallelamente
l’un presso l’altro: il secondo è caratterizzato
dalle esagerazioni dei movimenti e di una ruvidezza
di espressione che gli artisti si sforzarono di imprimere
ai loro personaggi.
Da questa seconda maniera si fa passaggio alla maniera
de’ Greci, di cui gli Etruschi, dopo l’incendio
di Corinto e il saccheggio d’Atene datovi da Silla, che
spinse gli artisti di Grecia in Italia, divennero discepoli
e collaboratori.
Tuttavia i primi Etruschi potevano a buon dritto
[385]
vantarsi d’aver con successo trattato scultura e pittura
fino dai tempi in cui i Greci non avevano che
assai scarsa cognizione delle arti che dipendono dal
disegno: argomento pur questo che avvalora la credenza
dal Mazzoldi espressa nelle sue Origini Italiche,
non abbastanza apprezzate come si dovrebbe, che la
civiltà fosse prima dall’Italia importata alla Grecia,
i Pelasghi appunto e gli Atalanti procedendo dalla
terra nostra.
Plinio ne fa sapere infatti che in Italia venisse eseguita
una statua innanzi che Evandro, mezzo secolo
prima della guerra di Troja, giungendo dalla nativa
Arcadia, sostasse sulle sponde del Tevere e vi fondasse
Pallantea, che ho più sopra ricordato; e ne trasmise
pur la notizia che nel suo tempo si vedevano ancora
a Ceri, una delle dodici principali città dell’Etruria,
affreschi d’una data anteriore alla fondazione di Roma.
Egualmente le pitture del tempio di Giunone, condotte
da Ludio Elota, prima che Roma esistesse, in
Ardea, città del Lazio, capitale dei Rutuli e soggiorno
del re Turno, come raccogliesi dal Lib. VII dell’Eneide,
della freschezza delle quali rimaneva quell’enciclopedico
scrittore maravigliato, non meno che
dell’Atalanta e dell’Elena di Lanuvio, la prima ignuda,
la seconda invece decentemente palliata e spirante timidezza
e candore.
Fondata Roma, Romolo e Numa ricorsero, come
mezzo di civilizzazione, a imporre il culto a quelle
[386]
immagini di numi che Evandro ed Enea avevano recato
in Italia ne’ più remoti tempi, quantunque poi
per crescere loro autorità, li avessero a circondar di
mistero tenendoli gelosamente ascosi agli sguardi profani.
Le prime opere di scultura presso i Romani si
vuole essere state statue di legno o di argilla, raffiguranti
divinità. D’altri personaggi si citano le statue:
di Romolo, cioè, di Giano Gemino, consacrate da Numa,
la prima anzi delle quali coronata dalla Vittoria, fu
poscia collocata sopra una quadriga di bronzo tolta
dalla città di Camerino. Più innanzi il simulacro dell’augure
Accio Nevio e delle due Sibille e le statue
equestri di Orazio Coclite e di Clelia trovasi scritto
che venissero fuse in bronzo in epoca assai prossima
a quella in cui siffatti personaggi avevano vissuto.
Anche nel Foro Boario venne collocata in quei
primi tempi una statua d’Ercole trionfatore; come
più tardi sulla piazza del Comizio venne posta quella
di un legista di Efeso, appellato Ermodoro. Un Turriano,
scultore di Fregela lavorò in rosso una statua
di Giove e fu cinque secoli avanti l’Era Volgare. Un
Apollo di smisurata grandezza fu da Spurio Carvilio,
dopo la sua vittoria contro i Sanniti, fatta fondere in
bronzo, usando all’uopo delle spoglie tolte a’ vinti
nemici.
Non è che dugentottanta anni prima di Cristo, dopo
la sconfitta di Pirro, che a Roma venne offerto lo
spettacolo di una esposizione di molti e pregevoli oggetti
[387]
d’arte, quadri e statue che dall’esercito Romano
erano stati predati in un con ingente quantità d’oro
e d’argento, ed altre preziosità negli accampamenti
del Re epirota, che alla sua volta erano stati da lui
derubati nella Sicilia ai Locri, nel saccheggio dato
al tesoro del loro tempio sacro a Proserpina.
I monumenti che la nazione consacrava ad eternare
i fasti più gloriosi consistevano d’ordinario in
semplici colonne, rado a’ più valorosi capitani concedevasi
l’onoranza di una statua, limitata l’altezza a
tre piedi soltanto, onde designate venivano codeste
statue col nome di tripedaneæ; mentre poi sigillæ dicevansi
quelle più piccole d’oro, d’argento, di bronzo
od avorio, le quali erano per solito d’accuratissimo
lavoro.
Pel contrario nelle case private, i patrizj collocavano
in apposite nicchie le immagini dei loro illustri
maggiori, e se n’era anzi costituito un diritto, solo
concesso a coloro che avessero sostenuto alcuna carica
curule, come il tribunato e la questura, ed erano la
più parte lavorate in cera; talvolta per altro in legno,
in pietra od in metallo. Chi di tal diritto fruiva, poteva
processionalmente siffatte immagini portare nelle
pompe funerali, lo che ognuno si recava a sommo
di onore.
La presa di Siracusa per opera di Marcello e le
conquiste della Macedonia, della Grecia e dell’Asia,
per quella di Paolo Emilio, di Metello e de’ Scipioni,
[388]
dovevano rendere più acuto il desiderio di possedere
oggetti d’arte, comunque non fosse giunto, come
dissi più sopra, a farsene il virtuale apprezzamento
neppur a’ tempi della maggiore coltura, come furono
quelli di Cesare e di Cicerone. Perocchè i trionfatori
tutte le meraviglie dell’arte, di cui i Re macedoni
avevano impreziosito le loro principali città, mandassero
a centinaja di carra a Roma, in un con tante
altre ricchezze; per modo che per centoventitre anni
di seguito non s’avesse bisogno di prelevare imposte
sui cittadini.
Come già narrai, si travasarono dalla Grecia in
Roma, coi capolavori dell’arte, anche i loro artefici, e
poterono così stabilirvi le loro scuole e sistemi e
farli prevalere, che il Senato con apposito decreto
mandò multarsi gli scultori che si fossero allora
allontanati dalle dottrine di essi, la eccellenza delle
quali veniva tanto splendidamente attestata da sì
egregie ed immortali opere.
Le statue, che dapprincipio avevano giovato soltanto
ad illustrare i trionfi, vennero pertanto adoperate ben
presto a decorar piazze e monumenti e quindi a crescere
il fasto delle abitazioni private. Silla, Lucullo,
Ortensio e il cliente di lui Cajo Verre, diedero il primo
esempio: dietro di essi vennero tutti i più facoltosi
degli ultimi tempi della Republica, seguiti pure da
tutti quelli delle colonie, come rimangono ad attestarcelo
tanti capolavori, de’ quali più avanti dirò,
rinvenuti in Ercolano e Pompei.
[389]
Di tal guisa gli artisti greci venuti a Roma vi trovarono
molto lavoro e fortuna. Si citano fra essi un
Pasitele, che eseguì una statua nel tempio di Giove
e n’ebbe il diritto di cittadinanza; i suoi allievi Colote
e Stefanio; Arcesilao, che scolpì la Venere genitrice
per Cesare, il qual si vantava da lei discendere;
Apollonio e Glicone, autore dell’Ercole Farnese, condotti
a Roma da Pompeo; Alcamene e Cleomene, Poside
e Menelao, Decio e Damasippo, e sotto Augusto
Menofante e Lisia, Nicolao e Critone e l’ateniese Diogene,
che condusse le statue che si collocarono sul
frontone del Pantheon di Agrippa. Augusto stesso
fece erigere sotto il portico del suo Foro le statue
degli oratori e de’ trionfatori più illustri, e in Campidoglio
si vede tuttavia una statua di questo imperatore
con un rostro di nave a’ suoi piedi in memoria
di sua vittoria sovra Sesto Pompeo.
Ma ho ricordato testè Cajo Verre. Or come si può,
anche sommariamente, come faccio io qui stretto
dall’economia dell’opera, ritessere la storia dell’arti,
o piuttosto compendiarla, senza ricordare le gesta
infami di quest’uomo, contro cui si scagliarono le
folgori della eloquenza del sommo Oratore?
Cajo Licinio Verre, senatore, era stato proquestore
dapprima in Cilicia, poscia pretore per tre anni in
Sicilia, dove, non pago dell’ordinaria rapacità de’ suoi
colleghi, trattò la Sicilia più che paese di conquista.
Abusando del suo potere, fece man bassa su tutte le
[390]
preziosità publiche e private. Quadri e statue de’ più
celebri artisti attiravano specialmente la sua cupidigia,
nè ristava davanti alcuna legge divina ed umana
per venirne in possesso. Cicerone, difendendo contro
lui le ragioni de’ Siciliani, aveva potuto senza iperboli
esclamare: «Dove sono le ricchezze strappate a
forza a tanti popoli soggetti e ridotti omai alla miseria?
Potete voi chiederlo, o Romani, quando vedete
Atene, Pergamo, Mileto, l’Asia, la Grecia inghiottite nei
palagi di alcuni spogliatori impuniti?» Minacciato per
ciò d’accusa capitale, egli aveva prese le sue cautele,
nè restava punto dal dichiararle svergognatamente a’
suoi amici, dicendo: io feci del prodotto del triennio
che durò la mia pretura tre parti: una per il mio
difensore, una per i miei giudici e la più grossa
per me.
Il suo difensore fu Ortensio, che oltre essere rinomatissimo
oratore, era appassionatissimo delle opere
di arte, vantandosi fra gli altri di possedere il dipinto
degli Argonauti di Cidia, che aveva costato centoquarantaquattro
mila sesterzi, che sarebbero lire ventottomila
delle nostre. Cicerone dice di Verre: che in lui
la cupidigia d’artistiche cose era un furore, un delirio,
una malattia, dacchè in tutta la Sicilia non esistesse
un vaso d’argento o di bronzo, fosse di Delo o
di Corinto, non una pietra incisa, non un lavoro di
oro, d’avorio, di marmo, non un quadro prezioso, non
un arazzo, che quell’avido governatore non volesse
[391]
vedere co’ proprj occhi, per trattenere poi quanto gli
sembrava opportuno ad arricchire la di lui raccolta.
Basti per tutti il seguente aneddoto. Antioco, figlio del
re di Siria, volendo sollecitare l’amicizia del Senato
romano, viaggiava alla volta della grande città, seco recando
un ricchissimo candelabro, per donarlo al tempio
di Giove Capitolino. Transitando per la Sicilia, ricambiando
Verre d’una cena, questi vedute le mille preziosità
che aveva, sotto pretesto di mostrarle a’ suoi
orefici, se le faceva col candelabro portar a casa. Vi consentiva
Antioco; ma quando si trattò della restituzione,
il ladro pretore tanto insistè per aver tutto in dono,
che alla perfine, a lasciargli ogni cosa si decise,
purchè almeno gli rendesse il candelabro destinato al
popolo romano. Verre ricorse dapprima a pretesti per
ricusargli anche questo; ma poi impose termine a
ogni contesa, intimando recisamente al re che sgombrasse
avanti notte dalla provincia.
Chiederà il lettore se tanto ladro venisse poi condannato.
Risponderò che non fossero questi soltanto
i gravami contro lui formulati: altri furti e depredamenti
d’ogni genere da lui commessi in Acaja,
in Cilicia, in Panfilia, in Asia ed in Roma; la venduta
giustizia, le violenze, gli stupri, l’oltraggiata
cittadinanza; sì che li potesse così Cicerone riassumere
nella Verrina De Frumento: Omnia vitia, quæ
possunt in homine perdito nefarioque esse, reprehendo,
nullum esse dico indicium libidinis, sceleris, audaciæ,
[392]
quod non in unius istius vita perspicere possitis[336].
Ebbene, Cicerone appena ne potè assumere l’accusa
protetto da Pompeo; ma il fece con tanto vigore
fin dalla prima arringa, che spaventatone Ortensio,
disperando dell’esito del suo patrocinio, ne
dimise tosto il pensiero, e Verre stesso persuaso,
andò spontaneamente in esiglio, dove passò la trista
vecchiezza e morì proscritto da’ Triumviri, come ce
lo lasciarono ricordato Seneca e Lattanzio[337], condannato
però a restituire a’ Siciliani quarantacinque
milioni di sesterzi, dei cento che essi avevano addomandato
e che forse non rappresentavano tutto il
danno della sua rapina.
Le altre orazioni che contro Verre si hanno di
Cicerone, non furono recitate, attesa la contumacia
dell’accusato; ma corsero allora manoscritte per le
mani di tutti e a’ posteri rimasero monumento, come
di eloquenza, così della condotta de’ magistrati romani,
che nella propria Verre compendiava.
Toccai più sopra di Augusto, come l’arti favorisse
e gli artisti, e da Tito Livio infatti egli venne chiamato
per antonomasia riedificatore dei templi, ed a
[393]
buon diritto però potè morendo dire di sè: Trovai
Roma fabbricata di mattoni e la lascio fabbricata di
marmo.
Fu sotto di lui che Dioscoride portò la glittica,
od incisione in pietre dure, al più perfetto suo grado
e si levano a cielo il suo Perseo, la Io, il Mercurio
Coriforo, ossia portante un capro, e il ritratto dell’oratore
Demostene inciso su d’un’ametista. Nello stesso
genere furono pure lodatissimi Eutichio figliuolo di
Dioscoride, Solone, Aulo e chi sa quanti altri, se
i Musei tutti serbano i più squisiti cammei di quel
tempo e se dagli scavi di Pompei se ne tolsero di
preziosissimi, tali da formare la meraviglia di chi li
vede adesso nel Museo Nazionale di Napoli.
E poichè m’avvenne di ricordare la glittica o glittografia,
come altri la chiama, nel difetto di trattati antichi
intorno a quest’arte, — perocchè non se n’abbiano
che pochi cenni nelle opere di Plinio, — parmi potersi
ritenere che avessero a un dipresso in antico i metodi
che si han pur di presente in Italia, dove a
preferenza fu sempre coltivata e portata a perfezione.
Ad intaccar la pietra, si usava dagli artefici romani
una girella che chiamavano ferrum obtusum, e la
cannella da forare appellata da Plinio terebra, giovandosi
del naxium, specie di grès di Levante, poi
dello schisto d’Armenia, a cui sostituirono da ultimo
lo smirris, che noi diremmo smeriglio. Credesi nota
agli antichi la punta di diamante come strumento
[394]
attissimo all’incisione. Delle pietre dure incise valevansi
principalmente a farne anelli e sigilli; onde,
litoglifi dicevansi gli artisti intagliatori di pietre, e
dattilioglifi gli intagliatori di anelli, usandosi anche
nello stesso significato le parole più prettamente latine
sculptores e cavatores.
E qui chiudo la parentesi, che parvemi necessaria
a dare una qualunque idea di questa particolare arte
del disegno e ritorno al primo subbietto.
Del tempo di Tiberio, ha poco a registrare la storia
dell’arte, se non è la statua di quel Cesare che fu
ritrovata in Carpi e una effigie colossale ricordata
da Flegone, liberto d’Adriano, nel suo Trattato delle
cose meravigliose. Nè di meglio del tempo di Caligola
e di Claudio; comunque del primo si sappia ch’ei
chiedesse agli artisti invenzioni straordinarie e prodigiose:
di quello di Nerone varrebbe invece intrattenerci,
se di lui stesso ebbe a scrivere Svetonio: pingendi
fingendique, non mediocre habuit studium[338]; ciò
che inoltre gioverebbe a provare che la professione
dell’Arti Belle, non fosse più, come per lo addietro,
cotanto disprezzata.
A lui è imputato d’aver dato l’incendio a parecchi
quartieri della città; ma lo si pretende escusare, dicendo
averne avuto il pensiero per distruggere tante indecenti
[395]
catapecchie, onde in luogo di esse sorgessero
palagi, si ampliassero le vie, e potesse meglio allinearne
le mura e imporre alla città il proprio nome,
appellandola Neropoli. E vi fabbricò infatti la Casa
di Oro, che dissi più sopra quant’area occupasse e
vi fe’ portare statue e quadri de’ più famosi autori,
arredi d’oro, d’argento, d’avorio e madreperla, e collocarvi
quel colosso, di cui pure più sopra accennai,
eseguitovi da Zenodoro, alto cento piedi, nel cui lavoro
impiegò l’artefice ben dieci anni e il cui valore
fu di quaranta milioni di sesterzi, a dir come nove
milioni di lire italiane.
Sotto gli imperatori di casa Flavia, Vespasiano e
Tito, dai quali veduto abbiamo eretto l’Anfiteatro, detto
il Colosseo, non si sa che importanti opere scultorie
venissero in Italia condotte, dove si eccettuino una
bella statua rappresentante l’imperatore Tito ed una
bella testa colossale del medesimo imperatore, che
Winkelmann ricorda.
È anche a quest’epoca appartenente di certo, secondo
l’opinione d’Ennio Quirino Visconti, l’incomparabile
gruppo del Laocoonte, degli artisti rodii
Agesandro, Atenodoro e Polidoro, che Plinio non esitò
a dichiarare Opus omnibus et picturæ et statuariæ præponendum[339].
[396]
Viste così le principali cose di scultura pertinenti
all’epoca imperiale infino ai giorni del cataclisma
vesuviano, mi conviene ora completarne il discorso
colle opere scoperte in Ercolano e in Pompei.
Le più grandi si rinvennero in Ercolano: tali la
statua equestre in marmo di Nonio Balbo e quella
del figliuol suo, che ne fiancheggiavano la basilica
e la importanza delle quali opere lasciò indovinare
l’importanza altresì de’ personaggi che rappresentavano;
onde ne dolse che nè la storia, nè gli
scavi abbiano finora portato alcun lume su di essi;
tali il magnifico cavallo in bronzo, rinvenuto nel
teatro e già spettante ad una quadriga, che nei
primi scavi colà praticati venne messa sventuratamente
a pezzi, e ricomposta poi, forma oggidì una
delle più interessanti e preziose opere del Museo di
Napoli in un con alcune figure del bassorilievo
del carro, con un Bacco, otto statue consolari, quelle
di Nerone, Claudio Druso e sua moglie Antonia, un
ministro di sagrifici in bronzo e due teste di cavallo,
e una statua di Vespasiano, e due di bronzo rappresentanti
Augusto e Claudio Druso. Nello stesso Museo di
Napoli, sono pure le statue di sei celebri danzatrici,
trovate nella casa detta dei Papiri[340], il magnifico
[397]
Fauno ebbro, in bronzo, ch’era a capo della piscina
nello xisto di essa casa, i busti di Claudio Marcello,
di Saffo, di Speusippo, Archita, Epicuro, Platone,
Eraclito, Democrito, Scipione l’Africano, Silla, Lepido,
Augusto, Livia, Cajo e Lucio Cesare, Agrippina, Caligola,
Seneca, Tolomeo Filadelfo, Tolomeo Filometore,
Tolomeo IX, Tolomeo Apione, e Tolomeo Sotero
I; di due Berenici e di due altri personaggi
sconosciuti. Una statua e cinque busti in bronzo
si trovarono nella stessa casa, su l’un de’ quali si
lesse il nome dell’artefice: Apollonio figlio di Archia
ateniese.
Circa alle opere di statuaria rinvenute in Pompei,
esse sono in numero minore che non ad Ercolano;
ma non sono meno pregevoli. Io ne ricorderò taluna
e saranno le principali.
Nel tempio d’Iside fu rinvenuta una bella statua
in marmo rappresentante Bacco, che fu detto, forse
dal luogo in cui fu trovato, Isiaco. Essa appare coronata
di pampini la testa, e colla destra alzata, cui
tien rivolto affettuosamente lo sguardo, ci fa supporre
che stringesse un grappolo. Al piede sta una pantera,
e sulla base leggesi la iscrizione che ho già
riferita parlando di questo tempio[341], dove ho pur
ricordata la statua di Venere Anadiomene coll’ombilico
dorato. Nel Pantheon, o piuttosto, come più
[398]
rettamente fu giudicato, tempio d’Augusto, nel 1821
si trovarono quelle due statue che già ricordai, le quali
si ritennero rappresentare l’una Livia sacerdotessa
d’Augusto, l’altra Druso: la prima sopratutto è una
delle opere di scultura più rimarchevoli che vi si
scoprissero. Ha essa una tale maestà che a chi la riguarda
incute reverenza.
Ma siccome a suo luogo ho già ogni volta ricordate
le opere di plastica; così de’ marmi, altro non ricorderò
qui che il bassorilievo in marmo di Luni, o come direbbesi
oggi di Carrara, raffigurante una biga, su cui
sta un africano, e alla quale sono attelati due corridori
preceduti da un araldo, come si usava comparire
in publico da’ magistrati. La purezza dei disegno
e della esecuzione rivelano l’artefice greco.
Dirò meglio de’ bronzi.
Leggiadra è la statuetta trovata in una nicchia
innalzata nel mezzo di una stanza, rappresentante
Apollo, e sì ben conservata, che neppure appajano
danneggiate le corde argentee della lira. Taluni, all’acconciamento
alquanto muliebre de’ capelli, alla
delicatezza de’ lineamenti del volto, ed all’espansione
del bacino, vollero invece ravvisarvi un Ermafrodito.
Una Diana vendicatrice, sarebbe la più armonica
figura, se non vi disdicessero certe alacce mal attaccate:
più lodevole e prezioso lavoro è il gruppo di
Bacco ed Ampelo, dove gli occhi sono intarsiati in
argento.
[399]
Ma tre statuette vi sono che vengono considerate
come altrettanti capolavori e i migliori che furono
scavati in Pompei: l’una rappresentante il Fauno
danzante; l’altra Narciso; la terza un Sileno. Il loro
merito si costituisce principalmente dalla maravigliosa
e caratteristica espressione, dalla perfetta concordanza
di tutte le parti, dalla irreprensibile finezza d’ogni
particolare, da una esecuzione insomma completa del
bello ideale.
Il Fauno ritrovato nella casa, cui per la propria
eccellenza fu imposto il suo nome ed era nel mezzo
dell’impluvium, ha il capo incoronato di foglie di
pino, le braccia alzate, le spalle alquanto rigettate
all’indietro, ogni muscolo in movimento e il corpo
tutto in atto di chi sta per muovere alla danza. Non
può essere ammirato il minuto lavoro del metallo,
se non che vedendolo: l’epidermide è così resa morbidamente,
da vedervi sotto la vita: opera certo
codesta della più perfetta fusione, che non ebbe d’uopo
per bave o altre scabrosità, di lima o di cesello
dell’artefice.
Fa riscontro al Fauno, il Narciso, statuetta trovata
in una povera casuccia, ed è d’una grazia tutta particolare
e nell’atteggiamento scorgesi come stia in
ascolto della Ninfa Eco. La sua testa piega da una
parte, come appunto farebbe chi sta ascoltando voce
che giunga da lontano, teso ha l’orecchio, e il dito
rivolto verso dove la voce muove. L’espressione non
poteva essere più felicemente côlta.
[400]
Il Sileno finalmente, più recentemente trovato dal
comm. Fioretti, è ancora più perfetto, se è possibile;
quantunque pel soggetto si mostri rattrappito e curvo.
Era pur desso decoro d’una fonte: ciò che ne fa ragionevolmente
supporre che dunque nell’interno delle
camere vi fossero ancora maggiori preziosità di quelle
ritrovate, se così all’aperto si tenevano siffatte maraviglie.
Molte opere peraltro della statuaria pompejana accusano
la decadenza dell’arte, come infatti al tempo
della catastrofe della città l’arte romana se ne andava
degenerando nel barocco. E fu in questo tempo
che alle statue prevalsero i busti, l’abbondanza
de’ quali segna appunto il nuovo periodo della decadenza
cui si veggono spesso aggiunte le spalle,
parte del torace e talvolta le mani e qualche panneggiamento.
Peccano questi assai sovente d’esagerazione,
ma in ricambio conservano l’individualità.
Sempre a’ giorni del decadimento si fecero busti di
più marmi e colori, l’una parte nell’altra innestando,
massime gli occhi e le vesti.

Marco Bruto. Vol. II. Cap. XVIII. Belle Arti.
Per completare quanto è attinente alla scultura
nel suo più esteso significato, dovrei dire delle gemme.
Qualche cenno ne ho fatto non ha guari più
sopra, parlando della glittica, e per non entrare in
maggiori particolari, ai quali assai si presterebbe il
Museo Nazionale di Napoli, per quanti oggetti si raccolsero
negli scavi d’Ercolano e Pompei, mi basti riassumerne
[401]
in concetto generale il discorso; che cioè
anche in questo ramo dell’arte i Romani furono
dapprima imitatori de’ Greci, adottandone i soggetti
e desumendoli da fatti patrizii, sempre però con
espressione allegorica. Ho già pur detto che in seguito,
nell’epoca del risorgimento, Italia predominò
tutte le altre nazioni nella perfezione di quest’arte.
Impiegavasi questa principalmente nel lavoro di anelli
e sigilli, de’ quali, come dissi in questa mia opera,
usavasi moltissimo e però di pompejani se ne hanno
molti: e la glittica poi conta inoltre fra’ suoi capolavori
una maravigliosa coppa nel Museo napolitano
summentovato.

Gneo Pompeo. Vol. II Cap. XVIII. Belle Arti.
Finchè si provò allora la influenza greca, l’arte
romana grandeggiò; mano mano che scemava, amenenciva
contemporaneamente di sua degnità, e, abbandonata
a sè, ricadde nel fare pesante, secco e
freddo.
Così ritengonsi di greci artefici i musaici, ai quali
ho riserbato le ultime parole in questo capitolo dell’Arti,
e dei quali Pompei ne largì di superbi, anzi
il più superbo che si conti fra quanti si hanno dell’antichità,
nella Battaglia d’Arbela o di Isso, come
dovrebbesi per mio avviso più propriamente dire,
ed a cui consacrerò peculiare discorso.
Ma prima si conceda che rapidi cenni io fornisca
intorno a quest’arte.
Ne derivano la denominazione da Musa; quasi il
[402]
suo lavoro ingegnoso fosse invenzione ispirata dalle
figlie di Mnemosine, o forse perchè se ne decorasse
dapprima un tempio delle Muse. Ciò che più importa
sapere si è com’essa unicamente consista nell’accozzamento
di pietruzze, o pezzetti di marmo, di
silice, di materie vetrificate e colorate, adattate con
istucco o mastice sopra stucco e levigandone la superficie.
Si chiamò dapprima pavimentum barbaricum,
quando del musaico si valse per coprire aree alle quali
si volle togliere umidità. Poi si disposero a disegni
semplici, come a quadrelli di scacchiere, onde si
venne al tesselatum, che era formato di pietre riquadrate.
Progredendo l’artificio, ne seguì la specie del
sectile, formato di figure regolari combinate insieme,
che è quel lavoro che noi chiamiamo a commesso od
a compartimento. Poi con frammenti orizzontali di
forme diverse si giunse a piegare l’artificio a tutte
le idee, capricci e disegni, come greche, festoni, ghirigori,
ed a tutto quanto insomma costituisce ciò
che chiamavasi opus vermiculatum, come si trova ricordato
dal verso di Lucilio:
Arte pavimento, atque emblemata vermiculato
E qui piacemi avvertire come tutto questo processo
non abbiasi a confondere con quello che dicevasi
opus signinum, nome dato ad una peculiare sorta di
materiale adoperato pure a far pavimenti, consistente
in tegole poste in minuzzoli e mescolate con cemento,
quindi ridotte in una sostanza solida colla mazzeranga.
[403]
Ebbero questi lavori il qualificativo di signini,
dalla città di Signia, ora Segni, famosa per la fabbricazione
delle tegole e che prima introdusse questo
genere di pavimentazione.
Tutti questi primitivi saggi non erano ancora il
musaicum propriamente detto, ma quel che i Greci
chiamavano litostrato; per giungere al musivum opus,
che rappresenta oggetti d’ogni natura, emblemata,
non bastavano per avventura i marmi e ciottoli:
convenne fabbricare de’ piccoli cubi di cristalli artifiziali
colorati. Tornò facile il connettere le asarota,
ossia musaici rappresentanti ossa e reliquie di banchetto,
o un pavimento scopato, che con tanta naturalezza
fu imitato, da ingannare chiunque.
Così, avanti ogni altro paese, in Grecia si spiegò il
lusso de’ pavimenti e, prima di ogni altra città, presso
gli effeminati sovrani di Pergamo. Citansi di poi i musaici
del secondo piano della nave di Gerone II,
che in tanti quadretti di meravigliosa esecuzione
rappresentava i fatti principali dell’Iliade, tutti condotti
a musaico; quindi i lavori eguali del magnifico
palazzo in Atene di Demetrio Falereo.
È probabile che similmente si lavorasse a Roma
coll’introdursi dell’arte greca; e quanto si rinvenne
in Pompei potrebbe essere irrecusabile prova, se già
noi non sapessimo come in questa città usi e costumanze
vi fossero eziandio speciali e dedotti da Grecia,
e come di colà vi si rendessero agevolmente
[404]
artisti. Tuttavia dal seguente passo di Plinio, pare che
ai giorni di Tito imperatore, ne’ quali Ercolano e
Pompei toccarono l’estrema rovina, questa del musaico
fosse nuova importazione, e che appena facesse
capolino in Roma verso il tempo di Vespasiano.
Plinio adunque, dopo aver detto che i terrazzi
grecanici a musaico vennero da’ Romani adottati al
tempo di Silla e citato ad esempio il tempio della
Fortuna a Preneste, dove quel dittatore vi fece fare
il pavimento con piccole pietruzze; così sostiene che
l’introduzione de’ pavimenti di musaico nelle camere
con pezzetti di vetro fosse affatto recente: Pulsa
deinde ex humo pavimenta in cameras transiere, e
vitro: novitium et inventum. Agrippa certe in Thermis,
quas Romæ fecit, figlinum opus encausto pinxit: in reliquis
albaria adornavit: non dubio vitreas facturus
cameras, si prius inventum id fuisset, aut a parietibus
scenæ, ut diximus, Scauri pervenisset in cameras[342].
Checchè ne sia, se recente consideravasi a’ tempi
di Plinio il Vecchio l’introduzione in Italia del musaico,
[405]
questo si presenta nondimeno fiorentissimo d’un
tratto e grande nelle opere pompejane.
Gli scavi offrirono saggi appartenenti a tutte le
epoche di progresso di quest’arte, e in ognuno si
manifesta una prodigiosa fecondità d’invenzione negli
artisti della Magna Grecia, e chi si assunse di
riprodurli con disegni ne ammanì interessantissimi
volumi.
Non è possibile dunque occuparmene qui per ricordarli
tutti; solo mi restringerò a dire de’ più
importanti.
Un musaico quadrato di circa cinque piedi e tre
pollici, fu rinvenuto nella casa detta di Pane, rappresentante
un genio alato che a cavalcion d’un leone
si inebbria. L’espressione del fanciullo è mirabile,
come mirabile è la mossa del leone: la cornice a
foglie, a frutti ed a maschere teatrali compiono la
perfetta esecuzione.
Un altro di forma circolare, di sette piedi di diametro,
trovato nella casa appellata del Centauro, rappresenta
allegoricamente la Forza domata dall’Amore,
in un leone ricinto da alati amori che gli intrecciano
di fiori la fulva chioma. Nella parte superiore del musaico
vedesi una sacerdotessa che fa una libazione;
nella parte inferiore stanno l’una di fronte all’altra
due donne sedute. Se non il disegno, che lascerebbe
desiderj, l’esecuzione e l’effetto de’ colori sono sorprendenti.
[406]
Nella casa detta di Omero, nel tablinum si trovò
un musaico istoriato raffigurante un choragium, o
luogo in cui si facevano le prove teatrali, come già
sa il lettore, per quel che ne ho detto nei capitoli
intorno ai Teatri. Sono diverse figure in piedi, attori
che stanno intorno al corago, o direttore, che li sta
istruendo, il manoscritto della commedia alla mano.
Un tibicine soffia nelle tibie, come accompagnando
la recitazione del corago, perocchè paja veramente
che ogni teatrale rappresentazione fosse dal suon
delle tibie secondata. Vi hanno maschere disposte
per gli attori e uno sfondo pure interessante: il
tutto condotto con una rara maestria.
Nella stessa casa detta di Omero, sulla soglia si
vide un musaico rappresentante un cane incatenato
colla leggenda CAVE CANEM. Si raccoglie da tal lavoro
artistico come all’usanza comune presso i Latini
di tenere alla porta della casa un vero cane, quasi
a custodia di essa, si fosse sostituito in tempi più
civili una pittura del cane, eseguita in musaico e
collocata, varcato appena il limitare, sul suolo colla
suddetta leggenda; o altre parole, composte pure in
musaico, bastassero, come SALVE, giusta quanto si
vede nella casa delle Vestali, o SALVE LVCRV, ecc.
consuetudine quest’ultima che vediamo copiata in
molte case signorili de’ nostri giorni.
Ma eccoci alla casa del Fauno. In essa, ove già
trovammo sorgere dal mezzo dell’impluvium la stupenda
[407]
statuetta in bronzo che forma altra delle
opere più preziose degli scavi, si rinveniva altresì
nel tablinum un musaico quadrato incorniciato da
una greca assai corretta e dipinta a svariati colori,
nel cui mezzo è un leone, che in uno stupendo scorcio,
sembra stia per islanciarsi, così da incutere spavento
a chi lo guarda. È a rimpiangere che sia assai
danneggiato.
Nella stessa casa v’ha inoltre la maraviglia di
quest’arte del musaico, la giustamente famosa Battaglia
d’Arbela, o di Isso, o il passaggio del Granico
che si voglia ritenere, che per grandezza, invenzione
ed esecuzione sorpassa quanti musaici si conoscano
finora. Mette conto che qui ne dica più largamente
che non degli altri.
Anzitutto noto che esso misura un’altezza di otto
piedi e mezzo, e una larghezza di sedici piedi e due
pollici, senza calcolare il fregio, che a mo’ di cornice
circonda il soggetto; onde hassi a ragione a proclamarlo
per il più grande musaico conosciuto.
Ora eccone la descrizione.
A manca di chi riguarda, che è anche la parte
più guasta, vedesi su d’un corsiero un giovane guerriero,
che tosto distinguesi per il posto concessogli
di fronte al capo dell’esercito nemico, come il capo
esso pure dell’una delle armate. Ha la lorica di
finissimo lavoro al petto e la purpurea clamide agli
omeri ondeggiante. Ha scoperto il capo, perocchè il
[408]
cimiero gli sia nel calor della mischia caduto, e
stringe nella destra la lancia, che sembra aver egli
appena ritratta dal fianco d’un guerriero, cui è
caduto sotto il cavallo ferito di strale che gli rimase
confitto. L’agonia di questo infelice guerriero è
espressa con toccante verità. Dietro di lui ve n’ha
un altro, che comunque ei pur vulnerato, combatte
tuttavia: ambi formanti intoppo a suntuosa quadriga,
i cui cavalli veggonsi disordinati, ma che indubbiamente
traggono altro importante personaggio, il qual
rivolge l’attenzione sui due feriti e intima a’ suoi di
venir loro in aiuto; mentre un soldato tiengli presso
un corsiero in resta, su cui potrà quel personaggio
montare appena ei ne abbia l’opportunità e pigliar
diversa parte all’azione. Lo scorcio di questo cavallo
è d’una prodigiosa bellezza. Tutto il resto dello
spazio a destra non è che una scena di desolazione e
scompiglio, comunque una selva di picche accenni
che l’impeto de’ combattenti da ambe le parti prosegue.
Quanti studiarono la composizione di questo musaico,
ne inferirono che le assise de’ guerrieri vinti,
come la forma della quadriga, esser non possano che
d’un esercito persiano, avendo tutti la tiara, propria
di questo popolo, come si vede in altri antichi
monumenti, e più ancora si distinguano per Persiani
ai grifi ricamati sopra le anassiridi, o calzoni come
essi portano, e sopra le selle.
[409]
Se dunque il guerriero vittorioso e feritore vestito
alla greca, per la somiglianza al tipo assegnatogli
da statue e medaglie è Alessandro il Grande: il capo
de’ Persiani non può essere allora di necessità che
Dario, perchè avente la tiara diritta, che solo aveva
diritto il re di così portare[343]; com’egli solo la candice,
o mantello di porpora, e la tunica listata di
bianco[344] ed egli solo l’arco di sì straordinaria grandezza,
ond’ebbero que’ della sua dinastia il nomignolo
di Cojanidi, cioè arcieri.
Constatati i due capi principali degli eserciti nel
musaico raffigurati, nelle persone dei due re, Alessandro
e Dario, il soggetto allora deve rappresentare
la Battaglia di Isso, non il passaggio del Granico, nè
il combattimento di Arbela. Imperocchè il primo fu
operato in estate; i Persiani in esso si servirono di
carri falcati, che qui non si veggono, nè i due re si
trovarono a fronte, e nulla poi indichi l’esistenza di
un fiume, ciò che dall’artista non si sarebbe negletto
di riprodurre a segnalare quel fatto, s’egli avesse
inteso d’esprimere il passaggio del Granico. Egualmente
la battaglia di Arbela fu combattuta ai primi
di ottobre; v’ebbero pure carri falcati ed Alessandro
incontro a Dario non si valse della lancia,
come vedesi nel mosaico, ma dell’arco con cui uccise
[410]
l’auriga del re. Ora l’albero, che qui si vede
tutto privo di foglie, esclude inoltre che non si potesse
essere nè in estate, nè in ottobre, mentre in
Assiria tutto un tal mese gli alberi serbino intatto
l’onore delle frondi; ma nel verno, venendo anche
da Plutarco ricordato che la battaglia di Isso fosse
combattuta in dicembre, quando le piante dovevano
essere, come nel musaico, prive di foglie. Diodoro
Siculo e Quinto Curzio narrano per di più che a tal
battaglia assistessero i dorifori, o guerrieri armati
di lance, scelti per la guardia del re fra i dieci mila
immortali, coi loro abiti ricamati d’oro e coi loro
monili, e qui li vediamo appunto.
Tutte queste particolarità si raccolgono dai Cenni
publicati dal dotto cav. Bernardo Quaranta[345], ravvicinandovi
altresì i particolari storici che spiegano
ognor meglio la composizione del musaico.
Dario tentò dapprima di decidere il combattimento
d’Isso con l’ajuto della cavalleria; e già i Macedoni
si vedevano accerchiati, allorquando Alessandro chiamò
a sè Parmenione con la cavalleria tessala. Allora
la mischia divenne terribile: Alessandro, scorto da
lunge il re di Persia che incoraggiava i suoi dall’alto
del suo carro ed alla testa della sua cavalleria,
combatte egli come semplice soldato, per penetrare
fino a colui che riguardava come suo nemico
[411]
personale e sperava la gloria di ucciderlo di sua
mano. Ma ecco che offresi una scena sublime di
coraggio e di devozione. Osoatre, fratello del re di
Persia, vedendo il Macedone ostinato a cogliere Dario,
spinge il suo cavallo dinnanzi la reale quadriga
e trascina sopra tal punto la cavalleria scelta che
egli comanda: ivi segue una spaventevole carnificina;
ivi mordono la polve Atiziete e Reomitrete e Sabacete,
Alessandro stesso vi è ferito nella coscia. Finalmente
Dario prende la fuga, abbandonando la candice e l’arco
reale.
Io plaudo e convengo pertanto col dotto illustratore,
credendo sia qui veramente trattata la Battaglia
d’Isso, e non altro combattimento d’Alessandro il
Grande.
Tutto poi, per quanto riguarda esecuzione, è in
questo musaico stupendamente trattato. Il guerriero
che spira, cogli intestini lacerati, è di una verità
insuperabile: i cavalli non potrebbero essere più belli
e animati. Correzione di disegno, espressione di teste,
movenza di figure, disposizione di gruppi, sapienza
di scorci, colorito ed ombre, tutto vi è con una incredibile
superiorità trattato.
«Or bene, conchiude un illustratore di questa insuperata
opera, tutte siffatte bellezze non sono che
quelle d’una copia: quei vivi lumi sono soltanto riflessi,
perocchè il musaico fu imitato certamente da
un quadro. Che dobbiamo dunque pensare dell’originale?
[412]
A chi attribuirlo? A Nicia, a Protogene, ad
Eufranore, che dipinsero Alessandro? o piuttosto a
quel Filosseno di Eretria, discepolo di Nicomaco, la
pittura del quale, superiore a tutte le altre, a detta
di Plinio, e fatta pel re Cassandro, rappresentava il
combattimento di Alessandro e di Dario? Non si
andrebbe per avventura più d’accosto al verisimile,
pensando al divo Apelle stesso, che accompagnò
Alessandro nella sua spedizione, e che solo ottenne
in seguito il dritto di pingere il suo ritratto, come
Lisippo quello si ebbe di gittarlo in bronzo, e Pergotele
di scolpirlo sopra pietre preziose.»
Dopo ciò, mi trovo in debito di avvertire che il
disegno che ho procurato per questa edizione del rinomatissimo
musaico, appare completato dal lato sinistro, — che,
come ho già avvertito, fu non so dire se dall’ultimo
cataclisma toccato a Pompei, o dal precedente,
o fors’anco dall’incuria di chi lo sbarazzò dalle rovine,
come or si vede al Museo Nazionale, guasto, — per
opera del ch. pittore napolitano Maldarelli padre,
da un acquarello del quale, fornitomi dal mio eccellente
amico Adolfo Doria, l’ho fatto ricavare perchè
il lettore avesse un’idea esatta della maravigliosa
composizione.
Non tenni conto più sopra, onde non interrompere
il corso della storia dell’arti, delle botteghe o studj
di scultura, che emersero dagli scavi di Pompei: trovi
qui il cenno di essi il proprio posto.
[413]
Nell’uscire dalla nuova Fullonica, e discosto di
poco dalla medesima, designata dal N. 5, fu scoperto
uno studio di scultura, riconosciutosi tale dalla esistenza
di più un blocco di marmo, già digrossato
e abozzato, e diversi arnesi atti appunto a lavorare
il marmo e condurre oggetti d’arte.
Ma uno studio di scultura, anzi tutta una dimora,
più interessante all’epoca di sua scoperta, che fu
verso la fine del passato secolo (1795-98), perocchè
adesso lo si ravvisi nel più deplorevole stato di abbandono
e di rovina, sorgeva nella casa presso il
tempio di Giove e di Giunone, nella via di Stabia.
Ivi pure, nell’atrio della casa, si raccolsero statue
appena abozzate, talune presso ad essere compite,
elegantissime anfore di bronzo, blocchi di marmo,
fra i quali uno appena segato colla sega vicina ed
altri utensili artistici. Vi si trovò pure un orologio
solare, un uovo di marmo da collocarsi nel pollajo, per
correggere la chiocciola onde non rompa i suoi, un
bacino e un vaso di bronzo, con basso rilievo.
In una città come Pompei, nella quale, se non al
pari di Ercolano, certo nondimeno in modo non
dubbio le Arti erano in onore, così che ci avvenne
trovarne capolavori nelle più umili dimore, doveva
essere impossibile che gli scavi non ci additassero
magazzeni e studj di scultura; nè è presumere troppo
il pronosticare che pur ne’ futuri sterramenti se ne
troveranno altri.
[414]
La città si risvegliava da quel mortale letargo, in
cui l’aveva gittata il terremuoto del 63, e sgomberando
le rovine e rimettendosi a nuovo, era naturale
che artisti giungessero, chiamati d’ogni dove ed
aprissero studj e botteghe per tanto lavoro.
FINE DEL VOLUME SECONDO.
[415]
| CAPITOLO XII. — I Teatri — Teatro Comico — Passione degli antichi pel teatro — Cause — Istrioni — Teatro Comico od Odeum di Pompei — Descrizione — Cavea, præcinctiones, scalæ, vomitoria — Posti assegnati alle varie classi — Orchestra — Podii o tribune — Scena, proscenio, pulpitum — Il sipario — Chi tirasse il sipario — Postscenium — Capacità dell’Odeum pompejano — Echea o vasi sonori — Tessere d’ingresso al teatro — Origine del nome piccionaja al luogo destinato alla plebe — Se gli spettacoli fossero sempre gratuiti — Origine de’ teatri, teatri di legno, teatri di pietra — Il teatro Comico latino — Origini — Sature e Atellane — Arlecchino e Pulcinella — Riatone, Andronico ed Ennio — Plauto e Terenzio — Giudizio contemporaneo dei poeti comici — Diversi generi di commedia: togatæ, palliatæ, trabeatæ, tunicatæ, tabernariæ — Le commedie di Plauto e di Terenzio materiali di storia — Se in Pompei si recitassero commedie greche — Mimi e Mimiambi — Le maschere, origine e scopo — Introduzione in Roma — Pregiudizj contro le persone da teatro — Leggi teatrali repressive — Dimostrazioni politiche in teatro — Talia musa della Commedia | Pag. 5 |
| |
| CAPITOLO XIII. — I Teatri — Teatro Tragico — Origini del teatro tragico — Tespi ed Eraclide Pontico — Etimologia di tragedia e ragioni del nome — Caratteri — Epigene, Eschilo e Cherillo — Della maschera tragica — L’attor tragico Polo — Venticinque [416] specie di maschere — Maschere trovate in Pompei — Palla o Syrma — Coturno — Istrioni — Accompagnamento musicale — Le tibie e i tibicini — Melpomene, musa della Tragedia — Il teatro tragico in Pompei — L’architetto Martorio Primo — Invenzione del velario — Biasimata in Roma — Ricchissimi velarii di Cesare e di Nerone — Sparsiones o pioggie artificiali in teatro — Adacquamento delle vie — Le lacernæ, o mantelli da teatro — Descrizione del Teatro Tragico — Gli Olconj — Thimele — Aulæum — La Porta regia e le porte hospitalia della scena — Tragici latini: Andronico, Pacuvio, Accio, Nevio, Cassio Severo, Varo, Turanno Graccula, Asinio Pollione — Ovidio tragico — Vario, Lucio Anneo Seneca, Mecenate — Perchè Roma non abbia avuto tragedie — Tragedie greche in Pompei — Tessera teatrale — Attori e Attrici — Batillo, Pilade, Esopo e Roscio — Dionisio — Stipendj esorbitanti — Un manicaretto di perle — Applausi e fischi — La claque, la clique e la Consorteria — Il suggeritore — Se l’Odeo di Pompei fosse attinenza del Gran Teatro | 53 |
| |
| CAPITOLO XIV. — I Teatri — L’Anfiteatro — Introduzione in Italia dei giuochi circensi — Giuochi trojani — Panem et circenses — Un circo romano — Origine romana degli Anfiteatri — Cajo Curione fabbrica il primo in legno — Altro di Giulio Cesare — Statilio Tauro erige il primo di pietra — Il Colosseo — Data dell’Anfiteatro pompejano — Architettura sua — I Pansa — Criptoportico — Arena — Eco — Le iscrizioni del Podio — Prima Cavea — I locarii — Seconda Cavea — Somma Cavea — Cattedre femminili — I Velarii — Porta Libitinense — Lo Spoliario — I cataboli — Il triclinio e il banchetto libero — Corse di cocchi e di cavalli — Giuochi olimpici in Grecia — Quando introdotti in Roma — Le fazioni degli Auriganti — Giuochi Gladiatorj — Ludo Gladiatorio in Pompei — Ludi gladiatorj in Roma — Origine dei Gladiatori — Impiegati nei funerali — Estesi a divertimento — I [417] Gladiatori al lago Fùcino — Gladiatori forzati — Gladiatori volontarj — Giuramento de’ gladiatori auctorati — Lorarii — Classi gladiatorie: secutores, retiarii, myrmillones, thraces, samnites, hoplomachi, essedarii, andabati, dimachæri, laquearii, supposititii, pegmares, meridiani — Gladiatori Cavalieri e Senatori, nani e pigmei, donne e matrone — Il Gladiatore di Ravenna di Halm — Il colpo e il diritto di grazia — Deludiæ — Il Gladiatore morente di Ctesilao e Byron — Lo Spoliario e la Porta Libitinense — Premj ai Gladiatori — Le ambubaje — Le Ludie — I giuochi Floreali e Catone — Naumachie — Le Venationes o caccie — Di quante sorta fossero — Caccia data da Pompeo — Caccie di leoni ed elefanti — Proteste degli elefanti contro la mancata fede — Caccia data da Giulio Cesare — Un elefante funambolo — L’Aquila e il fanciullo — I Bestiarii e le donne bestiariæ — La legge Petronia — Il supplizio di Laureolo — Prostituzione negli anfiteatri — Meretrici appaltatrici di spettacoli — Il Cristianesimo abolisce i ludi gladiatorj — Telemaco monaco — Missilia e Sparsiones | 103 |
| |
| CAPITOLO XV. — Le Terme — Etimologia — Thermæ, Balineæ, Balineum, Lavatrinæ — Uso antico de’ Bagni — Ragioni — Abuso — Bagni pensili — Balineæ più famose — Ricchezze profuse ne’ bagni publici — Estensione delle terme — Edificj contenuti in esse — Terme estive e jemali — Aperte anche di notte — Terme principali — Opere d’arte rinvenute in esse — Terme di Caracalla — Ninfei — Serbatoi e Acquedotti — Agrippa edile — Inservienti alle acque — Publici e privati — Terme in Pompei — Terme di M. Crasso Frugio — Terme publiche e private — Bagni rustici — Terme Stabiane — Palestra e Ginnasio — Ginnasio in Pompei — Bagno degli uomini — Destrictorium — L’Imperatore Adriano nel bagno de’ poveri — Bagni delle donne — Balineum di M. Arrio Diomede — Fontane publiche e private — Provenienza delle acque — Il Sarno e altre acque — Distribuzione per la città — Acquedotti | 183 |
| |
| [418] |
| CAPITOLO XVI. — Le Scuole — Etimologia — Scuola di Verna in Pompei — Scuola di Valentino — Orbilio e la ferula — Storia de’ primordj della coltura in Italia — Numa e Pitagora — Etruria, Magna Grecia e Grecia — Ennio e Andronico — Gioventù romana in Grecia — Orazio e Bruto — Secolo d’oro — Letteratura — Giurisprudenza — Matematiche — Storia naturale — Economia rurale — Geografia — Filosofia romana — Non è vero che fosse ucciditrice di libertà — Biblioteche — Cesare incarica Varrone di una biblioteca publica — Modo di scrivere, volumi, profumazione delle carte — Medicina empirica — Medici e chirurghi — La Casa del Chirurgo in Pompei — Stromenti di chirurgia rinvenuti in essa — Prodotti chimici — Pharmacopolæ, Seplasarii, Sagæ — Fabbrica di prodotti chimici in Pompei — Bottega di Seplasarius — Scuole private | 231 |
| |
| CAPITOLO XVII. — Le Tabernæ — Istinti dei Romani — Soldati per forza — Agricoltori — Poca importanza del commercio coll’estero — Commercio marittimo di Pompei — Commercio marittimo di Roma — Ignoranza della nautica — Commercio d’importazione — Modo di bilancio — Ragioni di decadimento della grandezza romana — Industria — Da chi esercitata — Mensarii ed Argentarii — Usura — Artigiani distinti in categorie — Commercio al minuto — Commercio delle botteghe — Commercio della strada — Fori nundinari o venali — Il Portorium o tassa delle derrate portate al mercato — Le tabernæ e loro costruzione — Institores — Mostre o insegne — Popinæ, thermopolia, cauponæ, œnopolia — Mercanti ambulanti — Cerretani — Grande e piccolo commercio in Pompei — Foro nundinario di Pompei — Tabernæ — Le insegne delle botteghe — Alberghi dì Albino, di Giulio Polibio e Agato Vajo, dell’Elefante o di Sittio e della Via delle Tombe — Thermopolia — Pistrini, Pistores, Siliginari — Plauto, Terenzio, Cleante e Pittaco Re, mugnai — Le mole di Pompei — Pistrini diversi — Paquio Proculo, fornaio, duumviro di giustizia — Ritratto di lui e di sua moglie — Venditorio [419] d’olio — Ganeum — Lattivendolo — Fruttajuolo — Macellai — Myropolium, profumi e profumieri — Tonstrina, o barbieria — Sarti — Magazzeno di tele e di stofe — Lavanderie — La Ninfa Eco — Il Conciapelli — Calzoleria e Selleria — Tintori — Arte Fullonica — Fulloniche di Pompei — Fabbriche di Sapone — Orefici — Fabbri e falegnami — Præfectus fabrorum — Vasaj e vetrai — Vasi vinarj — Salve Lucru | 271 |
| |
| CAPITOLO XVIII. — Belle Arti — Opere sulle Arti in Pompei — Contraffazioni — Aneddoto — Primordj delle Arti in Italia — Architettura etrusca — Architetti romani — Scrittori — Templi — Architettura pompejana — Angustia delle case — Monumenti grandiosi in Roma — Archi — Magnificenza nelle architetture private — Prezzo delle case di Cicerone e di Clodio — Discipline edilizie — Pittura — Pittura architettonica — Taberna o venditorio di colori in Pompei — Discredito delle arti in Roma — Pittura parietaria — A fresco — All’acquarello — All’encausto — Encaustica — Dipinti su tavole, su tela e sul marmo — Pittori romani — Arellio — Accio Prisco — Figure isolate — Ritratti — Pittura di genere: Origine — Dipinti bottegai — Pittura di fiori — Scultura — Prima e seconda maniera di statuaria in Etruria — Maniera greca — Prima scultura romana — Esposizione d’oggetti d’arte — Colonne — Statue, tripodaneæ, sigillæ — Immagini de’ maggiori — Artisti greci in Roma — Cajo Verre — Sue rapine — La Glittica — La scultura al tempo dell’Impero — In Ercolano e Pompei — Opere principali — I Busti — Gemme pompejane — Del Musaico — Sua origine e progresso — Pavimentum barbaricum, tesselatum, vermiculatum — Opus signinum — Musivum opus — Asarota — Introduzione del musaico in Roma — Principali musaici pompejani — I Musaici della Casa del Fauno — Il Leone — La Battaglia di Isso — Ragioni perchè si dichiari così il soggetto — A chi appartenga la composizione — Studj di scultura in Pompei | 345 |
Nota del Trascrittore
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione
minimi errori tipografici.
Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.